L'editoriale di ateatro 86
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and1
Il mio Pasolini
Una conversazione con Luca Ronconi
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and7
L'ospite Pasolini
Una conversazione con Daniela Niccolò su Pasolini, L'ospite & altro
di Andrea Lanini
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and8
Le recensioni di ateatro: Diario privato
Léautaud secondo Ronconi
di Andrea Balzola
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and10
Le recensioni di ateatro: Mishelle di Sant'Oliva
Il nuovo spettacolo di Emma Dante
di Valeria Ravera
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro85.htm#86and11
Le recensioni di ateatro: La crociata dei bambini
I Sacchi di Sabbia a Castiglioncello
di Erica Magris
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and12
Le recensioni di ateatro: Shot – Foibe
Al Mittelfest le foibe secondo Renato Sarti con Bebo Storti e Tanja Pecar
di Ferdinando Marchiori
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and13
Santarcangelo haiku
Qualche spettacolo dal festival 2005
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and15
Passaggio in Iran: 22° Festival Internazionale di Teatro FADJR Teheran, 23 gennaio-2 febbraio 2004
Censura e censori nel teatro iraniano
di Mimma Gallina
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and30
La confessione cinematografica di un fan di Alfred Hitchcock
Costanti tematiche e motivi teatrali nel cinema di Robert Lepage: il caso Le confessionnal
di Sara Russo
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and48
Possiamo fare dei robot, possiamo creare la vita
Incontro (doppio) con Marcel.lì Antunez Roca
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and50
Arte contemporanea allo scoperto
J. Fabre, The Shelter (For the Grave of the Unknown Computer); O. Mocellin e N. Pellegrini, Le cose non sono quelle che sembrano
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and52
Factory a luci rosse
Tutto quello che avreste voluto sapere sulla Factory di Andy Warhol di Mary Woronov (Meridianozero)
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and66
E' scomparsa Valeria Moriconi
Una delle ultime primedonne del nostro teatro
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and80
Il Premio Tuttoteatro.com 2005: il bando
Scandenza: 26 agosto
di Tuttoteatro.com
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and81
La motivazione del Premio Hystrio Altre Muse a www.ateatro.it
E c'è anche la foto...
di Redazione ateatro
Nominato il nuovo Direttore Artistico del Festival di Santarcangelo dei Teatri
Il comunicato
di Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Santarcangelo dei Teatri
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro85.htm#86and83
La drammatica scomparsa di Giampiero Bianchi
Ottimo attore in teatro, era stato tra i protagonisti di Incantesimo
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and84
In libreria Le vie dei festival
A 7 euro nelle librerie Feltrinelli per tutta l'estate
di Associazione CADMO
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and85
"Hystrio" 03/05 con un dossier Pasolini
Il sommario del numero
di Redazione "Hystrio"
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro86.htm#86and86
Vi stupite se premiano ateatro? Leggete il numero 86!
L'editoriale di ateatro 86
di Redazione ateatro
Buonepratiche2
Ve l’avevamo promesso, e cerchiamo di mantenere. Insomma, stiamo organizzando la seconda tornata delle Buone Pratiche. O meglio, visto che siamo megalomani, abbiamo deciso di raddoppiare. Tra novembre e dicembre, ateatro organizza due incontri.
Il primo incontro cercherà di offrire una riflessione sul teatro pubblico, oggi. Ovvero, perché mai il potere pubblico, nelle sue varie articolazioni, dalla comunità europea agli enti locali, e magari anche i privati, devono finanziare la cultura, e in particolare il teatro? In altri termini, a che cosa serve oggi il teatro? A chi serve il teatro? Ovviamente una domanda del genere invoca anche una serie di indicazioni sulle modalità e i destinatari delle sovvenzioni. Chiameremo a discutere della questioncella i teatranti, gli studiosi, i legislatori, i rappresentanti degli enti pubblici, ma anche economisti, filosofi, storici, sorici dell’arte, sociologi, imprenditori, per provare ad affrontare la questione dalle fondamenta, e vedere a che punto siamo.
L’altro round, a Brindisi, affronterà la questione meridionale. Ovvero la disparità (dall’attività alle infrastrutture alle sovvenzioni, eccetera) tra il nord e il sud del paese anche in campo teatrale. E’ una storia lunga, da un lato, di cui sarà interessante ricostruire le stratificazioni. Ma dall’altro, in uno scenario assai vitale, la riflessione apre una serie di prospettive di notevole interesse per il futuro.
Insomma, l’impertinente ateatro – imbaldanzito dal successo delle Buone pratiche – insiste e rilancia. Come sapete, siamo piccoli, poveri, indipendenti e liberi. Di sicuro non toccherebbe a noi mettere sul piatto temi così “pesanti”. Tuttavia ci sembra necessario rilanciare la discussione sul teatro italiano e sui suoi assetti in maniera insieme provocatoria e costruttiva (speriamo…).
Nel prossimo numero (fine agosto-primi di settembre) pubblicheremo i due documenti preparatori degli incontri, e come al solito cercheremo di pubblicare in anteprima suggerimenti, indicazioni, materiali & altro.
Dopo di che, questo ateatro 86 è, come al solito fin troppo ricco di informazioni, pensieri, suggestioni.
Il nuovo enfant prodige della scena teatrale è un iraniano? Parliamo del suo spettacolo Amid the Clouds, visto da molti a Parigi o a Santarcangelo, ma vi regaliamo anche un reportage esclusivo sul miglior censore del teatro iraniano (gli danno anche il premio…).
Poi un’apertura del trentennale pasoliniano, con due interviste ai Motus e a Luca Ronconi (che nel frattempo ha messo in scena Diario privato con l’eterna coppia Proclemer-Albertazzi). Ancora, gironzolando tra i festival, le recensioni dei nuovi lavori di Emma Dante, Renato Sarti-Bebo Storti, Sacchi di Sabbia, Fanny & Alexander. E ancora nella sezione tnm un dossier su Marcel.lí Antúnez Roca oltre i confini dell’umano, un viaggio all’incrocio tra cinema e teatro con Robert Lepage, l’installazione di Jan Fabre a Montemarcello… Infine, immancabili, le news, che cerchremo di tenere aggirnate anche in questo assolato (speriamo) agosto.
E vi stupite se premiano ateatro?
Il mio Pasolini
Una conversazione con Luca Ronconi
di Oliviero Ponte di Pino
Luca Ronconi ha ormai una teatrografia vastissima, con decine e decine di testi allestiti nel corso di un quarantennio. A Pier Paolo Pasolini è tornato in diverse occasioni, a cominciare dalla metà degli anni Settanta, quando portò in scena al Laboratorio di Prato il Calderón.
Calderón faceva parte di una trilogia che partiva dalla Vita è sogno.
Curiosamente si dice che Pasolini abbia deciso di scrivere Calderón dopo aver visto Il principe Costante di Grotowski, un’altra variazione sul tema della Vita è sogno…
Poi, all’inizio degli anni Novanta, ho messo in scena a Torino tre testi - Affabulazione, di nuovo Calderón e Pilade - proprio perché erano passati quasi vent’anni. Nel ’75 avevo lavorato su tre testi in cui la rivolta era al centro, in vari modi – nel testo di Pasolini si parla del ’68, nella Vita è sogno la rivolta diventa un problema metafisico, e La Torre di Hoffmansthal è a metà tra questi due aspetti. Nel ’90 gli spiriti rivoluzionari si erano abbastanza assopiti, anche nei giovani: così ho voluto lavorare su quei testi per vedere se e come l’eco di situazioni storiche e di temperature non conosciute direttamente potesse essere recuperata attraverso la mediazione teatrale. Devo dire che la risposta è stata positiva, perché i ragazzi si sono veramente appassionati.
Tra le numerose regie che hai firmato, gli autori italiani contemporanei sono molto rari. Proprio per questo la tua attenzione per Pasolini è ancora più significativa.
Contemporaneo non è solamente chi scrive in un determinato periodo, ma chi appartiene alla cultura di quel determinato periodo, in quel determinato paese. Un drammaturgo italiano degli anni Trenta che copia le commedie del boulevard francese non è un drammaturgo italiano, ma un imitatore di cose che hanno una loro contemporaneità nel loro luogo d’origine. Quindi non tutti quelli che scrivono teatro oggi in Italia sono autori italiani contemporanei. Il che non vuol dire che non ce ne siano, anzi. L’altro problema è che la maggior parte degli autori italiani contemporanei sono anche attori: si scrivono i loro testi, e spesso sono interessantissimi.
Autori-attori come Eduardo e Fo, che non a caso Pasolini cita nel suo Manifesto per un nuovo teatro.
Ma penso anche a Fausto Paravidino, a Davide Enia, a Scipione e Sframeli: non sto parlando di esperienze minori, ma di cose importanti. Non è un problema generazionale, è un fatto permanente del teatro italiano. Ma fino al momento in cui quei testi non diventano classici, l’attore che li ha scritti per sé ha un’ipoteca molto forte sulla propria opera. Questo nel caso di Pasolini non avviene. Inoltre Pasolini appartiene contemporaneamente al teatro e alla letteratura, e anche questo è un vantaggio: perché è un letterato che in quanto tale condivide il disprezzo dei letterati per il teatro così com’è. Poi, in quanto uomo di teatro scrive testi estremamente importanti, materiali che però hanno la necessità di una mediazione. Anche se come ho detto i motivi per cui di volta in volta l’ho portato in scena sono stati diversi, più specifici, contingenti, oggi, a posteriori, dopo aver fatto quasi tutto Pasolini, e più volte, posso dire che questi sono i motivi per cui l’ho portato in scena.
Anche Giovanni Raboni, un paio d’anni fa, notava che i testi teatrali più interessanti, in questi anni, li hanno scritti dei letterati, non dei drammaturghi professionisti. Anche perché sono più liberi rispetto alle forme e alle convenzioni del teatro. Citava, per esempio, Giovanni Testori e Mario Luzi.
Rosales di Luzi è un testo che mi interessa. Testori, ho pensato di metterlo in scena un paio di volte, La monaca di Monza l’avrei messa in scena volentieri.
Anche perché è un testo che ha bisogno di una forte mediazione registica…
Ai miei esordi avrei dovuto fare la regia della prima edizione: eravamo un gruppo di attori, i più giovani eravamo Sergio Fantoni, Valentina Fortunato e io. Poi c’era Lilla Brignone, che però aveva la volontà – comprensibile – e l’impegno di farla con Visconti… Anche alla fine se non fu un grande risultato. Molti dei testi successivi di Testori sono invece dei monologhi, e io non amo i monologhi.
Però in reatà nel teatro di Pasolini i monologhi hanno un ruolo fondamentale, sono quasi la struttura portante del suo teatro…
Ma lo sono anche nel teatro di Shakespeare! Però il teatro di Pasolini è molto spesso autobiografico… Nella sua opera l’io monologante spesso si sdoppia, si triplica, eccetera. Per esempio, già nella prima commedia che ha scritto, Storia interiore, ma anche in Petrolio. Anche Pilade e Oreste sono due facce della stessa persona: dicono dei monologhi, ma c’è sempre una dialettica e un conflitto tra i due aspetti della stessa personalità. Questo dà spessore e interesse – oltre che ambiguità – ai testi pasoliniani. Anche nel Calderón, non sai mai in quante figure si proietti l’autore.
Ci sono due mondi in cui può essere declinato il rapporto con la biografia. C’è quello che hai indicato tu. Ma è anche possibile ricondurre l’opera al vissuto dell’autore, alle sue esperienze e vicissitudini. E intorno alla biografia di Pasolini è sorta una vera e propria mitologia.
Gli aspetti della vita privata di Pasolini appartengono a lui. Non lo dico per delicatezza o per rispetto, ma è sbagliato elevarli a criterio interpretativo. Un’esperienza anche eccessiva è per chi la vive un’esperienza assolutamente normale, naturale. Usare la biografia come criterio interpretativo mi sembra un atteggiamento molto grossolano, sarebbe come leggere La ricerca del tempo perduto per fare la psicoanalisi di Proust. Ma figuriamoci, a chi può interessare?
Un altro dei motivi d’interesse del teatro di Pasolini riguarda la lingua.
Qurell’impasto di passionalità e di retorica che c’è nella sua scrittura teatrale, e che ha dato tanto fastidio ai suoi colleghi letterati, è un ottimo materiale per essere messo in voce, per essere somatizzato.
Pasolini scrive le sue tragedie in un arco di tempo molto ristretto e in una fase molto precisa della storia del teatro italiano. Sono anche gli anni dei tuoi primi grandi spettacoli. La scrittura di Pasolini e tue regie sono due risposte a quella crisi…
In quel momento, per pochissimi anni, il teatro è stato un veicolo interpretativo estremamente forte.
Dopo un periodo di crisi e di apparente isterilimento, è come se si fosse aperta una diga. E come sempre, quando si aprono le dighe, vengono distrutte le catapecchie ma anche delle cose pregevoli: aver buttato via tutto non è stata una cosa proficua. Nel caso di Pasolini, l’interesse per il teatro è venuto anche perché in quegli anni, fra il ‘65 e il ’70, ci furono delle vere esplosioni.
Sono gli anni in cui arrivano in Italia il Living Theatre e il Teatr Laboratorium di Grotowski, e con Carmelo Bene nasce l’avanguardia teatrale italiana… A questa situazione, Pasolini dà una serie di riposte: quello che scrive sul teatro in ambito giornalistico, naturalmente le sue tragedie, e poi il Manifesto per un nuovo teatro, e la regia di Orgia allo Stabile di Torino. Sono risposte molto articolate…
Più che articolate, contraddittorie. Le tragedie sono importanti, e restano. Il Manifesto, riletto con il senno di poi - ma forse anche prevedendolo con il senno di allora - è velleitario. Quella che lui ritiene essere la vera funzione del teatro, non può essere quella che indica lui…
Nel Manifesto Pasolini contrappone il suo teatro di parola da un lato al teatro borghese della chiacchiera, e dall’altro al “teatro dell’urlo”, cioè del gesto e del corpo, delle varie avanguardie. Insomma, per il recupero di una funzione civile, politica del teatro.
Ma su questo siamo tutti d’accordo. Il problema è che pensava che parola e teatralità siano due termini antitetici. Non lo sono. Sono complementari. Questa è l’impasse di quel Manifesto. Tanto è vero che quando ha voluto dare con la messinscena di Orgia un’esemplificazione di quel tipo di teatro, è stato un vero disastro. Non solo un disastro rispetto al pubblico, anche se comprensibilmente quelle élite operaie che lui sperava assistessero allo spettacolo se ne fregavano. Ma è stato un esperimento snobistico, e recepito come tale, senza nessun tipo di comunicazione, uno spettacolo totalmente inerte. Pensare che la sillabazione di un testo – eliminando quella che è la mediazione dell’attore – possa essere sufficiente, pensare che possa esserci una comunicazione diretta dal palcoscenico alla platea, è assurdo. La comunicazione è sempre trasversale, obliqua. Altrimenti ricadi in un didascalismo piattissimo. Certo, lo si può fare, ma non con i testi di Pasolini, che sono pieni di ambiguità e di reticenze.
Anche se per altri aspetti la sua è una scrittura profondamente esibizionistica…
…e allo stesso tempo reticente. E’ il fascino dei suoi testi. E’ impossibile leggerli piattamente. Perché proprio il carattere nascosto, non voluto, di un testo, quello che sfugge all’autore perché grazie a dio è un grande autore, è quella la matrice che genera la rappresentazione.
Dopo la regia di Orgia, Pasolini si disamora del teatro. Anche se a muovere sia te sia lui era forse una consapevolezza comune: che l’ipotesi nazional-popolare, quella da cui erano nati i teatri stabili, non funzionava più, o almeno non poteva più funzionare allo stesso modo.
In forme diverse, ci siamo abbastanza ritrovati, ma è anche vero che Pasolini rifiutava tutto quello che c’era.
Aveva e voleva avere una funzione provocatoria e pedagica nei confronti del sistema culturale – e dunque anche teatrale - di quegli anni.
Il problema è che il teatro non lo conosceva, non ci andava. Se invece di pensare al teatro come a un rito borghese, con l’odio che aveva per la borghesia, l’avesse pensato come a un rito aristocratico, come di fatto era, lo avrebbe odiato di meno.
L'ospite Pasolini
Una conversazione con Daniela Niccolò su Pasolini, L'ospite & altro
di Andrea Lanini
Quando Pier Paolo Pasolini decise di raccontare attraverso il corpo degli attori il lento disgregarsi delle certezze e delle ipocrisie dell’interno borghese di Teorema, ingranaggio spietatamente cinico destinato a fagocitare l’ego della “buona famiglia” italiana, pensò di girare un film: il suo teatro di parola sarebbe probabilmente risultato inadatto a esprimere il vuoto e i lunghi silenzi di un romanzo che progrediva sullo sbriciolamento della conversazione, su un dialogo che diventa vittima e specchio dell’aridità spirituale di quel microcosmo che il poeta friulano identificava con la borghesia. L’incontro tra il teatro e la complessità dell’opera pasoliniana sono avvenuti attraverso l’arte dei Motus, compagnia simbolo di una straordinaria stagione dello spettacolo italiano legata alla “Romagna felix” e all’esplosione creativa dei gruppi degli anni Novanta, e da più di un decennio autrice di lavori che sono costantemente ospitati dai festival più importanti del mondo: il loro ultimo spettacolo, L’Ospite, è il risultato di un percorso d’indagine della poetica e della multiforme espressività di Pasolini iniziato nel 2002, e che oggi vive di una compenetrazione affascinante tra la cifra stilistica della loro produzione e quella dello scrittore-regista-drammaturgo. In un teatro che mira alla resa di una rappresentazione filtrata attraverso il linguaggio del cinema, in un luogo scenico che abolisce definitivamente la sua natura di decoro per farsi autarchico mondo da vivere e percepire attraverso la commistione dei media, l’atmosfera di Teorema diventa il territorio ideale per mostrare al pubblico la creazione di una tipologia nuova d’attore, il cui potere comunicativo non è più delegato alla parola ma ad un flusso di pensiero e coscienza che si estrinseca attraverso le arti digitali, il video, il primo piano, il montaggio in scena: la tecnologia più avanzata diventa così tramite per la narrazione di un urlo originario, di un moto di rivolta che Pasolini incarnò nelle vesti di uno sconosciuto ed enigmatico ospite e nella violenza delle sue verità. Abbiamo chiesto a Daniela Nicolò (assieme ad Enrico Casagrande fondatrice e anima creativa della compagnia) di parlarci del suo rapporto con Pasolini, da sempre costante punto di riferimento per i Motus.

Pasolini cercò costantemente di sperimentare nuovi mezzi espressivi: questo desiderio di tentare vie sempre nuove – caratteristica che lo rende molto vicino ad un tipo di percorso come il vostro – lo ha talvolta circondato di incomprensione e dissenso, facendo apparire la sua opera contraddittoria, impenetrabile, sconcertante. Quale è, e quale è stato, il vostro rapporto con Pasolini autore, con le sue scelte artistiche?
Pasolini è stato a lungo un autore controverso anche per noi: ci sono stati degli aspetti del suo lavoro che per molto tempo non abbiamo amato, e che probabilmente solo oggi abbiamo imparato ad apprezzare e capire, durante questo lungo periodo di studio e di ricerca sulla sua opera. Il nostro avvicinamento al suo universo creativo è stato difficile, pieno di contraddizioni: abbiamo sempre avuto un grandissimo rispetto per la sua capacità di attraversare e utilizzare le varie forme dell’espressione – poesia, letteratura, cinema, pittura -, per il suo impegno politico. Trovare oggi un artista che riesce a lavorare così a tutto tondo è veramente difficile: oggi ognuno è troppo chiuso nel suo mondo espressivo. Una delle grandi lezioni di Pasolini è stata quella di dare dimostrazione di una possibilità straordinaria di spaziare da un campo all’altro, di attraversare gli ambiti artistici mantenendo inalterata la capacità di essere sempre originale. Ci ha veramente colpito il suo arrivare al cinema così tardi e arrivarci con questa carica di novità nel linguaggio. La nostra esigenza di superare i nostri stessi limiti e i nostri codici, il nostro desiderio di sorpassare il già acquisito sono sicuramente un punto di contatto con lui. Anche il nostro lavoro, come il suo, cerca da sempre numerose affinità con vari ambiti artistici come la letteratura, il cinema, le arti visive, la musica. Questa apertura di campo entra inevitabilmente nel nostro teatro. Credo che ci avvicini a lui anche un’urgenza forte di rivolgerci e di rivolgere lo sguardo sul contemporaneo, sulla quotidianità: anche se Pier Paolo Pasolini è stato sicuramente molto più efficace di noi, perché aveva una presenza continua sui mezzi di comunicazione di massa. I suoi erano anche anni diversi: c’era un impegno politico molto più evidente; da parte nostra c’è un’intenzione di raccontare il contemporaneo, ma ovviamente non con l’impegno politico che aveva lui.

Dei tanti aspetti che caratterizzano questo autore, quale è secondo te quello che oggi dimostra la sua maggior forza?
Credo che sia proprio quello che, qualche anno fa, sembrava pagare un eccesso di retorica: la critica ai mezzi di comunicazione di massa, e in particolare l’intervento che portò avanti direttamente contro il mezzo televisivo. Solo dieci - quindici anni fa io stessa giudicavo quella presa di posizione così dura un po’eccessiva, fin troppo retorica. Ma vedendo ciò che la tv è diventata, in Italia e non solo, osservando l’abbrutimento dei media e il livellamento dei programmi delle reti pubbliche e private, non si può che dire che aveva ragione lui, e che il suo sguardo era riuscito a percepire i segnali di ciò che sarebbe successo. E pensare che la tv che Pasolini criticava noi oggi ce la sognamo: era una tv che poteva spesso permettersi programmi anche molto interessanti. In questo è stato profetico. Negli ultimi anni la cultura del nostro Paese ha subito un tracollo generale un po’ su tutti i livelli. La nostra esigenza è stata proprio quella di recuperare questo Pasolini, il Pasolini degli ultimi anni, quello che si occupa soprattutto della borghesia.

E per scardinare le dinamiche borghesi Pasolini fa arrivare questo misterioso “ospite”…
Certo. Il nostro lavoro parte essenzialmente dal romanzo: tutti conoscono il film, ma per molti aspetti il romanzo è superiore, un’opera assolutamente straordinaria. Il film e il romanzo offrono angolazioni e punti di vista sul suo pensiero anche lontani: nello spettacolo abbiamo cercato di coniugare la parola scritta (un tipo di scrittura matematica, analitica) con ciò che Pasolini ha raccontato attraverso il grande schermo. Utilizzando dei mezzi espressivi che a quel tempo non esistevano: il teatro di Pasolini era un teatro molto legato alla parola. La nostra contaminazione e la nostra tecnologia hanno reso possibile la convivenza tra immagine, silenzio, parola scritta. Lo spettacolo crea un ambiente che riesce a far convivere questi due territori, universi lontani provenienti dal film e dal romanzo. Ti confesso che per me le cose migliori di Pasolini non vanno cercate nel teatro, anche se alcune cose che lui ha scritto per il palcoscenico sono molto belle. Io amo molto di più il Pasolini romanziere e narratore.

Il tema del deserto è un fil rouge che attraversa tutto il vostro spettacolo e che è presente anche nelle vostre passate produzioni - in “Rooms” apparivano le immagini dei deserti americani arricchite dalle suggestioni provenienti da De Lillo e dal “rumore bianco” -, e al contempo è un topos dell’opera e della poetica di Pasolini…
I deserti sono i luoghi a cui siamo più intimamente legati. Sono il posto più adatto per mettersi in gioco. In Teorema ci sono delle pagine bellissime dedicate all’attraversamento del deserto, e per il nostro spettacolo abbiamo girato molte immagini dedicate a questo luogo speciale che spesso è la meta preferita dei nostri viaggi. Anche Pasolini, appena aveva un po’ di tempo, si rifugiava nei deserti di Africa e India: per lui rappresentavano l’universo ideale per lanciare l’urlo definitivo, per incontrare la dimensione del sacro. In Pasolini il rapporto col sacro è molto forte, mentre in noi questa ricerca è più velata. Noi non siamo credenti, e non credente era anche Pasolini, ma in lui questa contraddizione tra il non credere e il bisogno di ricercare la dimensione del sacro era probabilmente più forte. E il deserto è il luogo del mondo in cui senti più forte il bisogno di porti questa domanda, di riflettere sul tuo rapporto con la religione.
Uno dei dati più evidenti dell’Ospite è un inequivocabile cambio di rotta rispetto alla vostra produzione precedente: la leggerezza e l’autoironia che caratterizzavano anche i momenti più intensi e aspri dei vostri spettacoli lasciano il posto ad una disperazione che sembra senza speranza, ad un atmosfera plumbea che vive della mancanza di qualsiasi possibile via di fuga…
Con L’ospite abbiamo toccato temi per noi molto forti, molto drammatici. E’ vero che c’è un’importante svolta, in questo spettacolo: direi che questo è il primo lavoro in cui l’ironia scompare del tutto. Quello che in questa occasione presentiamo al pubblico è uno sguardo disperato, e non poteva essere altrimenti, perché L’ospite è il frutto di una lunga sofferenza : per noi è stato molto difficile arrivare a trovare una strada per mettere in scena quelle parole, quell’esasperazione che Pasolini lascia trasparire dal suo testo. La svolta deriva da qui, la scomparsa di qualsiasi componente ironica parte da questo dato di fatto. Questa dimensione più cupa riflette anche il momento molto difficile che chi fa teatro si trova ad affrontare in questi anni: la situazione, in generale, è veramente preoccupante.
Anche lo stato attuale delle cose trova spazio nell’indagine che lo spettacolo propone: ci sono delle domande che, partendo da una riflessione sugli anni di piombo, finiscono inevitabilmente per centrare le problematiche del momento che stiamo vivendo. Il riflettere sui nostri giorni dà origine ad un’inquietudine eloquente…
La domanda politica dello spettacolo è molto forte, ed è diretta alla nostra quotidianità, pur partendo dai fatti politici degli anni Settanta. In quel periodo è iniziata una discesa che non si è più interrotta, e Pasolini aveva previsto ciò che oggi si sta realizzando. Nel romanzo queste domande politiche ci sono, ma noi nello spettacolo ci siamo spinti oltre: non ci siamo fermati a quegli anni, ma abbiamo diretto lo sguardo su quanto sta accadendo oggi. Per notare che se al tempo di Teorema sembrava esserci ancora un barlume di speranza, quella speranza sembra oggi scomparsa del tutto: nella nostra visione anche quei tenui bagliori tendono a spegnersi.
Quali sono le reazioni del pubblico a questo nuovo sguardo dei Motus?
Abbiamo verificato che il pubblico rimane molto toccato da questo nuovo punto di vista che lo spettacolo propone, il dolore di questa presa di coscienza arriva molto: la gente percepisce subito che L’ospite è una cosa molto diversa da quelle che abbiamo proposto in passato.
Pensi che si possa considerare attraversata una linea di non ritorno? Non penso che un’esperienza così sofferta e radicale si lascerà facilmente accantonare, in futuro…
Assolutamente. Le acquisizioni provenienti da questo nuovo percorso continueranno a far sentire la loro presenza: posso dirti che abbiamo già deciso di continuare a lavorare su Pasolini. Anche nel nostro nuovo progetto, Piccoli episodi di fascismo quotidiano, continuiamo ad osservare un passato molto recente per capire meglio l’oggi. Per noi però è anche importante recuperare una certa leggerezza che comunque è nostra: in Piccoli episodi l’ironia tornerà a farsi sentire, ma sarà cattiva, molto cattiva!.
L’ospite ha debuttato in Francia: qual è stata la reazione del pubblico?
In Francia la reazione è stata molto bella: abbiamo scoperto che lì Pasolini è amatissimo e, soprattutto, conosciutissimo. Tante persone ci hanno avvicinato per farci domande che dimostravano una preparazione sbalorditiva sulla sua opera…
Quali sono le prossime tappe dell’Ospite?
In autunno lo porteremo in Germania, e poi, speriamo, in Canada, paese con cui si è avviato un bellissimo discorso. In Canada abbiamo fatto Twin rooms, che è uno spettacolo sulla cultura americana: devo dire che Twin rooms è stato capito molto di più in Canada – paese molto antiamericano (eravamo in Québec) – che in Italia; là hanno avvertito molto di più le tematiche che abbiamo deciso di affrontare, le critiche a certi aspetti della società degli Stati Uniti che autori come De Lillo attaccano spesso nei loro libri.
C’è un pubblico che preferite in assoluto?
Direi quello dei paesi dell’Est europeo. Per quella gente andare a teatro è una cosa importantissima, che fa veramente parte della vita: i teatri sono sempre strapieni, è una cosa bellissima. E questo grande interesse è dimostrato anche dall’attenzione che i media dedicano al teatro, alle compagnie, agli autori.
Vogliamo parlare della situazione attuale del teatro italiano?
Devo dirti che sono molto pessimista, in questo momento. Attraversiamo una fase estremamente difficile: i gruppi vivi, quelli che continuano a proporre cose nuove e che in qualche modo “resistono”, hanno davanti a loro una strada che è sempre più in salita. Lavorare in Italia facendo un certo tipo di percorso – un percorso indipendente dai grandi stabili che con i loro scambi stanno monopolizzando tutto, un cammino che cerca una sua originalità e autonomia – è sempre più difficile. Credo si possa dire che questo sia il periodo peggiore che abbiamo mai attraversato: i circuiti sono sempre più chiusi, e sono pochissimi i teatri che trovano il coraggio di ospitare produzioni di un certo tipo. Noi abbiamo fatto lo spettacolo a Cascina (L’ospite è andato in scena a “LaCittàdelTeatro” di Cascina lo scorso 23 aprile, Ndr) proprio perché il direttore, Sandro Garzella, ha voluto fortemente questa cosa. Il problema non è quello del pubblico: al “Rossini” di Pesaro abbiamo fatto due repliche con L’ospite che hanno registrato il tutto esaurito, e sono state le date con il maggior numero di spettatori di tutta la stagione di prosa. Il problema riguarda la volontà di chi deve decidere, e questa volontà diventa politica nel momento in cui si decide di non far passare un certo tipo di spettacolo. In Italia L’ospite non riesce a girare: noi stiamo sopravvivendo grazie ai contatti che abbiamo con l’estero. Se fosse per i risultati che abbiamo in Italia, avremmo dovuto smettere da tempo, anche se poi non lo facciamo mai perché non riusciamo a rinunciare al nostro lavoro. Dovremo lavorare su progetti più piccoli, in futuro. In realtà è tutto molto triste. Da tempo stiamo valutando l’ipotesi di andarcene definitivamente dal nostro paese. La speranza è quella di trovare la forza di poter resistere facendo qualcosa insieme agli altri gruppi. I Motus hanno raggiunto un certo livello allargando la compagnia, dando lavoro a delle persone: la prospettiva di dover tornare indietro è sconfortante, e non è una questione di orgoglio. E’ la volontà di non voler accettare delle logiche che ti impediscono di fare quel tipo di lavoro che la tua passione e la tua volontà sanno di poter portare avanti.
Le recensioni di ateatro: Diario privato
Léautaud secondo Ronconi
di Andrea Balzola
Da tempo ormai Ronconi ha scelto un “teatro delle idee” , dove testi teatrali poco noti, quasi mai rappresentati oppure, ancor più, testi non teatrali, di tipo scientifico o di matrice letteraria, molto lontani dalla drammaturgia scenica, suscitano la sua attenzione e orientano le sue scelte (e sfide) registiche.

Anche in questo caso, dove Ronconi ha a disposizione una celebre coppia di mattatori della scena italiana più “stabile”, come Giorgio Albertazzi e Anna Proclemer, coadiuvati da un’altra ottima attrice a lui cara, Paola Bacci, la sua scelta è stata sorprendente e spiazzante. Riesumare dalle impolverate biblioteche un autore francese pressoché sconosciuto al grande pubblico, Paul Léautaud (Parigi 1872-1956) di professione critico teatrale (anche questo rivela una punta di ironica malizia del regista) per la prestigiosa rivista “Mercure de France” e autore di un diario logorroico e in alcune sue parti “osceno” – il Journal Littéraire – depositato in ben diciannove volumi. Ronconi ha affidato a Raffaele La Capria la riduzione e l’adattamento drammaturgico di un estratto di 400 pagine del Diario di Léautaud, tradotto e pubblicato in Italia nel lontano 1968. L’operazione di forbice è radicale ma nello stesso tempo legittimata dal carattere non strutturato del racconto diaristico, minuzioso all’eccesso, anche nella descrizione delle relazioni erotiche tra lo scrittore e la sua amante, Anne Cayssac, donna borghese sposata e come Léautaud soccorritrice instancabile di animali randagi. Una passione per gli animali che unisce il misantropo critico e, come la chiama lui, il suo “Flagello”, e che nell’interpretazione di Ronconi-La Capria diventa anche metafora ironica di una animalesca passione erotica. Se è sempre il conflitto a generare la tensione drammatica, qui, nella noia della cronaca quotidiana di una moderatamente eccentrica vita borghese, appena movimentata dall’assistenza agli animali (“ho avuto perlomeno trecento gatti e cinquanta gatti” ricorda Léautaud), l’anima drammaturgica è il contrasto tra il reciproco detestarsi dei due amanti e la loro irresistibile attrazione sessuale. Così, nella versione presentata in prima nazionale al Teatro Argentina di Roma, tutto si svolge nell’arco temporale della ventennale relazione tra Paul e Anne (dal 1914 al 1934) e in un unico ambiente borghese, che però mescola lo studio dello scrittore con l’appartamento di lei e del marito, il quale è spesso presente in scena nei panni di un pianista totalmente ignaro ed estraneo (il musicista Maurizio Aschelter, che esegue dal vivo le musiche di Paolo Terni). Un microcosmo dove non sembrano trapelare gli eventi drammatici, (guerre, rivoluzioni e dittature) che in quegli anni scuotevano la Francia e l’Europa, tutto è riconducibile a un’impenetrabile sfera privata dove i due protagonisti sembrano essere gli unici esseri umani rimasti al mondo, qualche cenno riguarda soltanto i commercianti che forniscono il cibo per gli animali.
Ma la vera, geniale, chiave di volta registica e simbolica, è quella di far recitare per tutto lo spettacolo i due protagonisti seduti su due grandi poltrone telecomandate, che si incrociano, si allontanano, si accostano e si aggirano, come in una sorta di caustico e paradossale valzer da salotto. Nella frenesia erotica degli amanti è così svelata l'ombra di un'impotenza al contatto vero, a una relazione intima reale. Il dialogo di Paul e Anne, ricomposto da una raffinata tessitura drammaturgica, si dipana in un linguaggio monotono fatto di piccoli battibecchi e pettegolezzi domestici nel quale irrompe il veleno della reciproca insofferenza e la cronaca oscena e dettagliata dell’atto sessuale. Una sessualità spogliata di sentimento, raffreddata da Ronconi mediante una modalità "sterilizzatrice" che ne fa la versione porno della chiacchiera salottiera. Qui l’anticonformismo ostentato da Léautaud - “Sono considerato un sovversivo, un immorale che oltraggia tutto. In realtà dico al massimo un quarto di ciò che so” - si rovescia in una consuetudine di ordinaria anormalità. Sull’intelligenza del montaggio testuale s’innesta la prova virtuosistica di Albertazzi-Proclemer, che modula con straordinaria disinvoltura continue varianti su una coazione a ripetere di dialoghi vuoti e di coiti dialogati. Un contorcimento fisico e verbale che scorre su un movimento continuo e senza meta, che riesce a movimentare in modo sorprendente un diario compilatorio e che fa anche ridere il pubblico, ma è un riso che alla fine lascia l’amaro in bocca, il retrogusto è la sensazione dell’aridità di un approccio esclusivamente mentale – in questo caso letterario - alla relazione umana e sessuale. Come se l’ordine del discorso – per dirla con Foucault – filtrasse tramite la parola o l’immagine l’energia vitale dell’attrazione sessuale e rivestisse come maschera posticcia un’impura animalità, un istinto inarrestabile e nello stesso tempo insensibile (perciò anche privo di “senso”). Segno dei nostri “virtuali” tempi attuali e conferma della puntualità di Ronconi nel saper parlare sempre al presente attingendo al passato, nel riflettere la realtà attraverso lo specchio della metafora teatrale o letteraria.
Diario privato
Da Journal Littéraire di Paul Léautaud,
riduzione di Raffaele La Capria,
con Giorgio Albertazzi, Anna Proclemer, Paola Bacci
scene di Marco Rossi, costumi di Gianluca Sbicca e Simone Valsecchi,
luci di Guido Levi, musiche a cura di Paolo Terni,
al pianoforte Maurizio Aschelter, aiuto regia Emiliano Bronzino, Simone Toni,
regia di Luca Ronconi
Le recensioni di ateatro: Mishelle di Sant'Oliva
Il nuovo spettacolo di Emma Dante
di Valeria Ravera
Un gomitolo da avvolgere, braccia che si levano e si abbassano a facilitare il dipanarsi della lana, un filo che unisce due persone, morbido a tratti, poi improvvisamente teso sino allo spasimo. Questa azione antica, presente nell’immaginario di molti, apre – prefigurandone l’andamento – Mishelle di Sant’Oliva, il nuovo spettacolo di Emma Dante presentato in prima nazionale al Festival delle Colline Torinesi.

Foto di Alfredo Amato.
Sulla scena spoglia (due tendoni drappeggiati a mo’ di piccoli sipari sospesi nel vuoto, due sedie di legno, una borsa, una corda) ci sono Gaetano e Salvatore, un vecchio e un ragazzo, padre e figlio. Parrebbe un normale quadretto domestico, ma non lo è. Sui due uomini aleggia lo spettro della “francisa”, “la prima ballerina dell’Olympia di Parigi”, moglie e madre che li ha abbandonati da diversi anni preferendo il “balletto” alla vita coniugale.
Salvatore accudisce il padre con dedizione e sollecitudine, gli prepara da mangiare, lo accarezza, lo copre perché non prenda freddo. Il vecchio è agitato, si lamenta, succhia freneticamente acqua da un biberon. “La solitudine mi secca il cuore” dice, e ricorda. Ricorda l’incontro con la moglie, la sua bellezza senza pari, l’orgoglio per averla portata dalla Francia a Palermo fra l’invidia di tutti. Anche il ragazzo ricorda l’infanzia, i passi di danza insegnatigli dalla madre, il gioco fra chi è più bravo a eseguirli fra lui e il padre… Ma non c’è spazio per la nostalgia o la tenerezza se l’oggi è fatto di vuoto e sopraffazione: la tensione fra i due aumenta e lo scontro è inevitabile. La donna, inizialmente mitizzata, a poco a poco viene fatta a pezzi, e da étoile parigina si trasforma nella “prima puttana di Palermo”. Buon sangue non mente, e ora è Salvatore, in arte Mishelle, “u figghiu da francisa”, ad ancheggiare per le strade del quartiere di Sant’Oliva con il rossetto sulle labbra e un vestito nero con gli spacchi che gli fascia il corpo strabordante.
In questa discesa agli inferi senza freni né respiro, ancora una volta Emma Dante porta alla luce gli incubi racchiusi fra le mura domestiche, il lato oscuro dei rapporti familiari, la loro violenza talvolta intrisa di un malinteso sentimento d’amore. Non teme il grottesco, l’eccesso, l’assurdo, il ridicolo. Sa che fanno parte dell’esistenza e vi attinge a piene mani, creando un teatro così intenso da far male. Come in mPalermu, Carnezzeria, La scimia, sono i corpi degli attori il nucleo pulsante dello spettacolo. Corpi oppressi dal grasso, dagli anni, dalla fatica, madidi di sudore ma trasudanti bellezza, vita, verità. Corpi pesanti eppure leggerissimi quando si liberano nella danza, emblemi di un universo degradato e spietato ma pregno di umanità. Ed è davvero “bellissima” Mishelle – di una bellezza pura e crudele – mentre sulle note di Loredana Bertè esegue con grazia i passi imparati quand’era bambino e si chiamava solo Salvatore.

Foto di Alfredo Amato.
C’è l’amara lezione di Beckett nel bellissimo Mishelle di Sant’Oliva, nell’attesa vana che riempie il tempo e lo spazio, nel cappio fissato con un lucchetto al soffitto, nelle frasi e nei gesti frequentemente reiterati, nel tentativo di suicidio estenuato ed estenuante, gioco di morte che non si conclude mai. E c’è la tragedia di due uomini, a turno vittima e carnefice, che non possono fare a meno l’uno dell’altro e sono destinati a ferirsi per il semplice fatto di esistere, il vecchio obnubilato dalla struggente nostalgia del passato e da un egoismo assoluto, il ragazzo diviso tra la continua ricerca di approvazione e il desiderio di essere se stesso fino in fondo. Le loro schermaglie verbali spesso si dipanano in un dialetto siciliano scabro ed evocativo, lingua segreta e oscura capace di grandi suggestioni ma anche di accrescere il senso di claustrofobia che li schiaccia.
Francesco Guida è una straordinaria Mishelle, femminiello candido e seducente nella sua fisicità traboccante, irresistibile cocktail di pudore e sfrontatezza mentre ripete ossessivamente al padre “Non mi taliare” o cammina avanti e indietro a testa alta come una consumata professionista del marciapiede, vergogna paterna ma regina della notte. Altrettanto bravo è Giorgio Li Bassi, capace di alternare sprazzi di folle vitalità nel ricordo della donna amata a una cupezza senza speranza.
Il crescendo di sofferenza e angoscia, spezzato solo per brevi attimi da spiragli di sorrisi, culmina nell’abbraccio finale fra padre e figlio, disperato e soffocante: il filo si tende ancora una volta, ma non si spezza.
Le recensioni di ateatro: La crociata dei bambini
I Sacchi di Sabbia a Castiglioncello
di Erica Magris
Nella locandina del lavoro presentato al Festival Inequilibrio 2005 il 7 e l’8 luglio a Castiglioncello, I Sacchi di Sabbia scrivono che si tratta di “una tappa anomala del nostro percorso artistico, quasi la necessità di un allontanamento "da noi", dalle nostre modalità produttive.” La crociata dei bambini presenta in effetti diverse “anomalie” che lo rendono allo stesso tempo particolarmente interessante ma difficilmente descrivibile.
Innanzitutto il formato del lavoro è spiazzante: non si tratta di uno spettacolo unico di durata “standard”, ma di tre microspettacoli di venti minuti ciascuno, concepiti non come tessere di un mosaico più ampio, ma come frammenti completamente autonomi e a sé stanti. Hanno infatti la stessa macrostruttura spaziale e drammaturgica, ma si differenziano per i materiali testuali pronunciati, per il trattamento ritmico-sonoro del tessuto verbale e per la combinazione degli attori. Ogni gruppo di dodici spettatori ammesso ad ogni sessione assiste solo ad uno dei tre microspettacoli. Le esperienze e i ricordi di questo evento teatrale a tre facce saranno quindi simili e allo stesso tempo diversi. D’altra parte, anche il genere non è facilmente definibile, come traspare anche dall’ambigua definizione scelta per la locandina: “concerto-studio per visioni e suoni”. Racconto? Oratorio? Performance? Ognuno di questi termini risponde parzialmente alle caratteristiche del lavoro, ma non lo comprende interamente. Infine, non si tratta propriamente di una produzione della compagnia, ma del risultato di un laboratorio tenuto da Giulia Gallo e Giovanni Guerrieri insieme al musicista Bruce Borrini con gli allievi della scuola del Teatro Sant’Andrea a Pisa, a partire dal testo di Marcel Schwob La crociata dei bambini, pubblicato la prima volta nel 1895. Il lavoro è quindi sostenuto da attori non professionisti, che hanno compiuto un lungo percorso di studio del testo; all’inizio del laboratorio non era prevista la realizzazione di uno spettacolo da presentare al pubblico, ma man mano che si proseguiva nell’esplorazione del testo di Schowb, l’entusiasmo per il lavoro ha imposto di suggellarlo con l’incontro con gli spettatori.
Il testo di Marcel Schowb, dedicatario dell’Ubu Roi di Alfred Jarry, sembra allontanarsi dai temi prediletti dalla compagnia e dalla sua particolare ricerca sul linguaggio comico. Il libro tratta di un fatto oscuro ed inquietante, accaduto nell’Europa cristiana del tredicesimo secolo, quando trentamila ragazzini provenienti dalla Francia e dalla Germania, di età compresa fra i 4 ai 12 anni, formarono una sorta di improbabile esercito e si misero in marcia per raggiungere la Terra Santa e liberare il Sacro Sepolcro dagli Infedeli. Convinti che il mare si sarebbe aperto davanti a loro per lasciarli avanzare, molti, giunti al porto di Genova, si buttarono nelle acque e annegarono; altri si imbarcarono e furono venduti come schiavi, altri ancora proseguirono a piedi via terra e perirono di stenti lungo il viaggio. In realtà, La crociata affascinava i Sacchi di Sabbia, in particolare Giovanni Guerrieri, già da molto tempo ed era stato utilizzato in forma di frammento irriconoscibile in diverse creazioni, in particolare in occasione del Teatrino di San Ranieri a Pisa. L’argomento, così fosco e apparentemente lontano dal nostro presente, è ricco di suggestioni: in generale suggerisce una riflessione profonda sul futuro che si uccide, ed in particolare richiama alla mente tragiche vicende e peripezie cui sono condannati anche oggi i bambini nati nella miseria e nella guerra.
Fin dall’inizio, nel novembre dello scorso anno, il laboratorio del Teatro Sant’Andrea è stato imperniato sulla prosa poetica ed evocativa di Schowb. Invece di lavorare sulla nozione di personaggio, sul gesto e sull’azione drammatica, Giovanni Guerrieri e Giulia Gallo, hanno condotto gli allievi della scuola in un percorso di lettura del testo, finalizzato ad esplorare le possibilità espressive dello strumento vocale. Supportati dalla presenza di Borrini, che aveva già in precedenza collaborato con I Sacchi di Sabbia, i partecipanti si sono progressivamente appropriati del testo e hanno trovato delle sonorità, delle modulazioni, dei ritmi, che sono stati man mano rielaborati in una partitura in cui la partecipazione individuale è definita da una concertazione corale molto precisa.
La storia dei bambini-crociati è raccontata per frammenti da due differenti tipologie di narratori, ispirate alla struttura dell’edizione italiana del libro (Milano, La biblioteca blu, 1972). Il testo di Schwob si presenta come una raccolta di racconti in prima persona di alcune figure che parteciparono all’esercito dei bambini o che ne ebbero notizia: il goliardo, il lebbroso, papa Innocenzo III, tre bambini, lo scrivano François Longuejoue, il Kalandar, la piccola Allys, papa Gregorio IX. Ogni testimonianza condensa in poche pagine impressioni, reazioni, preghiere, che lasciano al lettore ampio spazio all’immaginazione e alla suggestione. Fra “oscure foreste, e acque, e montagne, e sentieri pieni di rovi”, fino al “cielo liquido” del “mare divoratore orlato di bianco” e alla “terra ardente” dove “tutto è bianco”, si ricompone la tragica avventura dei bambini, minacciati continuamente dalla fame, dagli stenti e da “uomini maligni” che “crepano gli occhi ai piccini e segano loro le gambe per mostrarli e chiedere la carità”. Gli editori italiani hanno poi scelto di racchiudere l’opera fra una prefazione di Jorge Luis Borges e due brani che illustrano la realtà storica della crociata dei bambini, il primo di Steven Runciman, autore della Storia delle crociate edita da Einaudi, il secondo di Alphandéry e Dupront, autori di uno studio sulla cristianità e sull’idea di crociata. Nello spettacolo, una voce narrativa più “storicizzante” e “oggettiva”, costruita a partire da brani di testi di Borges e degli storici, accompagna l’intervento dei personaggi-testimoni. Le due voci sono affidate a due gruppi distinti di sei e quattro attori, che si distinguono per le modalità di resa vocale utilizzate e per la disposizione nello spazio. I due gruppi sono infatti posti l’uno di fronte all’altro; in mezzo ad essi, si trovano gli spettatori seduti su un’unica fila di sedie, coinvolti fisicamente nel responsorio fra i gruppi narranti.
Il rapporto fra gli spettatori e gli attori è uno dei perni su cui si fonda la comunicazione dello spettacolo. Giovanni Guerrieri e Giulia Gallo hanno costruito la posizione dello spettatore con un dispositivo di visione e di coinvolgimento semplice ma di grande efficacia, giocando sulla dialettica fra prossimità e distanza. I dodici spettatori entrano al buio e in silenzio, si accomodano sulle sedie. Lentamente, entra il primo gruppo di attori, che si posiziona in piedi di fronte ad essi al limite del contatto fisico. Si accendono le luci e lo spettatore si ritrova a osservare e ad essere osservato da queste figure vestite di nero. Qualche secondo di silenzio, che pare lunghissimo, e poi inizia un bisbiglio corale, in cui tutti gli attori sussurrano il medesimo testo, ma con tempi sapientemente sfasati: “Un giorno di maggio del 1212 apparve a Saint-Denis, dove re Filippo di Francia teneva la sua corte, un pastorello di circa dodici anni, di nome Stefano, che recava con sé una lettera per il re…” Mentre terminano l’introduzione con le parole “dicono che ne sia rimasta eco nelle tradizioni del Pifferaio Magico”, gli attori capovolgono degli specchi rettangolari che tenevano fra le mani e mostrano agli spettatori lo spazio alle loro spalle. Le luci illuminano progressivamente quattro figure su una pedana immobili come il gruppo scultoreo di un bassorilievo: sono i testimoni, che il pubblico vede solo riflessi in uno specchio, come se fossero gli spettri emersi da quelle acque marine in cui i Genovesi temevano di veder apparire i bambini annegati. Questa volta le voci degli attori compongono una polifonia ricca di contrasti fra toni alti e bassi, fra ritmi distesi e accelerati, fra soli e momenti corali. Nell’alternanza sonora e visiva fra i racconti frammentari e sconnessi dei testimoni e le parole più razionali dei narratori, tra l’immediatezza dello sguardo diretto negli occhi dell’attore e la distanza dell’immagine riflessa, gli spettatori seguono l’esercito dei bambini per la strade d’Europa, fino al porto di Genova dove essi aspettarono invano che il mare si aprisse per farli passare. Il racconto verbale è accompagnato da alcune immagini stilizzate di Giulia Gallo, che stigmatizzano alcuni momenti della vicenda: alle spalle del pubblico vengono fatte scorrere delle silhouette scure che rappresentano i bambini in cammino con le croci e i bastoni da pellegrini, i bambini annegati in mare fra pesci indifferenti, una nave attaccata dai flutti. Quando sulle parole finali dei narratori gli specchi vengono riabbassati e le luci si spengono, gli spettatori restano come ipnotizzati, ancora immersi nell’universo di suoni e visioni che è stato loro costruito intorno utilizzando pochi materiali essenziali – la voce, il corpo, la luce, gli specchi, le silhouette.
L’operazione dei Sacchi di Sabbia è un’esperienza disorientante e coinvolgente, sia per gli spettatori che per gli apprendisti attori coinvolti nel progetto. Come lo spazio intimo della sala del camino del Castello Pasquini si è rivelato suggestivo proprio rispetto a quel Medioevo evocato dallo spettacolo, così altri luoghi raccolti e carichi di passato sarebbero particolarmente indicati ad accogliere questo lavoro. Speriamo che riesca ad essere presentato ancora, nonostante l’anomalia del formato e del gruppo attoriale, innanzitutto nell’affascinante cornice della chiesa sconsacrata di Sant’Andrea a Pisa, sede della compagnia.
Le recensioni di ateatro: Shot – Foibe
Al Mittelfest le foibe secondo Renato Sarti con Bebo Storti e Tanja Pecar
di Ferdinando Marchiori
Un bambino è in fila all’alba per il latte. Arriva un fascista, lo sente parlare sloveno e lo caccia via. Il piccolo se ne ricorderà qualche anno dopo, al momento di scegliere, e diventerà partigiano. È uno dei pochi, esili spunti narrativi di Shot – Foibe lo spettacolo con Bebo Storti e Tanja Pecar, regia di Renato Sarti, presentato in prima assoluta al Mittelfest di Cividale, ma destinato a un secondo debutto milanese in novembre. Uno spunto che ci si aspetta di vedere ripreso alla fine di uno spettacolo drammaturgicamente assai debole ma che si trova – come dire? – al posto giusto nel momento giusto. E infatti ecco il titino ancora in cerca del fascista che lo umiliò, senza tuttavia trovarlo: “Altrimenti lo avrei buttato in foiba”. La battuta è rivelatrice dell’atteggiamento complessivo di Sarti nei confronti della materia storica affrontata. Se nel corso dei due atti ritornano i toni rauchi e rancorosi di Mai morti, soprattutto la parte conclusiva insiste su questo piano che inclina incautamente (e a volte precipita, con inutili volgarità e attacchi personali – allo storico Sabatucci, per esempio, alla studiosa istriana di letteratura italiana Nelida Milani) verso un giustificazionismo che lascia perplessi. Così, ricordando l’uomo costretto a guardare mentre la moglie viene violentata dai fascisti, l’attore dirà: “Cosa fai? Gli spari in faccia. Io non voglio giudicare, non dico che è giusto, ma forse anche sì”. E poi “le scuole italiane in Istria le hanno chiuse, sì, ma anche per ripristinare quelle chiuse prima dai fascisti”, e i presunti 5.000 infoibati diventano “forse 500” e le foibe una metafora dell’isterismo storiografico delle zone di confine, “un abisso per le fantasie della mente”.

Foto Luca d'Agostino/Phocus Agency © 2005
Eppure lo spettacolo era partito con una immagine scontata ma efficace che poteva diventare figura portante dell’intero lavoro e determinare un atteggiamento scevro da ideologismi. Storti e la Pecar, attrice slovena che garantisce l’impasto multilingue transfrontaliero – triestino, sloveno, italiano, croato – sono in scena con l’elmetto da speleologi e l’intenzione di calarsi nei crepacci della storia, “una sorta di percorso carsico in un argomento delicatissimo” ha appena spiegato il regista rivolgendosi al pubblico. Accesi i faretti sulla testa, i due attori si muovono carponi emulando le avventure di Sussi e Biribissi, i protagonisti di un libro per l’infanzia letto da quegli stessi bambini che nel secondo dopoguerra, all’alzabandiera, in coda all’inno nazionale cantavano: “Marciam marciam che Tito xé un rufian”.
Ma il cauto addentrarsi nel “Carso che xé tuto vodo”, in una “tera che xé tuto un buzo”, lascia ben presto il posto alla veemenza di una ricostruzione storica dell’occupazione italiana della Slovenia che elenca cifre, dati, mostra sullo schermo gigante terribili immagini di violenza a Lubiana, a Fiume, nel campo di concentramento di Arbe, dove nelle “tende Roma” i deportati morivano di fame e di malattia. Si leggono lettere di soldati italiani che descrivono le atrocità commesse sui civili inermi, si raccontano episodi raccapriccianti, si ricorda l’incendio dell’albergo Balkan a Trieste, la politica antislava, l’italianizzazione forzata dei nomi, le tante vittime degli squadristi, come il direttore d’orchestra Bratuz, costretto a bere olio di macchina per aver parlato dal podio nella sua lingua, lo sloveno.
Si comprende allora il primo intento del regista (che firma il testo e cita Claudia Cernigoi, autrice di Operazione foibe, Kappavu Edizioni): spiegare il contesto e le ragioni storiche che determinarono – dopo l’8 settembre e più tardi nell’immediato dopoguerra – le violenze contro gli italiani. Operazione doverosa, che la ricerca storiografica (da Giacomo Scotti a Raul Pupo) ha da tempo avviato. Quello che suona strano, tuttavia, è la riduzione di un eccidio a fatto quasi privato. Lo spettacolo contesta al Presidente Ciampi l’espressione “sterminio etnico” da lui usata di fronte alla foiba di Basovizza, ma all’idea di un olocausto di italiani sostituisce quella di una serie di regolamenti di conti, vendette personali, faide paesane. “Se si fosse trattato di sterminio etnico – si arriva a dire – come mai 2.000 operai potevano andare nel 1948 da Monfalcone” a lavorare in Jugoslavia? È un ragionamento troppo ingenuo per non essere in cattiva fede. Chiunque conosca la storia dei “monfalconesi” sa che la loro scelta (dalle conseguenze spesso drammatiche) e la loro accettazione da parte della Federativa jugoslava erano entrambe il portato di una cultura politica che (a scorciare il discorso con l’accetta) sostituiva “il sol dell’avvenire” internazionalista alle retoriche della patria e opponeva al nazionalismo la lotta di classe.

Foto Luca d'Agostino/Phocus Agency © 2005
Considerare le violenze contro gli italiani nel loro giusto contesto non può del resto lasciare l’impressione nello spettatore che si giochi ancora sull’equazione italiani infoibati = fascisti. Ma è un’ambiguità che sembra funzionale al primo come al secondo intento dello spettacolo: sgonfiare le cifre intorno alle foibe. Ecco allora Storti insistere su numeri e nomi, citare puntigliosamente gli errori nelle liste compilate in sessant’anni, da quella di Bartoli a quella di Papo fino a quelle più recenti: nomi e cognomi di persone inserite due volte o viventi dopo i fatti o giustiziati altrove. Ma che senso può avere calcolare perfino la percentuale di errori di queste liste?
Nelle note di sala, il regista dichiara che “il fine teatrale, e non storico, di Foibe è quello di colpire la coscienza dello spettatore facendo comprendere quanto importante sia aspirare ad una società multietnica”. Nobile scopo. Ma perché accanto ai precedenti storici che hanno causato le foibe, e alla vergognosa strumentalizzazione politica della destra italiana, Sarti e Storti non hanno ricordato anche la tragedia di chi ha subito, solo in quanto italiano, le stesse violenze e discriminazioni di chi le aveva subite in quanto sloveno o croato? Perché cioè non hanno fatto sentire – una volta ribadita la responsabilità del fascismo – la comune tragedia di un’area, quella della Venezia Giulia, dell’Istria, della Dalmazia, dove si è pianto in tutte le lingue? Il teatro, ben più intensamente della storia, può farci sentire che uno è il dolore. Può insegnarci a distinguere tra vittime e carnefici, ma deve saper riconoscere (meglio e prima della storiografia) quando le parti si invertono. Può farci comprendere anche una vendetta, non giustificarla.
E infine: dov’è il teatro? Lo spettacolo è lugubre, grigio, lungo, senza pathos. Non uno slancio lirico che commuova: eppure dalla lettura in ginocchio della tremenda lettera di un cappellano militare che assiste i fucilati s’intravede quella pietas che sola potrebbe opporsi a tanto male. Uno spiraglio d’ironia sembra aprirsi nel secondo atto, che inizia con le battute del processo a Cecchelin, noto attore triestino antifascista. Ma è anche questo un personaggio buttato via, reso subito livido da una recitazione monocorde. Quando il teatro si sostituisce alla storiografia senza mettere in gioco il proprio linguaggio, senza riflettere anche su se stesso, finisce per fare della cattiva storia e del cattivo teatro.
Santarcangelo haiku
Qualche spettacolo dal festival 2005
di Oliviero Ponte di Pino
Amid the Clouds di Amir Reza Koohestani - ventisettenne regista e drammaturgo di Shiraz, enfant prodige del teatro iraniano subito adottato dai francesi - racconta le stesse drammatiche vicende di Le Dernier Caravanserrail di Ariane Mnouchkine: l’esodo dal terzo al primo mondo, fino ai campi profugi francesi affacciati verso l’Inghilterra, dopo mille pericolie e peripezie, umiliazioni e fatiche. Ma là dove lo spettacolo del Théâtre du Soleil raccontava con ritmo quasi cinematografico, partendo da un’inchiesta di stampo giornalistico, per approdare una vicenda corale, in un allestimento kolossal ricco di effetti spettacolari, Koohestani lavora invece per sottrazione. Una scena immersa nel buio, dove – si scoprirà – campeggiano solo tre-quattro parallelepipedi di vetro pieni d’acqua. Due soli attori, Shiva Fallai e Hassan Madjooni, emergono a tratti in questa notte notte della memoria e dell’oblio. Il testo è ridotto all’essenziale, e sospinge la vicenda più verso la favola e il mito che il reportage e la denuncia.


Lei fugge dall’Iran perché è rimasta incinta: e racconta che sono state le acque del fiume che doveva attraversare, lo stesso fiume che ha travolto i suoi familiari lasciandola sola in mezzo al guado. Lui ha invece deciso di abbandonare il proprio paese perché ossessionato dal suicidio della madre. Non c’è bisogno di spiegare nulla, ma chiaramente la condizione della donna all’interno della società, e il suo ruolo in un immaginario dove il mito può ancora risuonare, sono al centro del lavoro di Koohestani e del suo Mehr Theatrical Group (anche se è molto difficile immaginare, per noi europei, quale possa essere l’impatto di uno spettacolo del genere sugli spettatori e le spettatrici iraniani).
Imour e Zina si incontreranno al confine tra Bosnia e Croazia, in una terra di nessuno lontana sia da casa sia dalla loro meta, soli in un mondo ostile dopo che anche lui ha visto i suoi parenti travolti dal torrente che segna il confine. Nel cuore hanno un groppo di angosce e speranze che non riescono neppure a capire.

La vicenda procede per sucessivi frammenti di monologo, lei e poi lui e poi ancora lei. Sono stratificazioni successive di evocazioni liriche e di frammenti di realtà. Impercettibilmente, con delicatezza, uno dopo l’altro, Koohestani accumula segni elementari (come la donna che emerge dall’acqua di una della vasche-acquario), che finiscono per evocare un universo sempre più complesso. Così nel gioco teatrale il sostrato senza tempo della fiaba e la cronaca contemporanea trovano insospettabili risonanze reciproche. E per i due personaggi, al termine di una odissea fatta di fame, sete, freddo e solitudine, sarà finalmente possibile capire qual era la confusa speranza che li aveva messi in moto.
Il muro contro cui si struscia, nella prima stanza del suo spettacolo, Luisa Cortesi, ricorda quello dove s’arrampicavano nel memorabile inizio di Crollo nervoso Marion e Vera, più di vent’anni fa. In Crollo nervoso quella danza era una sfida contro la forza di gravità, un gesto aggressivamente trasgressivo; in Di stanze Luisa Cortesi gioca piuttosto con l’erotismo. Una volta, in quegli anni Settanta, si cercava lo shock come possibilità di liberazione. Ora che quelle speranze si sono svuotate, si cerca piuttosto la complicità, un rapporto quasi erotico di attrazione sensuale con lo spettatore. Una volta al centro del lavoro c’era l’analisi degli elementi costitutivi dello spettacolo, ora è piuttosto la costruzione di un formalismo volutamente convenzionale. Una volta a innescare il movimento dei corpi era la logica della macchina, adesso sono il respiro caldo e il fragile pulsare dell’animale. E’ tutto diverso, ma sembra esserci, dentro quei corpi, la stessa disperazione, la stessa rabbia, la stessa forza.

Foto di Carlo Gianni.
La danza di Luisa Cortesi (una lunga collaborazione con Virglio Sieni) rimanda a Steve Paxton (la consapevolezza dello spazio, il contatto del corpo con il mondo – e con un altro in queste stanze irraggiungibile ma costantemente evocato); ma richiama anche Jan Fabre e la sua provocatoria esibizione dei corpi e dei loro fluidi. Massimo Barzagli, artista visivo, ha “arredato” le stanze in cui si snodano le successive stazioni di questo percorso femminile con immagini fotografiche di interni, ora stampate su tappeti ora isolate e proiettate sulle pareti.

Foto di Carlo Gianni.
E’ un progressivo denudamento seduttivo e autoerotico, quello di Luisa Cortesi, che culmina nella lunga sequenza in cui la danzatrice si lava, leccandosi meticolosamente come un gattino. E che si conclude nell’applicazione di un trucco prevedibilmente eccessivo, con i tratti del viso stravolti dall’eccesso di rossetto e mascara, il corpo irrorato di crema che si struscia sul pavimento.
Ada ha ossessionato in questi anni Fanny & Alexander, portando alla creazione di una serie di macchine teatrali meticolosamente spiazzante, raffinate e inventive. L’ultima tappa di questa spettacolarizzazione del romanzo di Nabokov, Vaniada, spinge ancora una volta il gioco della rappresentazione verso i suoi confini. Questa volta gli spettatori – una cinquantina circa – vengono sistemati in un claustrofobico teatrino-bara, separando i maschi dalle femmine. Ben presto il pubblico si trova immerso in un’inquietante oscurità. In questo buio tombale, i due protagonisti del romanzo, Van e Ada, sono ridotti ad apparizioni: ormai, esaurita la loro parabola, sono fantasmi, che possiamo intravvedere quasi solo come evanescenti ectoplasmi, sentire come echi lontani, avvertire come presenze invisibili.

Allo stesso modo anche gli attori perdono corpo e materialità, restano maschere vuote, ectoplasmi, indizio di una assenza. Lanciano segni e frammenti dagli oblò che si aprono sulle pareti (come se si fosse invertito il rapporto tra pubblico, attori e scena della prima puntata del serial). Parlano attraverso gli enigmi incisi sulle lapidi che s’illuminano alle pareti, a sottolineare il gioco delle ambigutà che innervano l’intera operazione.
Quella d Vaniada è una macchina scenica che ingloba il pubblico e lo manipola, evocando a suo beneficio echi trascendenti e misteriosi, una scatola delle magie, un teatrino della morte inquietante e regressivo.
Serata finale, Sandro Lombardi legge Pascoli alla Villa Torlonia di San Mauro Pascoli, al centro della tenuta di cui suo padre era fattore. All’inizio un gruppo di bambini recita La cavallina storna, emblema del cantore bamboleggiante del fanciullino. Ma prevedibilmente il Pascoli di Lombardi è molto lontano dal cantore dolente e bamboleggiante, compiaciuto e vezzoso, di una certa insopportabile maniera: è al contrario un poeta vigoroso, robusto, a tratti persino rabbioso. E quando alla fine Lombardi ritorna alla Cavallina storna, è una lettura completamente diversa: perché questo Pascoli, quando s’interroga sull’omicidio insoluto del padre, è some se avesse letto l’”Io so” che Pasolini aveva dedicato all’Italia elle stragi impunite.
Passaggio in Iran: 22° Festival Internazionale di Teatro FADJR Teheran, 23 gennaio-2 febbraio 2004
Censura e censori nel teatro iraniano
di Mimma Gallina
L’incontro e le considerazioni che seguono risalgono a un anno e mezzo fa circa. L’Iran ha appena vissuto il trauma del terremoto di Bam (che ha creato qualche ripercussione organizzativa anche sul festival) e è alla vigilia di una competizione elettorale molto importante: il presidente Kathami, che perderà le elezioni pochi giorni dopo, gioca con grande cautela e accortezza (è stato un politico di statura eccezionale) un braccio di ferro duro con le autorità religiose. L’argomento del contendere ha a che fare con la censura: il consiglio della rivoluzione ¬composto di religiosi - ha infatti per costituzione il compito di approvare le liste elettorali. Nessuno contesta questo ruolo, ma questa volta si sta un po’ esagerando: fra le epurazioni si contano personalità stimate e autorevolissime, fra cui un fratello dello stesso Kathami.
Tutte le persone che incontro - gente di teatro, interpreti, studenti/pubblico curiosi del contatto occidentale, portieri d’albergo - non parlano volentieri di politica, non partecipano neppure troppo a questo scontro (che a me sembra di importanza vitale per il paese) e di cui so dai quotidiani in inglese di Teheran. Ma parlare in genere non è facile, non capisco se e in che misura ci sono controlli (probabilmente sì, ma discreti), o se la cosa ha a che fare con la barriera tutt’altro che sottile della forma e dell’educazione: quel modo di fare spontaneamente cerimonioso - che ho verificato prima di partire organizzandomi una personale retrospettiva Kiarostami in video - per cui ci si saluta e risaluta in continuazione, ci si chiede come stai, non ci si tocca, si rispetta (gradevolmente) lo spazio reciproco, ma non si riesce a dire un gran che.
Lo stato della democrazia è decisamente un terreno minato, a Teheran riesco a scambiare solo poche battute con un interprete di spagnolo, meno controllato della media, e le sue conclusioni meritano una riflessione: in occidente la democrazia ha anche duecento anni e non potete certo dire che sia perfetta, da noi ne ha venti, dateci il tempo. E sul tempo, ¬rispondendo alla mia impazienza di ottenere informazioni, materiali, incontri eccetera - l’interprete personale di italiano che mi ha messo a disposizione il festival (molto giovane, molto bella e molto ignorante: ma ha studiato in Italia dove suo padre commercia in tappeti), mi traduce credo letteralmente e con disinvoltura milanese un proverbio assai istruttivo: “Se cerchi di organizzare il tempo, il tempo ti cagherà addosso”. Mi sembra troppo giovane per esserselo inventata apposta per me! Sto dimenticandomi che siamo in oriente, e la concezione del tempo è l’indicatore principale di differenza culturale.
La notte, all’una e mezza circa, una rete televisiva nazionale trasmette un lunghissimo e documentatissimo telegiornale in inglese: una buona metà delle notizie sono di provenienza americana e si soffermano su povertà, ingiustizie sociali, nefandezze di quel paese e di Bush in particolare (anche a partire dal recente discorso alla nazione e da non ricordo quale presa di posizione all’ONU), raccontate di prima mano da testimoni americani, per lo più professori universitari. L’immagine è quella di un occidente malsano e bugiardo, dove non mancano le presenze consapevoli e amiche. La sigla della trasmissione è un esaltazione delle conquiste del paese, dighe, ponti, bambine che sorridono e l’immancabile volto severamente paterno di Khomeini.

La democrazia è giovane certo, non esiste una sola possibile democrazia, ed è così giovane che sembra ancora un po’ totalitaria. Ma le nostre in fondo... Tasto meglio il polso del rapporto con l’occidente a Isfahan, una delle città più belle che abbia mai visto, turistica e dove molti parlano inglese.

I giovani come sempre numerosissimi sono meno abbottonati (ma anche i commercianti: trovo perfino una botteguccia ebraica dove mi raccontano dei rapporti non troppo tesi della striminzita comunità con il contesto islamico). Con l’incredibile gentilezza che mi sembra propria di una grande civiltà, più che di uno stato canaglia (come la cucina del resto!), ti abbordano e chiedono di tutto di più sull’Europa e sull’Italia, dove verrebbero volentieri a specializzarsi. Se c’è un fondo di disprezzo per l’occidente, mi sembra sia decisamente solo rivolto all’America (e a Israele, naturalmente).
La censura è normale, quindi. E’ parte della vita quotidiana: fruga nelle liste elettorali, indirizza il TG di propaganda per stranieri, detta l’abbigliamento delle donne e il comportamento anche degli uomini e, perché no, ha una sua funzione precisa anche in teatro. Ma sappiamo anche che la censura non si nega, si aggira.
Il festival di Fadjir è un po’ come la Biennale di Venezia, diviso in sezioni e molto più noto a livello internazionale per il cinema. Ma quello teatrale è in crescita, guidato dal giovane Majid Sharifkhodaie. Pensavo fosse un maturo burocrate, ma mi trovo di fronte un bell’uomo barbuto e corpulento sotto i quaranta, così normale che non mi ricordo che non devo dargli la mano (ovvero, me ne ricordo con la mano a metà strada, osservando i ritratti degli ajatollah appesi al muro). Il festival è internazionale, ma sono al 90% iraniani gli spettacoli che si succedono presso il City Theatre (una struttura circolare con una sala grande e almeno sei-sette sale oltre al piazzale antistante per gli spettacoli off off o di strada), il Teatro Nazionale, il Teatro dell’Università e le Moschee (con la sezione dedicata alle sacre rappresentazioni). In tutto sono circa un’ottantina le proposte in programma. Cerco di incontrare subito Sharifkhodaie per avere almeno qualche indicazione, per orientarmi, e un po’ a fatica (per la stessa difficoltà che avrebbe un direttore di festival da noi a dirti di vedere quello anziché quell’altro) ricavo comunque qualche linea guida e la segnalazione di tre/quattro gruppi da non perdere. La maggior parte sono di Teheran, ma non pochi dal resto dell’Iran. Sono teatri pubblici e gruppi sovvenzionati, a volte universitari, ma non hanno - salvo un paio di eccezioni - la dimensione ingombrante che si associa quasi sempre al teatro pubblico. Sembrerebbero gruppi del tutto indipendenti, anche per la presenza di giovani e giovanissimi. Anche il pubblico è giovanissimo, soprattutto studenti universitari, più numerose le donne.


Il pubblico del festival nei teatri.
Ragazzi e ragazze sono mediamente molto belli: le ragazze hanno elaborato variazioni sul tema del velo e del coprirsi che farebbero invidia a Prada. Mi spiegano che va di moda da un paio d’anni il “manto” attillato con zip: cioè l’importante è che copra, non che sia largo; le ragazze più ortodosse, con manto coprente e nero, si sbizzarriscono con stoffe, nere ma lavorate, molto belle (e sono decisamente le più eleganti), ma fra le altre non sono rari i veli colorati. Meno frequenti i colori girando per la città, fuori dall’ambiente teatrale e universitario. Qui il velo per la verità fa comodo anche a me (del resto ci si abitua presto), per filtrare un inquinamento che percepisco ben superiore a quello di Milano: la città è trafficatissima e con oltre 10 milioni di abitanti, i semafori non vengono osservati e attraversare la strada è un terno al lotto (anche per gli strani canaletti ai bordi in cui si rischia di cadere - un’informazione che avevo sottovalutato dalla guida Lonely Planet).

I murales degli ajatollah, del grande vecchio e dei (giovani) eroi della guerra contro l’Iraq danno al paesaggo urbano un look cino-sovietico anni Settanta.

Il bazar enorme e affollatissimo è come tutti i bazar, con un rispetto maggiore delle distanze, ma trattative all’ultimo sangue, come è giusto.
In questo paesaggio la moschea è un’isola riposante. Ma può diventare frenetica come una club jazz per le sacre rappresentazioni provenienti un po’ da tutto l’Iran: orchestrine degne del Buena Vista Social Club, cast rigorosamente maschili all’altezza dei Legnanesi, e pubblico in delirio. Uomini, donne e bambini seguono le note vicende di Giuseppe, Giacobbe eccetera (le storie infatti sono spesso quelle bibliche) e soprattutto il Martirio dell’Imam Mohammad. Invidio i colleghi tedeschi che - quasi col libretto di assegni in mano - stanno già comprando: o meglio mettendo a punto un progetto di documentazione di questo “genere”, la versione scita/iraniana della sacra rappresentazione, con presenze filmate e dal vivo a Berlino.



Il pubblico delle sacre rappresentazioni nelle moschee diviso nei due settori, maschile e femminile.
In confronto gli spettacoli di taglio occidentale sono piuttosto deludenti, spesso naïf, con interpretazione di tipo psicologico piuttosto convenzionali. Ma non mancano le eccezioni, naturalmente: qualche testo che sembra interessante e forse meriterebbe di essere tradotto, qualche attore notevole, qualche sprazzo di genialità nella regia (e spesso si tratta di elementi che hanno frequentato anche e le scene occidentali).
Le punte più sconcertanti sono nel balletto e nei musical, di taglio storico, con contaminazioni fra folklore e danza contemporanea e non infrequenti derive politico-propagandistiche (temo sia una maledizione di questo genere nei paesi - per semplificare - a democrazia imperfetta: occidentali e orientali, europei o asiatici).


Non mi pesano però i quattro-cinque spettacoli al giorno in lingua parsi, un po’ alla ricerca di lavori interessanti e nella speranza di imbattermi nel guizzo di genio, un po’ perchè prevale l’interesse sociologico (e ho sperimentato che non capendo le lingue si capiscono un sacco di cose che le parole non dicono).
A questo punto posso arrivare al mio censore, che è anche nella commissione che ha scelto gli spettacoli e mi offre molte chiavi di lettura sul complesso del festival.
Incontro Hossein Mosafer-Astaneh negli uffici del Fadjr.

Ma l’ho già incrociato spesso nei giorni precedenti e ormai ci conosciamo. E’venuto lui, che fra l’altro è il ¬capo della commissione censura - a supervisionare lo spettacolo italiano ospite, La tomba di Antigone da Maria Zambrano, con Patricia Zanco, regia Daniela Mattiuzzi. Fra alcuni spettacoli di qualità, disponibili a costo zero o quasi, sulla carta e su video, la scelta del festival è caduta su questo: una scelta decisamente aperta, Antigone è una donna ribelle e segregata (nel 2003 era stato ospitato Natura morta in un fosso di Fausto Paravidino, regia Serena Sinigaglia, con Fausto Russo Alesi, produzione ATIR: qui addirittura una vicenda di prostituzione, omicidio, incesto). Dove va a colpire allora la censura?
Nel caso di Antigone per Hossein il problema principale era trovare una soluzione teatralmente valida per coprire la testa calva di Patricia! Cioè la massima nudità possibile. Ci ha colpito molto la sua insistenza nel salvaguardare l’immagine originale delle spettacolo realizzando una calotta: Patricia ha poi optato per un turbante, ma è stato subito chiaro che la preoccupazione - ed è così con gli spettacoli occidentali in genere - è trovare un punto di incontro fra la morale locale e una visione artistica diversa, ma che deve essere preservate in uguale misura, con sostanziale rispetto. Nel caso di Natura morta, l’anno prima, Fausto aveva dovuto coprirsi nelle scene a torso nudo: nessun intervento sul tema o sulla lingua (peraltro il festival non prevede traduzioni simultanee ma solo materiale informativo cartaceo e a nessuno sarà arrivato il turpiloquio).

La tomba di Antigone con Patrizia Zanco in Iran: una prova per il censore.
Il controllo preventivo, in entrambi i casi, è stato accurato, con intere scene recitate solo per i censori (praticamente erano prove filate).
Per inciso, tutti e due gli spettacoli italiani hanno ottenuto un notevole successo e, a quanto so, anche le rare presenze degli anni precedenti. Del resto il regista occidentale più noto e di casa qui è l’italiano-tedesco Roberto Ciulli (che quest’anno presenta un Tito Andronico del suo Theater an der Ruhr), per cui c’è un culto pari a quello che noi riserviamo a Dodin o a Brook.
Hossein Mosafer è molto disponibile e quasi felice di confrontarsi sul tema della censura. Sa che noi diamo un significato negativo a questa pratica, che la consideriamo una limitazione della democrazia, e vuole spiegarmi.
Per le presenze straniere, si tratta di smussare i possibili elementi di attrito culturale (come abbiamo visto). Per quanto riguarda gli spettacoli iraniani, e soprattutto i gruppi giovani (il nostro censore per la verità ha poco più di quarant’anni, ma i giovani in Iran sono giovani davvero), più che di controllo preventivo il ruolo si configura quasi come una consulenza: si tratta di evitare in scena quei comportamenti, atteggiamenti eccetera, che potrebbero infastidire lo spettatore perchè contrari alla morale corrente e danneggiare conseguentemente lo spettacolo. Tutto quello che potrebbe in sostanza configurarsi come una provocazione inutile e gratuita (anche rispetto alle autorità religiose, certamente: e la censura “protegge” anche da possibili reazioni di queste ultimi i giovani potenzialmente avventati).

La strana coppia all'iraniana, ovvero Neil Simon in chador.
La censura non si esercita sui contenuti, politici ad esempio, ma sul comportamento, sulla “morale” (potremmo dire sul “comune senso del pudore”: in fondo da noi questo tipo di censura è cessata meno di trent’anni fa: se ce la immaginiamo con il faccione di Alberto Sordi, non per questo era meno clericale e oscurantista).
Ci sono leggi di riferimento, regole precise per sapere cosa è permesso e cosa no? Ci sono e non ci sono (e sono legate ovviamente all’interpretazione del Corano), la discrezionalità è ampia e a maggior ragione il ruolo è delicato.
Faccio notare al mio nuovo amico che portare in scena uomini e donne che parlano di vicende private, di famiglia, d’amore, sempre vestitissimi e senza mai toccarsi, non è una limitazione da poco: configura uno stile (una drammaturgia, un’interpretazione), appiattita su questi stereotipi, limita non poco l’espressione (provate a immaginarvi uno spettacolo italiano dove gli attori non si toccano MAI! Un uomo e una donna si parlano spesso anzi a qualche metro di distanza, il che è del resto più espressivo e teatralmente efficace che la vicinanza stretta senza contatto).
Ma questo, mi ribatte, è il limite che il gusto e la morale implicano: andare oltre ferirebbe i sentimenti comuni, e finirebbe solo per danneggiare il teatro.
Parliamo di uno spettacolo che ho visto, di taglio sperimentale/occidentale anni Settanta (purtroppo le foto non sono riuscite). In scena una povera attrice vestitissima e con tanto di velo e il suo compagno in mutandoni e cannottiera si rotolavano in una vasca di fango: una sequenza che forse avrebbe avuto senso solo se fossero stati nudi, o quasi. Hossein, che è anche regista e docente all’accademia, sottolinea che quell’esperimento non è riuscito (anche se non è stato bloccato), proprio per la distanza di quel gusto da un teatro che sia davvero contemporaneo per l’iraniano contemporaneo. Non lo sfiora il dubbio che senza quei limiti di abbigliamento lo spettacolo potesse riuscire, e acquistare un senso, ma pensa che sia la dimostrazione di come sia sbagliato scopiazzare modelli come questi (non escludo che abbia ragione: peccato che non lo si possa verificare).
E controllo politico e sui contenuti? Escluso, dice. Mi spiega che fino ad alcuni anni prima era molto diffuso un teatro esplicitamente politico, che negli ultimi tempi però ha totalmente allontanato il pubblico. Le compagnie, gli artisti, si sono spostati sui temi che interessano davvero la gente: quasi tutti gli spettacoli infatti analizzano rapporti di famiglia, di coppia, amicizia eccetera. Autocensura? Forse no (come sostiene Hossein).
Capisco dagli spettacoli che non è solo riflusso (lo stesso che sta vivendo la “rivoluzione” iraniana), ma che la politica passa davvero dal privato. La grande avanzata delle donne nello studio e nelle professioni è una lotta continua in famiglia, la libertà di contrarre matrimonio con chi vuoi, la libertà di spostarsi, di valorizzare la complessità dei sentimenti: questa in fondo è politica . Ciulli, che frequenta l’Iran da anni, mi conferma questo spostamento e non lo vede negativamente (lui, così ideologico): soprattutto, vede una società che si muove suo malgrado grazie alle donne, al potere silenzioso che stanno prendendo. Speriamo.
Da parte sua, il direttore Sharifkhodaie sostiene che gli obiettivi del festival sono soprattutto “umanistici”: “riallacciare il dialogo fra la gente” sui problemi di fondo dei rapporti umani, per questa funzione il teatro è così importante. Ed è questa tendenza in effetti che sembra mostrare la scena iraniana (almeno nella grande maggioranza delle messinscene selezionate, e in particolare da parte dei gruppi giovani)
Per non equivocare: si può parlare anche di sesso, il tema anzi è ricorrente (una compagnia ha recentemente messo in scena Tutta casa, letto e chiesa di Fo/Rame!), ma senza oltrepassare il limite. E’su questo limite che si tratta di vigilare, salvaguardando al massimo la libertà di espressione, anche con consigli in corso di allestimento (naturalmente il controllo si esercita sullo spettacolo, non sul testo): e in questa pratica il mio interlocutore deve effettivamente eccellere, lo si deduce dall’autorevolezza che emana, ma anche dall’amicizia che lo circonda in giro per gli spettacoli e dal premio che riceve a fine festival come “miglior censore”! (potremmo proporlo anche in Italia: un premio alla più evidente autocensura!!!).
A dimostrazione di quanto poco Hossein sia rigido, dopo una gradevolissima ora con pasticcini e tè, mi da perfino la mano. Mi vuole dire, credo, che nessun intellettuale iraniano si sogna di pensare che la donna sia impura e non possa essere toccata. Basta solo qualche accorgimento per dire quello che vuoi: essere un teatrante-censore è aiutare gli altri a far e teatro.
Marzo 2004/ luglio 2005
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
La confessione cinematografica di un fan di Alfred Hitchcock
Costanti tematiche e motivi teatrali nel cinema di Robert Lepage: il caso Le confessionnal
di Sara Russo

Il confessionale (Le confessional, 1995) di Robert Lepage è il primo film girato dal regista canadese ed è anche l’unico a non essere tratto da alcuna sua opera teatrale. Solitamente abituato a creare un percorso artistico che dal teatro approda al cinema, transitando per un lungo processo dall'ideazione alla messinscena, attraverso successivi stadi di stesura e di scritture fino alla fissazione del testo definitivo e alla realizzazione di una pellicola (da Le Poligraphe a No, a La face cachée de la lune), Lepage qui si cimenta direttamente con il medium cinematografico senza l'originario imprimatur teatrale, ma non rinuncia però a chiamare all'appello contenuti e motivi formali che abitano le sue internazionali produzioni teatrali.
Dal punto di vista della trama, il film è un'intricata saga familiare che si impernia sullo svelamento dell’identità del padre, appena morto, da parte dei due protagonisti, e che si collega, come è noto ad una certa filmografia hitchcockiana, in particolare a Io confesso, pellicola che Alfred Hitchcock, regista molto amato da Lepage, girò proprio a Quebéc nel 1952.
I richiami di Lepage a Hitchcock sono sia tematici (come in Io confesso c’è un prete ingiustamente accusato che non può difendersi perché vincolato dal segreto confessionale) sia visivi, con l’inserto di alcune scene in bianco e nero della pellicola del regista inglese che si fondono perfettamente con la storia di Il confessionale in un gioco di citazione e insieme metanarrazione filmica.
Come nei suoi spettacoli teatrali Lepage mostra talvolta allo spettatore il dispositivo in scena (i videoproiettori ai piedi degli spettatori in La face cachée de la lune), svelando gli artifici tecnici che permettono all’attore di dialogare con la macchina scenica, così ne Il confessionale ricostruisce il set di Io confesso palesando allo spettatore gli artifici sottesi all’opera cinematografica con un complesso procedimento autoriflessivo. Io confesso è stato inoltre girato nella chiesa dove sarà battezzato uno dei protagonisti del film di Lepage.
In entrambi i film è nel passato che si ricerca la verità o la soluzione di un mistero – lo svelamento dell’identità del padre di Marc Lamontagne in Il confessionale e del vero assassino in Io confesso. Quest'ultimo è giocato su due piani temporali, passato e presente (si ricordi il lungo flash-back che occupa la parte centrale del film, e che mostra la storia d’amore fra il prete e la protagonista femminile); allo stesso modo la struttura del primo lungometraggio di Lepage si basa sulla stretta intersecazione di due storie ambientate in periodi diversi: la prima, che si svolge proprio durante le riprese di Io confesso in una chiesa del Quebéc nel 1952, narra le difficoltà di una ragazza madre e il segreto sulla paternità del figlio che aspetta; la seconda, ambientata nel 1989, ruota intorno alla ricerca del padre da parte del bambino, ormai adulto, aiutato dal suo fratellastro Pierre.
Nel film di Hitchcock i ricordi dei personaggi assumono la forma di flashback: ognuna delle evocazioni del tempo passato di Io confesso viene introdotta e si conclude mediante una dissolvenza, diversamente da quanto accade nel film di Lepage, dove le immagini del passato non appartengono ai ricordi di alcun personaggio, ma sono inserite dal narratore extradiegetico senza utilizzare tecniche di transizione come ad esempio la dissolvenza.
Le transizioni temporali di Lepage sono introdotte da carrellate, da panoramiche o piani sequenza, perciò senza stacchi di montaggio, e non sono mai collegate alla memoria volontaria dei personaggi.
L’inchiesta poliziesca della pellicola hitchcockiana corre parallela ne Il Confessionale ad una inchiesta più intima e archetipica: la ricerca delle proprie origini rappresentata dallo svelamento edipico dell’identità del padre.
Ne Il Confessionale molte immagini in bianco e nero del film di Hitchcock si intarsiano con le immagini a colori vere e proprie della storia dei personaggi lepagiani. Fin dall’inizio del film, brani di Io confesso grazie all’espediente del ponte sonoro, si inseriscono interrompendo la narrazione.
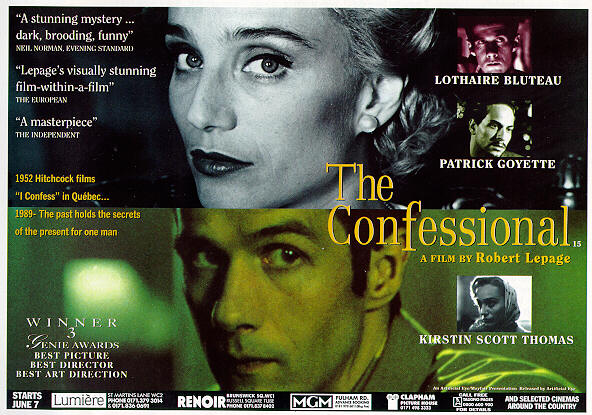
La sequenza de Il confessionale più interessante dal punto di vista tecnico in cui assistiamo all’integrazione di Io confesso è sicuramente quella ambientata nel 1952 nella chiesa dove lavora la madre di Marc e dove officia messa il prete che ha accolto in confessione il suo segreto. Lo staff di Hitchcock sta girando in questa chiesa alcune sequenze di Io confesso mentre si sta celebrando il battesimo di Mark in sagrestia.
In un complesso piano sequenza la macchina da presa prima inquadra Hitchcock (interpretato da Ron Barrage) e il suo attore (nel film di Lepage una controfigura presa di spalle incarna Montgomery Clift) che stanno iniziando a girare una scena di Io confesso, poi in un procedimento di mise en abîme nel momento in cui Hitchcock dice “Motore!” la pellicola di Lepage diventa in bianco e nero e all’inquadratura diegetica de Il confessionale subentra una vera e propria sequenza di Io confesso in bianco e nero (la sequenza che Hitchcock sta girando in quel momento nella chiesa): lo “sguardo” di Hitchcock si sostituisce allo “sguardo” del regista di Il confessionale senza soluzione di continuità con un complesso effetto metacinematografico.
La produzione cinematografica di Lepage, in particolare Il confessionale e Polygraphe, è basata sulla ricerca di una verità mai garantita, sempre pronta a contraddirsi: i personaggi delle sue opere filmiche e teatrali sono contraddistinti da una personalità contraddittoria, sfaccettata, che fa dubitare continuamente della loro buona fede, della loro innocenza o colpevolezza, della veridicità delle loro confessioni. Allo stesso modo il fascino e l’interesse dell’opera hitchcockiana, come hanno sottolineato per primi Eric Rohmer e Claude Chabrol nel saggio dedicato al regista inglese , consiste proprio nel saper creare figure ambigue, che spesso caricandosi della colpa di delitti altrui, divengono essi stessi colpevoli (un esempio per tutti il prete protagonista di Io confesso).
Nota Antonio Costa nell’introduzione al libro di Rohmer e Chabrol che i nuclei narrativi e tematici al centro dell’opera hitchcockiana sono il transfert di colpa, la confessione, la tentazione della perdizione e il sospetto (tutti temi presenti ne Il confessionale e Polygraphe) e l’inevitabilità del passato che riemerge (si vedano a questo proposito i film hitchcockiani La donna che visse due volte, 1958, e Marnie, 1964) .
In Lepage un movimento a spirale anima il teatro da un lato e il cinema dall’altro: motivi visivi (la scacchiera, il muro, il ponte…) e tematici (il viaggio tra Oriente e Occidente, il plurilinguismo, la specularità all’interno di una coppia di personaggi spesso legati da affetto fraterno) tipici della sua produzione teatrale ritornano nei film, mentre dal medium cinematografico Lepage accoglie uno spregiudicato modo di trattare il tempo e di ravvicinare, mediante un’operazione di montaggio, epoche e luoghi diversi (in una stessa scena è possibile assistere alla compresenza di più luoghi e livelli temporali di volta in volta illuminati, “inquadrati” grazie all’introduzione del video).
L’opera teatrale di Lepage che più di ogni altra intrattiene legami formali, tematici e soprattutto strutturali con Il confessionale è sicuramente I sette rami del fiume Ota (Les sept branches de la rivière Ota, 1994-1996), concepito del resto negli stessi anni in cui fu elaborato e girato il film.
E’ un’opera complessa con un andamento centrifugo a “mandala” che trova il suo cuore geografico e temporale nell’Hiroshima dilaniata dalla bomba atomica nel 1945 e che segue la vita di sette personaggi legati fra loro da rapporti di parentela nel corso di un cinquantennio tra Hiroshima, New York, Osaka, Terezin, Amsterdam.
I due personaggi principali motore dell’azione sono, come ne Il confessionale, due fratelli , che inizialmente ignorano di esserlo, chiamati entrambi Jeffrey: si incontreranno per caso a New York ormai adulti e scopriranno di avere avuto lo stesso padre Luke O'Connor, grazie ad una fotografia (la verità verrà letteralmente “alla luce” dopo il processo di sviluppo della fotografia).
Proprio come ne Il confessionale, dove l’unica testimonianza che Marc adulto ha della sua infanzia è rappresentata da una foto del suo battesimo, traccia di un passato destinato altrimenti all’oblio.
Uno dei simboli de Il confessionale è il ponte (ne I sette rami del fiume Ota sono presenti due ponti che attraversano il fiume, ricostruiti subito dopo essere stati distrutti dalla bomba atomica): il film infatti inizia e finisce con immagini del Pont de Québec. Il ponte, «legato al tema della sessualità, della fecondazione, della rigenerazione» , assurge così a simbolo di una separazione spaziale, che infine però congiungerà luoghi e tempi altrimenti non collegati.
Forse un indiretto invito di Lepage a superare i particolarismi che lacerano anche la sua Regione a favore di una contaminazione culturale che arricchisca il singolo individuo e insieme la comunità.
I personaggi dello spettacolo viaggiano, come Marc e Pierre de Il confessionale, fra Oriente e Occidente, per ricostruire le proprie origini, affrancarsi dal loro passato o trovare risposta ai propri interrogativi morali e interiori.
Ma è soprattutto nel modo di trattare i salti temporali, l’emergere confuso di sprazzi di memoria che irrompono nel presente senza transizioni sintattiche, come a ricalcare il processo mentale di improvviso ritorno di immagini rimosse, che I sette rami del fiume Ota non può non ricordare il procedimento di montaggio che è alla base de Il confessionale: Béatrice Picon-Vallin sostiene infatti che il vero tema dello spettacolo (un vero e proprio “prototipo del genere videoteatrale) è appunto, il “trattamento della memoria”.
lepage porta con disinvoltura sulla scena teatrale un montaggio parallelo di tipo cinematografico grazie anche all’introduzione del video: la scenografia, che ad un primo livello ricostruisce la tipica casa giapponese formata da porte scorrevoli semi-trasparenti è composta in realtà da sette pannelli di spandex che oltre ad “inquadrare” i personaggi, isolandoli dal resto dell’azione, fungono da schermi di proiezione. In questo modo la scena può ospitare contemporaneamente luoghi ed epoche lontane fra loro proprio come ne Il confessionale uno stesso piano-sequenza accoglieva e metteva in relazione significante il 1952 e il 1989, il Québec e il Giappone.
Tutte le transizioni temporali ne Il confessionale sono innestate da una unità di luogo: Lepage usa lo spazio come veicolo per viaggiare liberamente tra presente e passato, in questo caso tra il 1952 e il 1989 che spesso coesistono in una stessa inquadratura. Abbracciando il tempo e lo spazio, la mobile cinepresa di Lepage giustappone il “qui ed ora” al “là ed allora” come può fare un regista teatrale che si muove tra molteplici scenari mediante illuminazione alternata.
In una sequenza del film vediamo l’amante di Marc anziano nel 1989 che sale le scale dell’albergo. La macchina da presa segue il suo ascendere lungo la rampa delle scale, ma fra un piano e l’altro il personaggio si trasforma in se stesso da giovane, quando era ancora prete, colto nell’atto di salire le scale della chiesa. Lepage inganna l’occhio dello spettatore poiché assistiamo ad un falso piano sequenza: all’altezza del pavimento che divide le due rampe di scale (momento in cui avviene lo scarto temporale apparentemente fluido) c’è un impercettibile stacco nel montaggio.
L’appartamento del padre dove Pierre è tornato rappresenta l’inevitabile persistenza della memoria, indicata dai vuoti quadri scoloriti sulla parete dove un tempo c’erano le fotografie di famiglia. La parete diviene nel film un diaframma permeabile su cui emergono in dissolvenza sequenze legate al passato dei personaggi.
A livello visivo ricorre il motivo del paravento tipico delle culture orientali: come ne I sette rami, così anche ne Il confessionale l’appartamento in Giappone dove si ucciderà Mark è formato da pannelli scorrevoli suddivisi in caselle rettangolari (un richiamo alla grata del confessionale) che incorniciano i personaggi.
Nelle scene ambientate in Giappone de I sette rami del fiume Ota, Lepage adotta un’illuminazione in controluce che appiattisce i personaggi rendendoli nere sagome bidimensionali che ricordano il teatro d'ombre orientale; ritroviamo lo stesso procedimento ne Il confessionale, in particolare nella sequenza della sauna in cui i personaggi, inquadrati dall’alto e immersi in nel vapore giallo, divengono silhouettes evanescenti, e nella sequenza ambientata nell’appartamento di Pierre dove una luce posta in basso in primo piano proietta, ingranditi e deformati, i corpi dei due fratelli accostati alla parete.
Come ogni suo spettacolo teatrale, anche i film di Lepage si originano a partire da un “oggetto risorsa”, l’idea che è alla base del processo creativo, un “germe du départ” che trova corpo in un oggetto concreto in perenne trasformazione, che diventa il leit motive visivo dell’opera d’arte: «Un piccolo dettaglio nel quale ciò che nasce nel processo della creazione può rivelare in un attimo tutto quello che contiene lo spettacolo» .
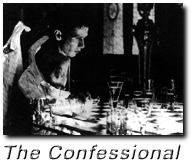
In Il confessionale assistiamo, soprattutto nell’ultima sequenza, al continuo metamorfismo dell’oggetto-risorsa intorno a cui ruota tutto il film: la parete, che grazie ad un elaborato sistema di sovrimpressioni si trasforma in schermo cinematografico, grata del confessionale e vasca da bagno.
In montaggio parallelo sono sintatticamente e semanticamente accostati il suicidio della madre di Mark nel 1952 a Québec, il suicidio di Mark nel 1989 in Giappone, e Pierre nella sua abitazione di Québec.
Hitchcock ha appena finito di girare una sequenza di Io confesso nel 1952 e dice all’operatore “cut!” (“taglia!”); con uno stacco torniamo in Giappone dove Mark si sta tagliando le vene nella sua vasca da bagno. Sull’immagine della vasca oramai divenuta rossa di sangue, germina per sovrimpressione il corpo privo di vita della madre di Mark che si è uccisa nel 1952 nello stesso modo del figlio. In un ennesimo salto temporale e spaziale la macchina da presa si sposta nella casa di Pierre nel 1989: Pierre è seduto su una poltrona posta di fronte a un televisore che dà le spalle alla parete verniciata di blu. Fuori campo si sentono le voci e i rumori di Io confesso. Durante una carrellata in avanti, che si avvicina a poco a poco alla parete, si sente fuori campo Pierre che risponde al telefono apprendendo la notizia della morte di Mark. Il rumore del suo pianto si sovrappone alla musica finale di Io confesso, mentre sulla parete ormai inquadrata a schermo intero con un procedimento di chroma key emerge l’ultima inquadratura di Io confesso con la scritta “The end”. A questo punto assistiamo ad un ritorno al 1952, proprio nel momento in cui gli abitanti di Quebéc City assistono, in una sala cinematografica, alla prima proiezione pubblica di Io confesso.
Che la sequenza di trasformazioni inizi con un suicidio nell’acqua, utero materno e dunque insieme morte e rinascita , e si concluda con lo schermo cinematografico che mostra il film ormai compiuto dopo una lunga gestazione, mi spinge a pensare che Lepage veda nell’arte l’unico veicolo per indagare sulle proprie radici e insieme fuggire la mortalità.
Il film di Lepage riflette sulle necessità di scoprire se stessi, e quindi rinascere, attraverso la ricerca delle proprie origini: è necessario fare i conti con il passato personale e con la storia del proprio paese e questo è possibile solo cercando uno specchio e solo confrontandosi con il diverso da sé.
Oltre che dal punto di vista contenutistico anche da quello formale, Lepage, adotta una compresenza di vari stili e linguaggi sempre tesi alla ricerca di una unitarietà che si origini dalla différence.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Possiamo fare dei robot, possiamo creare la vita
Incontro (doppio) con Marcel.lì Antunez Roca
di Anna Maria Monteverdi
Proponiamo suddiviso in brevi frammenti tematici il testo di alcune conversazioni e conferenze inedite di Marcel.lì Antunez Roca realizzate nell’aprile 2005 in Italia (a Cascina, alla Città del teatro, e alla Spezia, all'auditorium Dialma Ruggiero) coordinati da Giacomo Verde e Anna Maria Monteverdi per le associazioni Zonegemma e Cut up.
Il titolo di questi appunti sul lavoro dell'artista catalano non è altro che la frase con cui Marce.lì ha congedato il pubblico spezzino e che ricorda, attualizzata all'epoca tecnologica, l'invito di Hobbes nel Leviatano a “fare un uomo nuovo”, a sessant'anni esatti dalla comparsa del primo computer.
Marcel.lì Antunez Roca in queste occasioni ha raccontato il suo lavoro a partire dagli anni Novanta mostrando contestualmente immagini proiettate dal suo computer; l’attenzione era focalizzata sui “temi topici” delle sue installazioni, bioscuture e performance tra cui il rapporto tra biologia e tecnologia, tra cultura e mitologia e l'uso di robot ed esoscheletri, soffermandosi sul nuovo spettacolo Transpermia, realizzato a seguito di un’esperienza molto particolare a gravità zero condotta nell’ex Unione Sovietica, al Centro Aereospaziale Yuri Gagarin Cosmonautic presso la Città delle Stelle a sessanta chilometri da Mosca per il progetto Dedalus (2003). L’esoscheletro gli permette in questo caso di agire sullo schermo animando gli straordinari disegni a cartoon che raccontano un futuro non lontano fatto di incredibili interfacce organiche che ci permetteranno di mutare a nostro piacimento non solo il sesso, ma anche il genere (da umano ad animale a vegetale) aumentando percezioni e sensazioni, tornando infine al luogo utopico d'origine: lo spazio..
Il programma consente inoltre al performer anche di modificare e modulare la propria voce e i suoni, dando dimostrazione concreta di una mutazione tecno-antropologica già in atto.
DOPO LA FURA
Ho lavorato negli anni Ottanta con il gruppo spagnolo Fura dels Baus come coordinatore, attore e musicista; questo ha rappresentato una parte importante del mio lavoro che era nato dal collettivo con una metodologia aperta e che si trasformava pian piano con la discussione, con la sperimentazione anche in rapporto col pubblico; la Fura oltrepassa la seconda avanguardia degli anni Settanta e Ottanta con una visione più spettacolare degli altri gruppi, mescolando la musica di quel momento, industriale e noise, con una reinterpretazione del teatro di strada ma dentro spazi chiusi, industriali, vecchie fabbriche riusate appositamente per uno scopo artistico. Sono uscito dalla Fura agli inizi degli anni Novanta e da allora ho fatto molte cose; è stato per me un periodo fertile ma a trent'anni ho dovuto ricominciare la mia carriera da zero. Le cose che ho fatto all’inizio di questo eprcorso senza la Fura, dal 1990 al 1994 sono sculture, facce ricostruite con carne di maiale; sviluppavo poi il tema della dipendenza, della macchina di piacere che sono stati alcuni dei temi delle mie opere successive.
JOAN UOMO DI CARNE
Nel 1992 ho sviluppato un robot Joan uomo di carne; è una figura a scala umana 1:1, un robot ricoperto di carne di maiale che ha la capacità di interagire con il pubblico e quando il pubblico gli parla lui si muove con un sistema di “cattura di suono” di tipo analogico, attraverso un microfono e poi il suono è convertito in segnale midi; è un lavoro molto interattivo e molto particolare nel mio percorso iniziale: senza l’informatica questo lavoro non ha alcun senso, il computer è imprescindibile; il computer donava la vita attraverso la voce dello spettatore e attraverso la macchina, e la macchina allo stesso tempo diventava un meccanismo di relazione.

Joan che è stato installato in spazi pubblici, al Mercato della Boqueria, vicino alla Ramblas a Barcellona, muove la testa e il braccio e un po’ anche il pene con il suono acuto delle donne che si avvicinano; e più le donne ridono più la situazione diventa molto divertente. Talvolta anzi, è più interessante il pubblico della scultura!
Da quel momento in poi il mio lavoro si è sempre basato sul computer, con il dressskeleton che è un sistema capace di leggere il movimento corporale e che ha diversi interruttori che servono per controllare una situazione ipermediale.
INTERFACCE CORPORALI: Epizoo, Requiem, Afasia.
Una delle forme che ho sviluppato e perfezionato dal 1998 a oggi è un' interfaccia corporale di natura esoscheletrica, il “dresskeleton”, già sviluppato dalla robotica dagli anni Cinquanta e che io uso come fosse un dispositivo, uno strumento per raccontare storie. Il dressskeleton diventa il ponte che connette il corpo con la macchina Il performer oltrepassa la sua posizione classica di attore e diventa anche un po’ danzatore e collega il suo movimento con quello che fa la macchina.
Afasia (1998), è stato realizzato con il primo prototipo di dresskeleton per il controllo delle immagini dello schermo alle mie spalle.

All’estremo opposto c’è un esoscheletro “parassita” che non fa la stessa cosa del dresskeleton diciamo così amplificare la possibilità della gestualità- ipermedia- fino a quando diventa un robot che controlla il corpo. Epizoo e Requiem sono due macchine con una motivazione diversa. Epizoo è una macchina fatta inizialmente per muovere la parte sessuale del corpo, un’ortopedia basata sull’idea della sessualità, del rapporto tra sesso e potere. Il robot è diventato anche una performance più complessa, una macchina che sta tra il confine tra piacere e dolore.
Epizoo è questo esoskeleton robotico che muove il mio culo e il mio busto le mie orecchie ed è stato fatto per costruire una “macchina sessuale” per controllare corpo e sessualità.

Questa macchina e il sistema sono controllati da un mouse a sua volta controllato dallo spettatore che diventa protagonista come torturatore.
Requiem che è stato fatto per la mia esposizione Epifania, ha la forma di un’installazione; è una macchina basata sulla tema, sull’idea della morte ed è diventata una forma di scrittura scenica e coreografica perché con i suoi 19 gradi di movimento robotico poteva diventare un vero coreografo. Il corpo recupera la vita grazie a questa specie di sarcafago meccanico che ha la possibilità di muoversi fino a 19 gradi. Requiem è una macchina che mi ha fatto scoprire una via non immaginata prima: diventa una macchina per scrivere gesti, una macchina in qualche modo per coreografare, in quanto la gestualità, la coreografia sono state finora legate alla tradizione orale, c’è un coreografo che spiega come muoversi ma non c’era una maniera per scrivere come fare.

Questa macchina poteva essere usata per quello scopo. Lo scorso anno è stato in molti festival di danza per questo motivo.
Sono molto interessato ai robot che sono una parte, un’estensione del mio discorso performativo-artistico; ho lavorato con Sergi Jordà e Roland Olbeter, un ingegnere tedesco che abita a Barcellona da Joan fino oggi; lui si è occupato sempre di disegnare precisamente e interpretare la mia idea di forma di robot. In Afasia ho sviluppato il lavoro con il suono, sono collegato in forma interattiva al dresskeleton grazie al quale i movimenti del corpo sono convertiti in istruzioni per il computer e collego il suono di chitarra, cornamusa al dresskleeton; posso modificare in diretta immagini proiettate sullo schermo, suoni e robot. Per l’attore diventa un nuovo modello e un nuovo modo di stare in scena perché mescola sia l’idea del manipolatore di marionetta sia quella di attore che sta raccontando le storie e anche quella di danzatore. In Afasia attraverso il dressskeleton, il narratore usa tutti i media per raccontare un mito, l’Odissea.
SISTEMATURGIA
Parlo del mio lavoro come di sistematurgia, una drammaturgia che ha bisogno della informatica, una drammaturgia basata sul principio della gestione della complessità del computer. La sistematurgia è fondamentalmente un processo interattivo che indaga attraverso nuovi prototipi, un arco di mediazione che include l’interfaccia, il calcolo e i nuovi mezzi di rappresentazione. Non è un teatro-video in cui si vedono immagini che sono state fatte prima e che si sviluppano in maniera sequenziale. La sistematurgia sta al servizio di una narrazione, di un racconto, di un organismo teatrale ma lo fa in maniera interattiva usando uno strumento ipermediale.
BIOSCULTURE
La biologia è un sistema e mi sembrava una buona idea metterla nello stesso livello concettuale di un sistema informatico e della drammaturgia. Ho una storia biologica mi segue; lo scorso anno ho preparato un “esoscheletro” sopra cui era inscritto un poema catalano:
“Se quando sto dormendo ti vedo chiaro, sono matto di una dolce veleno”.
Allora lo scheletro, ricoperto di carne è messo dentro l’interno di una vetrina dove c’è un sistema biologico naturale di decomposizione, ci sono funghi e batteri che fanno decomporre la carne, e la telecamera filma tutte le “fasi storiche” di questa decomposizione, e la carne sparisce e si legge il poema. Ogni giorno questa bioscultura se ne va; è una bioinstallazione dove la carne diventa materia biologica in decomposizione. Ci vuole un mese di tempo per la decomposizione.
TECNOLOGIA E BIOLOGIA
Sono interessato all’idea della biologia. Non è un paradosso. La tecnologia e la biologia sono due percorsi paralleli; io sono convinto che la cultura è un processo biologico e la tecnologia è la conseguenza di questa forma culturale che alla fine diventa un mondo complesso con regole molte volte vicinissime a quelle della biologia.
Un mio lavoro fatto nel 1987 consisteva in pitture vive che mostrano decomposizioni: pollo, carota e pesce che si stanno decomponendo. Nel nuovo museo della scienza Barcellona c’è una replica di un mio lavoro del 1999 che non sono altro che sculture biologiche che col tempo si decompongono, una colonna di un metro e settanta piena di fango e acqua con un ecosistema che va cambiando sempre, che si alimenta con la luce e ogni mese ha un colore diverse rimanendo sempre vivo. Io ho una colonna dal 1999 nel mio studio, una colonna vivente come la chiamo io.
TEMI TOPICI
La vulnerabilità del corpo, la sessualità, il cibo, il desiderio, la maternità, il genere umano, il gioco, la salute, la metamorfosi, il simulacro, la chimera, la famiglia, il clan, l’utopia, la sincope, il folclore, l’idea di sacrifico, l’estasi, la protesi, l’istinto, il tatto e la fabula.
PROGETTO LA CITTA’ DELLE STELLE
Nel 2003 ho avuto la fortuna di essere invitato da Catalyst, un’organizzazione nata in Inghilterra per fare esperienze in gravità zero. Questa associazione è specializzata nel far progetti sull’arte e la scienza e dal 2000 al 2003 hanno fatto tre campagne in cui hanno portato artisti alla Città delle stelle in Russia e li hanno messi in un aeroplano per sperimentare la gravità zero e la doppia gravità. C’è una macchina preparata per fare un volo di parabola a gravità zero.
La parabola serve per istruire i cosmonauti, ed è stata disegnata e inventata per i sovietici e oggi è usata dalla Nasa e dall’Agenzia europea dell' Aereonautica.
Là c’era la replica della Mir che serviva per le prove di fluttuabililtà, per le prove dell’attività extra veicolare. Ho portato il mio staff, esoscheletro, schermi; siamo stati due giorni.Siamo stati invitati a partecipare a questa storia incredibile. Ci siamo visti all’inizio di aprile del 2003. Io ho avuto la fortuna di fare due voli diversi, 6 parabole nel primo e 19 nel secondo e mettere dentro tutta la mia esperienza più recente, il dresskeleton sviluppato per Pol e Requiem; abbiamo avuto l’idea di usare il movimento involontario del corpo che rimaneva collegato con lo schermo che è dietro. Abbiamo fatto questa esperienza due volte. Il primo giorno abbiamo realizzato microperformance di 30” ognuno con esoscheletro e schermo con immagini. Mi muovevo ma non aveva senso il movimento perché quando il corpo va in gravità zero prende una nuova dimensione di movimento senza bisogno di muovere niente; così abbiamo seguito un’altra strategia il secondo giorno. Abbiamo deciso di usare gli strumenti in modo diverso. L’esperimento con dresskselton questa volta prevedeva la presenza di uno degli istruttori, Boris che mi faceva muovere. Il periodo della gravità zero comincia dall’aereoporto militare con un volo che dura un’ora e mezza; l’aereo va a 6000 metri di altezza, fa una parabola di trenta secondi fino a 8000 metri e si lascia cadere poi va di nuovo a 6000 metri, tutto in un minuto e mezzo
Nei trenta secondi di doppia gravità senti i polmoni e il fegato che si comprimono e dopo c’è la gravità zero che significa perdita della autopercezione con cambio della pressione sanguigna, una nuova realtà dimensionale per tornare alla microgravità. In questa città delle stelle hanno sviluppato l'idea assurda di portare la vita fuori della biosfera e dopo queste esperienza ho pensato alla costruzione di un progetto che parlasse del portare la vita all’esterno attraverso un mezzo artificiale.
TRANSPERMIA-PANSPERMIA INVERSA
Portare la vita nello spazio mi ha fatto ricordare un’idea che spiega l’inizio, l'origine della vita nel nostro pianeta: la teoria della panspermia. Probabilmente comete e asteroidi sono venuti dalla stelle con materia biologiche batteri e spore hanno fatto crash sulla terra ed è uscita la vita 3600 milioni di anni fa e così ha inizio l’evoluzione biologica. La cultura in questo processo biologico fabbrica gli astronauti che ritornano allo spazio, all’esterno una nuova volta. La panspermia che ha portato la vita ritorna allo spazio attraverso una nuova panspermia inversa che io chiamo transpermia. L’utopia per me è di permettere a tutti, non solo ai cosmonauti e ai militari di andare nello spazio.
Il mio progetto Transpermia è dove abita questo prototipo dell’utopia.

 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Arte contemporanea allo scoperto
J. Fabre, The Shelter (For the Grave of the Unknown Computer); O. Mocellin e N. Pellegrini, Le cose non sono quelle che sembrano
di Anna Maria Monteverdi
Parco d'Arte Contemporanea La Marrana (Sp)
2 - 31 luglio 2005
Orario di visita: sabato e domenica dalle 18 alle 22

Gianni e Grazia Bolongaro amano l'arte al tal punto da aver fatto del loro smisurato e meraviglioso Parco (e annessa Villa) con vista sul fiume Magra dalle colline di Montemarcello della Spezia, un Museo all'aperto d'arte ambientale con le opere permanenti site specific, concepite in armonia con il luogo e con il paesaggio; opere che si lasciano attraversare dalla luce del sole, dall'aria, dal vento; opere da ascoltare e dentro cui immergersi. Con la mostra dedicata nel 1997 a Hossein Golba, è iniziata l’attività di La Marrana arteambientale, proseguita poi con le mostre di Kengiro Azuma (1998), Luigi Mainolfi (1999), Philip Rantzer (2000), Mario Airò e vedovamazzei (2001), Magdalena Campos-Pons, (2003), e le installazioni/sculture di Lorenzo Mangili, Jannis Kounellis, Josef Kosuth, Lucia Pescador, Cecilia Guastaroba, Quinto Ghermandi.
Ultime - solo in ordine di tempo - le installazioni: Le cose non sono quelle che sembrano di Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini e Il rifugio (per la tomba del computer sconosciuto) di Jan Fabre curata da Giacinto Di Pietrantonio, direttore del Gamec di Bergamo. L'eclettico artista fiammingo legato alle arti visive (compreso lo spettacolo) ha proposto per l'occasione un'opera straordinariamente ispirata e intensa in forma di capanno di pietra contenente all'interno sette lucerne e grandi croci viola e blu Bic con inciso il nome di specie di insetti scomparse. La scheda introduttiva parla di metamorfosi come tema dell'opera. Metamorfosi che è da rintracciare nell'olometabolia degli insetti, nel passaggio cioè attraverso i vari stadi larvali o nello stesso involucro-tana dell'opera in cui la morte diventa tutt'uno con la vita ovvero con la cavità uterina che la struttura in pietra richiama.

Nell'introduzione pubblica Fabre ha parlato degli insetti come “i migliori combattenti”, dunque una tomba per il milite-insetto ignoto. Ma il computer cosa c'entra? Si può azzardare che rifugio tomba computer (e relativa memoria ad accesso remoto) siano tutti contenitori di stati di passaggio,luoghi archetipici della sospensione, dell'attesa. Limen. La comprensione profonda del tema dell'opera (la metamorfosi) avviene attraverso una soglia impercettibile ma netta se si accetta di diventare, varcando il luogo, rifugiato, interrato o forse addirittura chip passando dall'essere uomo all'essere insetto ed infine all'essere cosa. Siamo sulla soglia della skené in attesa della metamorfosi. Siamo invitati a uscire piuttosto che entrare nel catalogo dell'esistente. Stiamo trasformandoci e non ce ne accorgiamo, stiamo per diventare kafkianamente coleotteri-animali o per divenire inanimati. Per spiegare la condizione evocata dall'opera uso le parole di Deleuze-Guattari riferite alla Metamorfosi di Kafka: “Non c'è più né uomo né animale, perché l'uno deterritorializza l'altro in una congiunzione di flusso, in un continuum di intensità reversibile”. In un momento storico in cui le grandi croci richiamano i cimiteri di guerra possiamo interpretare questa decimazione degli insetti come una sorta di profezia della specie prossima votata all'estinzione, quella umana. E intendere l'opera tutta come un corpo selvaggio primitivo, che si espande e si allarga a comprendere tutto ciò che la circonda: l'ambiente, le cose, gli esseri, le piante, gli animali, le pietre in una potenzialità infinita di scambio, in un invito antico alla metamorfosi, al mascheramento, alla vita da riconquistare fieramente come insetti-combattenti contro l'omologazione del mondo.

L'opera di Mocellin-Pellegrini è un'installazione scultorea e sonora insieme che evoca i giochi dell'infanzia dei fratelli Van e Ada dal racconto di Nabokov. Ancora insetti -e relativa metafora sessuale che si evince da un gioco enigmistico: insect/incest- popolano questo lavoro in forma di panche di pietra marmorea e relativo tavolo in cui viene offerto al visitatore il gioco dello scarabeo per comporre e ricomporre enigmisticamente parole. Attraverso casse acustiche viene sussurata al giocatore la storia d'amore interpretata in forma di dialogo da Ottonella e Nicola. In una vicina altalena ancora giochi di parole incise ma soprattutto una possibilità, dondolandosi, di ascoltare frammenti della storia, attivati grazie a fotocellule.
www.lamarrana.it
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Factory a luci rosse
Tutto quello che avreste voluto sapere sulla Factory di Andy Warhol di Mary Woronov (Meridianozero)
di Anna Maria Monteverdi
Coraggiosa e in fuga, Meridianozero di Padova non ha fatto solo incetta di straordinari autori noir consegnandoli al mercato italiano con una grafica elegante e d’impatto; ha anche pubblicato due volumi immancabili per chi ama l’atmosfera underground degli anni Sessanta a New York, Warhol e i Velvet di Lou Reed. Uno è l’edizione italiana di quel capolavoro che è Popism, Warhol's 60s, l’autobiografia di Warhol scritta con Pete Hackett. Il libro parla dell'attività cinematografica della factory e della quotidianità con artisti come Bob Dylan, Rudolf Nurejev, Norman Mailer, Jimi Hendrix, Tim Buckley, La Monte Young, Bob Rauschenberg, Jim Dine e termina con il ricordo della morte per overdose dell'attrice Edie Segdwick e con il sintetico messaggio in un “post” con cui il fotografo Bill Name annuncia l'abbandono della Factory. Molte cose cominciano a cambiare già dal 1969. Hollywood si interessa ai lavori di Warhol; la Columbia picture gli chiede di girare film in 35 millimetri. La Factory viene disertata. Paul Morrisey inizia le riprese di Trash e Urban Cowboy con un cast che viene così descritto nelle ultime righe del libro:
“Il cast era un nuovo, più giovane gruppo di ragazzi postpop, come Jane Forth, sedici anni. Tutta la moralità e le retsrizioni contro le quali le prime superstar della Factory avevano combattuto erano così lontane e irreali come può sembrare oggi l'epoca vittoriana. Il pop non era un argomento per questa nuova ondata: era tutto quello che non avrebbero mai conosciuto”.
L’altro libro edito da Meridianozero è Swimming Underground (My years in the Warhol Factory), tradotto Tutto quello che avreste voluto sapere sulla Factory di Andy Warhol e non avreste mai osato chiedere, di Mary Woronov, attrice, scrittrice e giornalista.

Il libro racconta “l’altra faccia della Factory” descritta proprio dall’attrice di alcuni storici film di Warhol (Chelsea Girl, Four Stars) nonché protagonista di Exploding Plastic Inevitable e tra le presenze (minori) femminili della Factory dove spiccavano Viva, Ultraviolet, Ingrid Superstar, International Velvet. Una carrellata che mette in chiara luce gli aspetti violenti, sadici e impudici della vita della Factory intorno al 1966, prima dell’attentato a Warhol da parte di Valerie Solanas ma che ne accentuano se possibile, il mito. Il libro racconta l’iniziazione di Mary, icona androgina, alla Factory: alta, magrissima, pantaloni di pelle nera aderenti e che si esibiva in coppia con Gerard Malanga in numeri sadomaso tra luci stroboscopiche mentre i Velvet Underground suonavano Venus in Furs o Heroin. Tra lesbiche, travestiti, trasgressioni sessuali di ogni tipo, anfetaminie, speed e acidi che portarono anche alla morte alcuni loro amici, spiccano primi piani di Ondine (il Papa in Chelsea Girl) che si infila un ago pieno di eroina in un occhio, la Duchessa che registra le sue telefonate con Warhol, Bill Name, il fotografo che si fa murare vivo dentro una stanza della Factory, Lou Reed che racconta dei guaritori filippini, Nico perennemente in posa. Tutto intorno gli avventori della Factory descritti come “ragazzotti apatici che ciondolavano aspettando qualsiasi cosa” seduti su divani argentei macchiati costantemente di sperma, consumando droghe o sesso in occasione dei vari party. Personaggi ritratti nel libro come una corte dei miracoli, “parassiti o tappezzeria” - come afferma causticamente la Woronov - che si muovevano in branco in taxi dal Dom nell’East Village al Max’s Kansas City. La Factory era il luogo dove Warhol con gli screen test faceva guardare per un quarto d’ora nella cinepresa regalando il sogno dell’immortalità a sconosciuti. Ma dentro la Factory fecero fugaci apparizioni anche Salvator Dalì, Tennessee Williams e Allen Ginsberg. Più che un racconto della Factory, il libro è un andare e venire della memoria di Mary, prima bambina maschiaccio al mare che vuole emulare i cugini nuotando al largo, poi ragazzina violenta che al college picchiava le compagne; dopo ancora, sverginata da un cameriere, in viaggio alla conquista della swimming New York, convinta da Gerard Malanga suo pigmalione, contro il volere della borghesissima famiglia; insegue poi il suo impossibile sogno d’amore con Ondine, in seguito scritturati entrambi per film underground e per piéces di teatro sperimentale (per la regia di John Vaccaro); caustica nel raccontare le abitudini sessuali, l’abuso di droghe e le trasgressioni di uomini e donne della Factory (a cominciare da lei stessa) che speravano di entrare nelle grazie di “Drella” e ottenere una scrittura da Hollywood, Mary ne ha per tutti, primo fra tutti proprio Lui:
“Andy diceva le cose più insulse; la gente ci impazziva sopra, si sentiva in dovere di leggerci i significati più reconditi, ma per noi era un’altra storia. Andy non solo era dislessico ma le parole lo mettevano a disagio (…) Quella notte Andy era impegnato a disegnare nasi, prima e dopo la chirurgia plastica. Quando mi chiese se mi piacevano, non risposi. A che pro? Tanto sapevo che quello stupido disegno sarebbe stato serigrafato da qualche parte e venduto a carissimo prezzo mentre a me veniva da staccarmelo il naso, quando pensavo ai miei rabbiosi disegni in bianco e nero”.
Ma le donne della Factory sono tra le sue mire preferite:
“Mentre Velvet finiva la sua bottiglia di vodka, un po’ troppo avidamente per una ragazza di buona famiglia, io scrutavo le altre due attrici. Ingrid Superstar si impasticcava, anche se non ne aveva bisogno, era già fuori di suo; Pepper invece era una nuova. Nessuno sapeva di che cosa si facesse, o chi l’avesse portata lì. Non sembrava messa troppo bene, una sorta di cavolo che sta andando a male, sicuramente una mina vagante”.

Ma soprattutto Mary racconta con orgoglio il momento in cui il popolo notturno dagli occhiali scuri, le “talpe”, l’aveva ammessa nel sacro recinto. Da cui uscì solo per entrare in una clinica per disintossicarsi; ebbe il tempo di vedere un triste Ondine mentre presentava in un college Chelsea Girl raccontando alla nuova generazione la vita della Factory. Due anni esatti prima della sua morte. Completano il libro alcune straordinarie fotografie di Bill Name.
E' scomparsa Valeria Moriconi
Una delle ultime primedonne del nostro teatro
di Redazione ateatro
E’ mancata il 15 giugno, nella sua casa di Jesi, nelle Marche, dove era nata nel 1931ce Valeria Moriconi, una delle ultime primedonne della scena italiana, protagonista di centinaia di spettacoli teatrale e decine di film nell’arco di una lunga carriera.

Valeria Moriconi nella Nemica di Dario Niccodemi (foto Tommaso Le Pera).
Aveva dovuto interrompere per motivi di salute la tournée di Spettri di Ibsen.
Valeria Abbruzzetti (questo il suo nome) aveva debuttato nel 1949 nella sua città, in una Filodrammatica e due anni dopo si era sposata con Aldo Moriconi, dal quale si sarebbe separata alcuni anni dopo. Si era poi trasferita a Roma, dove era stata notata da Alberto Lattuada, che nel 1953 l’aveva fatta debuttare al cinema in Gli italiani si voltano, nell'episodio Amori in città, e ne La spiaggia (1953), dove una scena in cui compariva in due pezzi suscitò una interrogazione parlamentare della DC.
Al cinema è stata diretta, tra l’altro da Yves Allègret, in Gli anni che non ritornano (1955) con Gérard Philipe, Marc Allègret, Mauro Bolognini in Guardia, guardia scelta, brigadiere e maresciallo (1956) e Gli innamorati (1955), dove ottenne la nomination al Nastro d'Argento per il ruolo della pantalonaia Marisa, Mario Mattoli in Miseria e nobiltà, con Totò, Valerio Zurlini (Le soldatesse (1966), che le valse la Grolla d'Oro), Nanni Loy in Un giorno da leoni e in Quelle strane occasioni nell'episodio Italian Superman.
In teatro, la svolta era arrivata nel 1957, quando era stata in scena con Eduardo in De pretore Vincenzo; Eduardo l’aveva voluta anche per ricoprire il ruolo che era stato di Titina in Chi è più felice di me (nel 1986 sarà Filumena Marturano con la regia di Egisto Marcucci).
Nel 1969 è Mina nella scandolosa Arialda di Visconti; nello stesso anno conosce Franco Enriquez e inizia il sodalizio umano e artistico più importante della sua carriera: danno vita alla Compagnia dei Quattro (assieme a Mauri e Scaccia) che tra il 1961 e il 1964 porta in scena tra l’altro Il gesto di Codignola e La bisbetica domata (1962); Andorra di M. Frisch, Niente per amore di O. Del Buono (1963); Edoardo II di Brecht-Marlowe, Il vantone di Pasolini (1964), Il mercante di Venezia (1967), Rosencrantz e Guildertern sono morti (1968), Le mosche (1968), La tragedia di Macbeth (1971). Le regie di Enriquez saranno numerose anche in seguito: da Il vangelo secondo Borges (1972) e Storie del bosco viennese di O. von Horvath (1977) a L'hai mai vista in scena di Fabbri (1979).

Valeria Moriconi nel Diario di Eva da Mark Twain (foto Tommaso Le Pera).
Attrice versatile, eclettica e curiosa, Nel corso della sua carriera ha lavorato con numerosi registi, spaziando dai classici alla drammaturgia contemporanea, dal monologo al musical, dalla commedia brillante alla riscoperta curiosa: De Bosio (I dialoghi del Ruzante, 1968), Castri (con una collaborazione particolarmente significativa, da La vita c
Numerosi riconoscimenti: i Premi Ubu per Hedda Gabler e Turandot (1981), per Emma B. vedova Giocasta (1982), Premio Duse nel 1995. Dura invece poco la sua esperienza come direttore del Teatro Stabile delle Marche, che abbandona quasi subito con qualche polemica.
Intensa anche l’attività radiofonica e televisiva: per il piccolo schermo ha interpretato tra l’altro Pigmalione (1962), La bisbetoica domata (1963), Resurrezione (1965), nei panni di Katiuscia, La presidentessa (1968) ed è stata la protagonista della seconda parte del Mulino del Po (1971).
Il Premio Tuttoteatro.com 2005: il bando
Scandenza: 26 agosto
di Tuttoteatro.com
PREMIO TUTTOTEATRO.COM ALLE ARTI SCENICHE
“DANTE CAPPELLETTI” 2005 - seconda edizione
Nato lo scorso anno dalla necessità di raccogliere e segnalare quanto agita e rende viva la scena contemporanea, il Premio Tuttoteatro.com – "Dante Cappelletti" giunge alla seconda edizione forte dell’eterogeneità di progetti che hanno lasciato dialogare gruppi affermati e realtà emergenti. Vincitore nel 2004, tra 138 candidati, il giovanissimo ensemble di Narramondo che in A.V. ha saputo imporre la scelta tematica, la bravura delle interpreti e l’efficacia del montaggio drammaturgico. Il lavoro compiuto sarà presentato in anteprima a Roma, in una nuova e proficua collaborazione con Zone Attive, nell’ambito del festival Enzimi, a settembre. Due le segnalazioni speciali del concorso, ideato e diretto da Mariateresa Surianello - dall’originale realtà di Maurizio Rippa alla scrittura contemporanea di Dionisi Compagnia Teatrale – che hanno contraddistinto questo riconoscimento per la qualità alta ed appassionata. Quasi a sottolineare l’omaggio che la rivista telematica di teatro, danza e spettacolo www.tuttoteatro.com ha voluto fare intitolando alla memoria del critico toscano, studioso e maestro che si era sensibilmente impegnato per il confronto tra culture e pensieri diversi e complementari, il premio ha messo in evidenza proprio un universo artistico composito ed intersettoriale. Il bando (scaricabile sul sito della rivista e su quello dell’Eti) si rivolge, anche per questa edizione, a progetti capaci di contenere l’interdisciplinarità dei linguaggi della scena, senza limitazioni né distinzioni tra categorie o generi, nel rispetto della complessità delle arti oppure preservando la purezza di un’unica formula espressiva.
I partecipanti, cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, senza limiti di età, singoli artisti o gruppi, potranno presentare un progetto di spettacolo inedito, in forma scritta (massimo dieci cartelle), corredato da eventuale materiale fotografico, da fornire anche su floppy o cd, in otto copie.
Per la nuova selezione, tenendo presente l’alta qualità dei lavori presentati in passato, la giuria – per il secondo anno presieduta dal Sindaco di Roma Walter Veltroni e formata da Roberto Canziani, Gianfranco Capitta, Massimo Marino, Renato Nicolini, Laura Novelli, Aggeo Savioli e Mariateresa Surianello - ha deciso di ampliare il ventaglio di scelte, sdoppiando in due appuntamenti la visione e la visibilità delle proposte, in un’ottica di più concreta promozione. Intanto, la collaborazione con Armunia che, nella sede di Castiglioncello a Castello Pasquini, ospiterà la semifinale agli inizi di ottobre, nella quale saranno analizzati un massimo di venti progetti, presentati in forma di studio scenico (durata massima 15 minuti). Quindi una rosa di dieci finalisti potranno allestire il progetto in una creazione della durata massima di 20 minuti da presentare al Teatro Valle di Roma il 4, il 5 e il 6 novembre 2005.
Il premio, sostenuto da ETI - Ente Teatrale Italiano, Comune di Roma – Assessorato alle Politiche Culturali, Provincia di Roma, Comune di Piancastagnaio e patrocinato dalla Regione Lazio, assegna € 6000,00 quale contributo alla produzione al primo classificato tra tutti i progetti di spettacolo inviati, entro e non oltre il 26 agosto 2005 (farà fede il timbro postale), a Tuttoteatro.com Associazione Culturale C.P. 301 - 00187 Roma San Silvestro.
PREMIO TUTTOTEATRO.COM ALLE ARTI SCENICHE
“DANTE CAPPELLETTI” 2005 - seconda edizione
Bando di concorso
L’Associazione culturale Tuttoteatro.com ha istituito nel 2004 il Premio alle arti sceniche intitolato “Dante Cappelletti”. La seconda edizione del Premio si svolge nel 2005, con la direzione di Mariateresa Surianello.
Dedicata a Dante Cappelletti (studioso, critico teatrale e docente universitario, scomparso tragicamente nel 1996), l’iniziativa vuole ricordare l’uomo e la sua alta lezione di vita e di scienza, che ha saputo trasmettere alle nuove generazioni. In questo solco, tracciato e prematuramente interrotto, Tuttoteatro.com si impegna a promuovere, diffondere, valorizzare e sostenere lo spettacolo dal vivo e le arti sceniche nella loro complessità, nonché la ricerca e la sperimentazione dei linguaggi, attraverso la produzione di nuove opere. Senza limitazioni di genere, forma e linguaggi.
La giuria del Premio selezionerà progetti di spettacoli presentati da singoli artisti o da gruppi, i quali saranno liberi di sviluppare i propri percorsi creativi, seguendo ciascuno le soggettive necessità espressive. Non si farà distinzione tra categorie di artisti (attori, cantanti, danzatori, musicisti, artisti visivi), né si metteranno steccati tra discipline (danza, musica, parola, arti visive). Questa interdisciplinarità non dovrà necessariamente riscontrarsi nei progetti, che potranno privilegiare anche un solo linguaggio.
Ancora in questa seconda edizione il Premio cercherà di raccogliere quanto si agita e rende viva la scena contemporanea.
1. L’Associazione culturale Tuttoteatro.com bandisce per il 2005 la seconda edizione del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche intitolato “Dante Cappelletti”.
2. Al concorso possono partecipare cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari senza limiti di età.
3. Al concorso possono partecipare singoli artisti o gruppi.
4. Ai candidati è lasciata piena libertà di genere, forma e linguaggio.
5. Ai canditati è richiesta la presentazione di un progetto di spettacolo in forma scritta (massimo dieci cartelle), corredato da eventuale materiale fotografico, in otto copie. Tale progetto deve essere fornito anche su supporto informatico (floppy, cd, dvd).
6. I progetti presentati devono essere inediti e comunque mai allestiti in forma di spettacolo.
7. Qualora il progetto avesse come scopo l’allestimento di un testo drammaturgico inedito, è richiesta la presentazione del copione integrale.
8. I candidati devono compilare e firmare la scheda di partecipazione allegata con l’impegno ad accettare il presente regolamento in ogni sua parte.
9. I progetti devono essere inviati entro e non oltre il 26 agosto 2005, farà fede il timbro postale, a Tuttoteatro.com Associazione Culturale C.P. 301 - 00187 Roma San Silvestro.
10. Tra tutti i progetti di spettacolo presentati la giuria ne selezionerà un massimo di venti, che dovranno essere presentati in forma di studio scenico (durata massima 15 minuti), nel corso della fase semifinale che si svolgerà a Castello Pasquini di Castiglioncello, nella prima decade di ottobre.
11. Tra i lavori semifinalisti, la giuria sceglierà i dieci finalisti che saranno allestiti in forma di studio scenico (durata massima 20 minuti) al Teatro Valle di Roma il 4, il 5 e il 6 novembre.
12. Tra i dieci finalisti la giuria sceglierà l’opera vincitrice, alla quale andrà un premio di 6.000,00 euro quale contributo alla produzione. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 6 novembre 2005, al Teatro Valle di Roma.
13. All’opera vincitrice è fatto obbligo di citare in tutti i materiali promozionali, nulla escluso, e in ogni futura rappresentazione il riconoscimento ottenuto: «Vincitrice del Premio Tuttoteatro.com “Dante Cappelletti”».
14. La giuria ha inoltre la facoltà di segnalare altre tre opere tra le dieci finaliste. A queste tre opere è fatto obbligo di citare in tutti i materiali promozionali, nulla escluso, e in ogni futura rappresentazione il riconoscimento ottenuto: «Segnalato al Premio Tuttoteatro.com “Dante Cappelletti”.
15. Qualora le opere finaliste, ad esclusivo giudizio della giuria, risultassero di particolare valore l’Associazione Tuttoteatro.com promuoverà la loro circuitazione sul territorio nazionale e internazionale.
16. La giuria della seconda edizione, presieduta dal Sindaco di Roma Walter Veltroni, è composta da Roberto Canziani, Gianfranco Capitta, Massimo Marino, Renato Nicolini, Laura Novelli, Aggeo Savioli, Mariateresa Surianello.
La motivazione del Premio Hystrio Altre Muse a www.ateatro.it
E c'è anche la foto...
di Redazione ateatro
Qui di seguito, la motivazione del Premio Hystrio Altre Muse assegnato a questo sito (nella foto di Gianfranco Marino, Valeria & Vanessa del Principe Costante, Oliviero Ponte di Pino e Claudia Cannella).

Il sito www.ateatro.it, la webzine di cultura dello spettacolo dal vivo curata da Oliviero Ponte di Pino in collaborazione con Anna Maria Monteverdi, è ormai diventata un punto di riferimento per il teatro italiano, grazie anche ai vivaci forum e alla newsletter periodica. Fondata all’inizio del 2000, in quattro anni ha pubblicato – grazie a una fitta rete di collaboratori – oltre 1000 tra saggi, interviste, recensioni, notizie, inchieste, testimonianze di artisti, costruendo un ricco archivio sempre consultabile online e raccogliendo una parte della sua produzione nel volume Il meglio di ateatro 2000-2003, pubblicato da il principe costante Edizioni. Nei suoi 85 numeri, ha posto particolare attenzione al nuovo teatro, al rapporto tra la scena e i nuovi media (con la sezione “tnm”), all’economia e alla politica dello spettacolo. Con questa vocazione, www.ateatro.it ha tra l’altro promosso e organizzato, nel novembre 2005 a Milano, l’affollato convegno sulle Buone Pratiche, a cura di Franco D’Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino, incentrato sulle nuove forme organizzative, produttive e distributive delle nostre scene. A questo sito viene assegnato il Premio Hystrio – Altre Muse quale segno di attenzione non solo verso chi ha saputo fare un uso intelligente del web come alternativa agli spazi sempre più risicati che il teatro riesce a ritagliarsi sulla stampa, ma anche e soprattutto verso lo spirito indipendente, colto e provocatorio, militante e sperimentale con cui è riuscito a costruirsi uno luogo di dibattito vitale e costruttivo.
Nominato il nuovo Direttore Artistico del Festival di Santarcangelo dei Teatri
Il comunicato
di Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Santarcangelo dei Teatri
Al termine di una lunga procedura, accompagnata da discussioni e polemiche (ne trovate traccia sia in ateatro sia nel forum), il Festival di Santarcangelo ha finalmente un nuovo direttore. Qui di seguito, il comunicato ufficiale (n.d.r.).
Il Consiglio d’Amministrazione di Santarcangelo dei Teatri, all’unanimità, ha nominato Olivier Bouin Direttore Artistico del Festival Internazionale del Teatro di Santarcangelo, con l’impegno di realizzare il progetto presentato.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Associazione Santarcangelo dei Teatri, riunita il 13 luglio presso la residenza municipale di Santarcangelo, ha espresso piena condivisione dell’operato del Consiglio d’Amministrazione per quanto riguarda sia il metodo sia il valore del percorso seguito per la individuazione e la scelta del nuovo Direttore Artistico dell’Associazione.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Santarcangelo dei Teatri ha dedicato nei mesi scorsi diverse sedute all’esame dei sette progetti presentati per concorrere alla scelta del Direttore Artistico. In fasi successive sono stati selezionati per un ulteriore approfondimento, attraverso un colloquio con gli estensori, quei progetti che sono apparsi più rispondenti ai requisiti richiesti, in particolare per la completezza con la quale sono state affrontate linee artistiche, organizzative e finanziarie in un quadro progettuale unitario e coerente; e che, nel rispetto del percorso storico del Festival, proponessero ipotesi innovative relativamente agli orientamenti artistici, culturali ed imprenditoriali con forte attenzione al Festival come ponte fra la realtà locale e quella internazionale.
L’ampia ed approfondita discussione sui progetti presentati ha indotto il Consiglio a riesaminare la linea di politica culturale seguita negli ultimi anni. Per il prestigio acquisito dal Festival a livello nazionale ed internazionale, sarà impegno primario del Consiglio stesso far sì che la manifestazione possa sempre più contribuire al rinnovamento della nozione e degli scopi dei festival di creazione contemporanea, dando così un fattivo contributo alla riforma dell’intero sistema teatrale. I Consiglieri hanno fatto propria la raccomandazione espressa dall’Assemblea di mantenere saldo il rapporto fra l’innovatività del progetto artistico e culturale e le istanze di forte radicamento con il territorio che hanno sempre caratterizzato la specificità del Festival. Il Consiglio si impegna quindi a programmare degli incontri periodici con i Soci per una continua condivisione e verifica delle attività programmate.
Il Consiglio ringrazia tutti coloro che hanno accolto l’invito a partecipare a questa innovativa procedura per l’impegno e l’entusiasmo dimostrati e si augura di poter contare anche in futuro sulla loro collaborazione.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Santarcangelo dei Teatri
Santarcangelo di Romagna, 13 luglio 2005
Olivier Bouin ha curato da 15 anni progetti culturali nelle diverse città dove ha vissuto (Praga, Parigi, Boston e recentemente Roma). Convinto del valore della creazione contemporanea, sia artistica sia culturale, per esplorare il complesso mondo di oggi, Olivier Bouin è stato il promotore di programmazioni ibride nelle quali il dialogo tra le discipline artistiche (teatro, danza, arti visive, musica, cinema, letteratura...), le scienze umane e sociali e l'esigenza di un rapporto forte e durevole col pubblico, costituisce un elemento fondamentale. Impegnato a difendere la singolarità delle proposte artistiche ed intellettuali, cerca di integrare nuovi modi di organizzazione e di finanziamento, a livello nazionale ed internazionale, promuovendo l'autonomia e la diffusione della creazione contemporanea.
La drammatica scomparsa di Giampiero Bianchi
Ottimo attore in teatro, era stato tra i protagonisti di Incantesimo
di Redazione ateatro
L'attore Giampiero Bianchi è morto il 16 luglio a Roma.Secondo notizie non confermate si sarebbe suicidato gettandosi sui binari della metro. Nato 60 anni fa a Varese, Bianchi era attore revalentemente di prosa, molto stimato, che ha fatto quasi tutta la sua carriera al Teatro Stabile di Genova.

Giampiero Bianchi e Andrea Jonasson protagonisti di Crimini coniugali allo Stabile di Trieste.
Nel '68, aveva esordito giovanissimo in tv accanto ad Aldo Reggiani nella Freccia nera e, qualche anno dopo, aveva colto, sempre sul piccolo schermo, il primo successo nella Donna di picche ('72). In teatro era stato brillante protagonista di Tradimenti di Pinter allo Stabile di Trieste, accanto ad Andrea Giordana e Ivana Monti, delle False confidenze di Marivaux nell'edizione di Sciaccaluga al Teatro di Genova ('98) dove era stato il partner ironico e svagato di Andrea Jonasson. A fianco di Giuseppe Cederna e Marco Cavicchioli aveva interpretato con la regia di Gallione Gol! (TacaLaBala), vaudeville sarcastico ed amaro scritto dallo stesso Cederna.
In questa stagione aveva recitato in coppia con Andrea Jonasson nella commedia Crimini coniugali di Schimdt. Negli ultimi anni aveva ottenuto una certa popolarità come protagonista di Incantesimo.
In libreria Le vie dei festival
A 7 euro nelle librerie Feltrinelli per tutta l'estate
di Associazione CADMO
Sarà per tutta l’estate nelle Librerie Feltrinelli
e nelle principali librerie italiane l’undicesima edizione di Le vie dei Festival, guida ai Festival estivi di cinema, teatro, danza e musica in Italia e in Europa realizzata dall’Associazione CADMO di Roma.
Riporta i programmi di circa 300 festival. La guida è il frutto di un’accurata ricerca che fornisce - UNICA IN ITALIA - una panoramica esauriente e tutte le informazioni necessarie sui festival estivi e dei principali festival autunnali: date, indirizzi, numeri di telefono, siti web, e-mail, schede con note, caratteristiche, nomi e spettacoli di maggiore interesse.
Il libro, di formato tascabile, come nelle scorse edizioni, non vuole essere uno strumento specialistico, ma è indirizzato soprattutto al lettore occasionale, non necessariamente assiduo frequentatore di festival.
Contiene piccoli commenti alle varie caratteristiche delle manifestazioni e negli anni è diventato anche uno strumento di agile consultazione, indispensabile anche per gli operatori che trovano nel libretto un valido sostegno per il loro lavoro.
Le vie dei Festival 2005 sarà in vendita, dal 10 luglio, in tutte le Librerie Feltrinelli e nelle principali librerie italiane al prezzo di 7 euro.
Per vendita online: Infoshop Mag6 Via Sante Vincenzi 10a, 42100 Reggio Emilia tel/fax 0522/430307
email: infomag@libero.it; www.infoshopmag6.it.
Come sempre questa è solo la prima parte di un progetto più ampio che prevede - con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Roma - la presentazione, tra settembre e ottobre, di quanto di più significativo è emerso dai programmi dei festival estivi. Proposte spesso anticipatrici di nuove tendenze che hanno portato a Roma per la prima volta artisti del calibro di Eimuntas Nekrosius, Alain Platel, William Kentridge, Enrique Vargas, Mauricio Celedon, il Big Art Group di Caden Manson e molti dei nuovi nomi del panorama teatrale italiano.
Per informazioni: Associazione CADMO tel. 06/3202102 – 3234686; e-mail: info@leviedeifestival.it
"Hystrio" 03/05 con un dossier Pasolini
Il sommario del numero
di Redazione "Hystrio"
Speciale Premio Hystrio alla vocazione La cronaca, le foto, i premiati dell¹edizione 2005 - di Claudia Cannella e Fabrizio Caleffi La questione teatrale Buttiglione alle Attività culturali dopo Urbani - di Ugo Ronfani Festival Viaggio nell¹Italia delle rassegne estive - di Giulia Calligaro Vetrina Cambio della guardia nel teatro di prosa: Calbi all¹Eliseo, Binasco allo Stabile delle Marche, Sinisterra al Metastasio - di Simona Buonomano, Pierfrancesco Giannangeli, Francesco Tei e Giulia Calligaro Drammaturgia Roberto Cavosi: miti antichi in tragedie di oggi - di Massimo Bertoldi Testi Gassosa - di Roberto Cavosi Danza Si moltiplicano sulle nostre scene le compagnie cinesi - di Domenico Rigotti, Dimitri Papanikas, Andrea Nanni Dossier Pier Paolo Pasolini A 30 anni dalla morte, un bilancio dell¹opera teatrale di uno fra i più acuti e contraddittori intellettuali del secondo dopoguerra - a cura di Claudia Cannella Teatromondo Parigi: Molière/Lully, Arias, Planchon, Pollesch e Sellars -Londra: Vanessa Redgrave - Bruxelles: Kunsten Festival des Arts - New York: Trisha Brown - di Giuseppe Montemagno, Filippo Bruschi, Laura Bevione, Lorenzo Donati e Alessandra Nicifero Nati ieri Ventiduesima tappa nell¹Italia dei nuovi gruppi: Teatro dell¹Argine - di Massimo Marino Biblioteca Le novità editoriali - a cura di Albarosa Camaldo Exit Addio a Valeria Moriconi, Raffaello Baldini, Renzo Vescovi e Barbara Nativi - di Domenico Rigotti, Giulia Calligaro, Pier Giorgio Nosari e Francesco Tei Critiche Pro & contro: Temporale di Strehler/D¹Amato - Bruni: Tempesta per burattini - L¹illusione comica di Sciaccaluga - Lavia/Melato mattatori per Albee - Carpentieri rilegge Della Porta - Il Ciclope siciliano di Pirrotta La società teatrale Tutta l¹attualità nel mondo teatrale, a cura di Giulia Calligaro Hanno collaborato: Marco Andreoli, Giovanni Ballerini, Sandro Bernardi, Massimo Bertoldi, Valentina Bertolino, Laura Bevione, Filippo Bruschi, Simona Buonomano, Fabrizio Caleffi, Stefano Casi, Roberto Cavosi, Anna Ceravolo, Concetta D¹Angeli, Lorenzo Donati, Loredana Faraci, Mimma Gallina, Emanuela Garampelli, Andrea Garlet, Gigi Giacobbe, Giuseppe Liotta, Stefania Maraucci, Massimo Marino, Antonella Melilli, Giuseppe Montemagno, Andrea Nanni, Alessandra Nicifero, Pier Giorgio Nosari, Dimitri Papanikas, Gianni Poli, Oliviero Ponte di Pino, Irina Possamai, Eliana Quattrini, Olindo Rampin, Domenico Rigotti, Francesco Tei, Martina Treu, Francesco Urbano, Nicola Viesti, Giusi Zippo. In copertina: Ritratto di Pasolini, illustrazione digitale di Ivan Canu

