L'editoriale di ateatro 98
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and1
Gli scheletri, i cani, il teatro
Marina Abramovic e Velasco
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and3
Il naufragio di Arlecchino
La CP Valour s'incaglia nelle Azzorre con il container del Piccolo Teatro
di Perfida de Perfidis
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and4
Appunti per una mappatura del videoteatro
Con qualche annotazione sul bando di Concorso Italia 2006 di TTV
di Anna Maria Monteverdi e Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and5
La tecnologia delle idee: Marcel.lí Antunez Roca El Dibuixant
Il video di Marcel.lí Antunez Roca e Miguel Rubio
di Annamaria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and6
A che punto siamo con Antonin Artaud?
Tre domande a Marco De Marinis
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and7
Antonin Artaud: Postilla 2006
da La danza alla rovescia di Artaud. Il Secondo Teatro della Crudeltà (1945-1948), Roma, Bulzoni, 2006
di Marco De Marinis
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and8
Ma che faccia aveva Shakespeare?
I ritratti (veri e presunti) in mostra alla National Portrait Gallery di Londra
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and10
Speciale Torino 2006: chiude il circuito teatrale piemontese?
Con una intervista al commissario Angelo Pastore
di Franco D’Ippolito
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and11
Speciale Torino 2006: nasce la Fondazione Teatro Europeo
Un festival teatrale internazionale per il Piemonte
di Franco D’Ippolito
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and12
Speciale Torino 2006: Caro Nevio
Una risposta alla mail di Nevio Gambula
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and15
Il poeta fuori dalle caverne
Brevi scritti su Franco Scaldati
di Clara Gebbia
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and20
Videoritratti ateatro: Jan Fabre
The Crying Body
di Orsola Sinisi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and27
Galileo in Romania
Progetto Sidereus Nuncius-Cultura 2000
di Anna Maria Monteverdi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and30
Una partitura per Edipo: Voce sola, 7013 parole in 71 minuti
Al tavolino di un bar con Cristian Ceresoli e Antonio Pizzicato
di Franco D’Ippolito
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and46
Le recensioni di ateatro: Niente più niente al mondo
Regia di Paolo Pierazzini
di Sara Ficocelli
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and47
Speciale elezioni 2006: la posizione della Lega Nord Padania sullo spettacolo
Risposte ai quesiti di "Hystrio"-ateatro da parte dell'On. Davide Caparini e di Roberto de Anna
di Mimma Gallina in collaborazione con Anna Chiara Altieri
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and80
Un'attrice "troppo": Adelaide Ristori
Che hanno detto al Convegno nazionale di Cividale del Friuli
di Angela Felice
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and81
In mostra la danza da Duncan a Bausch
A Milano dal 17 al 22 luglio
di Ufficio Stampa
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and83
1989: i crolli
Un concorso di drammaturgia
Il bando
di Compagnia Teatrale ATIR
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and84
Tadeusz Kantor in mostra a Torino 25 anni dopo Wielopole Wielopole
Dal 4 al 14 maggio
di Ufficio Stampa
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and85
Premio Hystrio 2006 per giovani attori
Il bando
di Hystrio
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and86
Un laboratorio con il Bread & Pupett
(e se non sapete che cos'è, curiosate nella ateatropedia)
di Pergine Spettacolo Aperto
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and88
Riccione TTV: il programma definitivo
La scena e lo schermo a Bologna dal 3 al 14 maggio
di Riccione TTV
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and89
Cesare Lievi riconfermato direttore del Centro Teatrale Bresciano
Alla guida delo stabile da dieci anni
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and90
Il non-lavoro del teatro
A Livorno, a cura di Concetta D'Angeli
di La Casa del Teatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro98.htm#98and95
I quiz di ateatro 100-2
L'editoriale di ateatro 98
di Redazione ateatro
Come mai TTV, il festival che cerca di coniugare teatro e video, è in crisi da anni? Oppure, se preferite, che c’entra la tecnologia con la creatività?
Antonin Artaud, il grande teorico del teatro del Novecento, è ancora così importante anche nel nuovo millennio?
Che faccia aveva Shakespeare?
Perché si discute così tanto del Circuito Teatrale Piemontese, di Ronconi alle Olimpiadi e in generale di Torino?
Che s'inventa Franco Scaldati nel suo quartiere, a Palermo?
Uno scheletro può dirigere un coro di bambini? E che ci fanno quei cani sotto il palco del Teatro dell'Arte?
Qual è il più stabile degli stabili italiani? Oppure, se preferite, riuscirà Cesare Lievi a battere il record di Marco Bernardi?
Che cosa ha in mente per quest'estate Jan Fabre?
Come seguire un laboratorio con il leggendario Bread & Puppett?
E che ci va a fare Galileo Galilei in Romania?
Ma soprattutto come mai l’Arlecchino di Strehler è naufragato su una spiaggia delle Azzorre?
Se vuoi risolvere questi quiz, leggi ateatro 100-2.
Ti rispondono la sublime Perfida De Perfidis e poi, in rigoroso ordine alfabetico, tra gli altri Marce.lí Antunez Roca, Marco De Marinis, Franco D’Ippolito, Clara Gebbia, Annamaria Monteverdi, Oliviero Ponte di Pino, Orsola Sinisi...
Perché non lo sai, se ateatro (e nei forum) non ci vai...
Gli scheletri, i cani, il teatro
Marina Abramovic e Velasco
di Oliviero Ponte di Pino

Marina Abramovic, Count on Us, 2003.
In scena c’è un coro di bambini che canta. La canzone si intitola Le Nazioni Unite:
L’amore e l’armonia vi regnano
L’ardente bandiera dell’amicizia
La fede nella giustizia, speranza
Di tutto il genere umano.
Le Nazioni Unite
Sono la vetta inespugnabile della libertà.
A dirigerlo, uno scheletro che quasi sembra danzare con le sue mosse leggere e appena burattinesche. Quando finisce la canzone, si scopre che ad animarlo è una donna, quello scheletro è fissato alla sua schiena.

Marina Abramovic, Nude with Skeleton, 2003.
Un altro schermo. Una donna nuda. Uno scheletro.
Dopo molti anni, dopo un lunga guerra, Marina Abramovic è tornata a Berlgrado, in quella che una volta era la Jugoslavia.
La guerra. La morte. Il sessso.
Ancora schermi. Da una parte un gruppo di uomini, in costume tradizionale, in fila. Si vedono quei volti duri, immobili. E dai pantaloni escono i loro cazzi eretti.

Marina Abramovic, Balkan Erotic Epic, 2005.
Dall’altra un prato sotto la pioggia. Una pioggia che sembra non smettere mai. Un gruppo di donne, vestite anche loro con costumi tradizionali, danza e urla, mostrando le vagine.
La guerra, la morte, il sesso. Negli ultimi anni Marina Abramovic ha avuto il coraggio di misurare quello che significano queste tre parole con il proprio corpo, in una serie di opere raccolte sotto l’insegna di Balkan Epic all’Hangar Bicocca di Milano, a cura di Adelina von Fürstenberg (nel ciclo rientra anche Balkan Baroque, presentato alla Biennale di Venezia nel 1977).

Velasco, Tana, 2006.
Il sottopalco di un teatro, cui si accede dopo un percorso tortuoso. Nella semioscurità, tra i pilastri che sostengono l’edificio, sembra di essere sul ponte di una nave: gomene, bitte sparse alla rinfusa sul pavimento. E poi alcuni cani, scuri, inquietanti, pieni di energia, cime nella visione di un mistero. Sono le sculture che Velasco ha portato al Teatro dell’Arte di Milano, in una installazione carica d’energia, bella e feroce.
Ecco, forse il teatro dovrebbe essere così, trasmettere le sensazioni e la forza, l’energia e la ribellione delle opere di Marina Abramovic e di Velasco.
Il naufragio di Arlecchino
La CP Valour s'incaglia nelle Azzorre con il container del Piccolo Teatro
di Perfida de Perfidis
Sono diventata buona? Sono diventata poetica? Chissà... Intanto - mentre voi cercate di immaginare se si farà il nuovo governo, e se c'è una poltroncina a disposizione (Prodi ha promesso qualcosa anche a voi, quando siete andati a trovarlo?) - ho una storia bella e triste da raccontarvi!

L'isola degli schiavi, regia di Giorgio Strehler, 1984.
Una spiaggia su un’isola sperduta in mezzo all’oceano. Un tempesta invernale, onde gigantesche, una nave viene sospinta verso la riva e s’incaglia.

La CP Valour s’incaglia alle Azzorre.
Il mare si placa, i marinai cercano di alleggerire il carico, ma non c’è niente da fare. La nave non si muove, è in trappola. Pochi giorni dopo, una nuova tempesta, ancora più terribile. Onde gigantesche spazzano il ponte, s’abbattono sulle fiancate. La nave s’inclina, il carico comincia a scviolare in mare.

La CP Valour s’inclina, i container cadono in mare.
Parte del carico affonda, ma molte casse e bauli galleggiano sulle onde, alcune vengono spinte a riva dalla corrente.
Le casse sono sfondate, ma dentro alcuni bauli ci sono ancora costumi, parrucche, scenografie, maschere, fotografie e manifesti teatrali, l’occorrente per il trucco.

Uno dei container della CP Valour: costumi, maschere, manifesti, fotografie...
Gli attori di una compagnia teatrale vengono informati di quello strano carico. Arrivano sulla spiaggia battuta dal vento dell’oceano. Tra i relitti, trovano quello strampalato tesoro. Provano quei costumi, indossano quelle maschere. Hanno qualcosa di strano, di magico. Vedono un costume pezzato, coloratissimo, sono davvero tutti i colori dell’arcobaleno. Un giovane attore lo indossa. C’è un altro costume, una ampia gonna e un corpetto scollato, lo trova una ragazza. E’ ancora umido, ha il sapore del mare, lei lo indossa ugialmente. In fondo a una cassa, avvolto da una pezza colorata, lui ha trovato una maschera. Toglie accuratamente la sabbia e le alghe, il suo volto scompare dietro quelle fattezze vagamente demoniache. Lei lancia un urlo, come spaventata, poi ride. Lui la insegue.
Gli altri li guardano senza capire.
Su quella spiaggia quell’Arlecchino e quella Colombina corrono per un po’ avanti e indietro, ridono, si abbracciano, si guardano, si allontanano. Fanno strani gesti. Cominciano a calarsi nei personaggi. C’è qualcosa di strano, una tensione che non avevano mai provato. C’è un antico copione che ricordano dalla scuola di recitazione.
IL PAESE DELLA CUCCAGNA di Carlo Goldoni
ATTO PRIMO, SCENA PRIMA
Spiaggia di mare con veduta di legni naufragati.
PANDOLINO, poi POLLASTRINA
PAND.
Chi m'insegna, chi mi dice
L'infelice Pollastrina
Se più vive, poverina,
O se morta è in mezzo al mar?
Povero Pandolin! che gran disgrazia!
M'avessero quell'onde subissato;
M'avessero ingoiato
Un'orca, una balena,
Ch'ora non proverei sì fiera pena.
Povera Pollastrina!
Per amor mio s'è indotta
A lasciar la sua patria, e con la madre
E col fratel meco è venuta in mare;
Ma prima d'arrivare
A far in terra il nostro sposalizio,
Se n'è andata la nave in precipizio.
Chi m'insegna, chi mi dice
L'infelice Pollastrina
Se più vive, poverina,
O se morta è in mezzo al mar? (parte)
ATTO PRIMO, SCENA SECONDA
POLLASTRINA dall'altra parte.
Chi m'insegna, chi mi dice
L'infelice Pandolino
Se più vive, poverino,
O se morto è in mezzo al mar?
Povera Pollastrina!
M'avevo ritrovato un buon marito,
E appena l'ho trovato, l'ho smarrito!
Mi dispiace perduti
Aver la madre ed il fratello in mare;
Ma oimè, che più penoso
M'è il dolor d'aver perso il caro sposo!
Chi m'insegna, chi mi dice
L'infelice Pandolino
Se più vive, poverino,
O se morto è in mezzo al mar? (parte)
SCENA TERZA
PANDOLINO, poi POLLASTRINA
PAND.
Chi m'insegna Pollastrina?
POLL.
Chi m'insegna Pandolino?
PAND.
Se più vive, poverina?
POLL.
O se morto è in mezzo al mar?
(Vanno smaniando per la scena, poi si scoprono e si riconoscono)
POLL.
Pandolin!
PAND.
Pollastrina!
POLL.
Idolo mio!
PAND.
Tu sei qui? Tu sei viva?
POLL.
Tu non sei naufragato?
a due
Evviva, evviva!
PAND.
Tua madre?
POLL.
Oh sventurata!
PAND.
Tuo fratello?
POLL.
Oh meschino!
Li ho veduti andar giù,
E non li ho più veduti a tornar su.
PAND.
Come ti sei salvata?
POLL.
Io mi son attaccata
A un bravo marinaio,
Ed egli semiviva
M'ha condotta del mar in sulla riva.
PAND.
E il marinaro poi,
Così tra viva e morta,
Ti ha fatto nulla?
POLL.
Il diavol che ti porta.
Sono le prime battute del Paese della cuccagna di Carlo Goldoni, quelle che si ricordano e recitano i due giovani attori. Perché quelli che indossano - quelli in cui si trovano così bene - sono i costumi di un altro spettacolo goldoniano, L’Arlecchino servitore di due padroni, che da quasi sessant’anni gira i teatri di tutto il mondo.
Avrebbero potuto essere anche le prime battute di un altro testo portato in scena da Goorgio Strehler, L’isola degli schiavi di Marivaux. Un altro naufragio, su un’altra isola deserta, quello raccontato da Strehler e Marivaux. Questa volta Arlecchino e Colombina sono in viaggio con i loro padroni, e il quartetto di servi e signori dovrà cavarsela tra le mille difficoltà di quell’ambiente ostile e fondare un nuovo patto sociale.
Dalle note di regia di Giorgio Strehler per L’isola degli schiavi
Un teatro in penombra. un velo azzurro scuro che copre dall'alto il palco, come un sipario.
di colpo una tempesta come nella Tempesta, ma minore.

La Tempesta, regia di Giorgio Strehler, 1977.
non tragica. piuttosto quasi infantile. si intravede tra i lampi l'ombra di una piccola nave a vele spiegate che ondeggia, si impenna, si piega, sparisce, riappare. la piccola nave perde le vele, gli alberi minuscoli si spezzano. poi tra fragori e spruzzi, s'inabissa.

L'isola degli schiavi, regia di Giorgio Strehler, 1984.
buio di colpo. silenzio.
luce. appare l'isola.
è un palcoscenico vuoto, bianco. sabbia lo copre. blu, quinte e fondo lontano. tutto assoluto.
sul palco. in una luce d'aurora che si alza e un poco di vento che solleva qua e là, lievi onde di sabbia, quattro corpi umani distesi, addormentati in posizioni diverse di sonno profondo. nudi. due uomini e due donne. per il palcoscenico vestiti, sparsi:
gonne sottogonne, corpetti colorati e biancheria, calze, scarpine, due con ricca fibbia, due senza, brachette intime, calzoni con nastri e senza. una spada con fodero ed elsa dorata, un ventaglio dipinto, un ombrellino di seta trasparente. tutto abbandonato a caso come dopo un naufragio.
e c'è anche qualche resto di legno, qualche lembo di vela, un bauletto sfasciato semisepolto, un chitarrino con poche corde. due bottiglie coi vetri che brillano nel sole come diamanti.
lentamente i corpi, uno dopo l'altro, incominciano a muoversi: si svegliano. le due figure femminili in ombra da un lato.
le due figure maschili in luce dall'altro.
i due uomini si girano, stirano le braccia,
sbadigliano, poi si vedono l'un l'altro. si scoprono e gridano quasi di meraviglia, riconoscendosi. uno dei due uomini ha sul viso una maschera nera.
l'altro ha il trucco disfatto di un attore.
L'UNO Aaaaaaaaa... Arlecchino!
L'ALTRO Ssssssssss... Signore! Voi?
L'UNO Tu?
L'ALTRO Io.
Un abbraccio di smarrimento
MONSIEUR In un'isola. Che ne sarà di noi?

L'isola degli schiavi, regia di Giorgio Strehler, 1984.
Sembra quasi che Giorgio Strehler, come il Prospero della Tempesta, abbia voluto giocare con il destino, mandando i costumi del suo spettacolo più celebre a naufragare su un’isola sperduta nell’Oceano Atlantico.
Perché quello che vi abbiamo raccontato è vero, quasi tutto vero. Un ottimo sito documenta giorno per giorno, ora per ora, la successione degli eventi (le immagini del disastro le abbiamo prese da lì).
I fatti. Nell’autunno del 2006 la compagnia del Piccolo Teatro porta il suo “spettacolo-manifesto”, L’Arlecchino servitore di due padroni, in tournée negli Stati Uniti. Dopo gli abituali trionfi, che chiudono i materiali di scena in un container e lo caricano su una nave che batte la bandiera delle Bermude, la CP Valour. A bordo ha 800-1000 container, una grande quantità di carburante e diversi fusti con varie sostanze chimiche.
Dovrebbe essere un viaggio tranquillo, dal Canada a Valencia. Del resto cosa può la furia della natura contro un colosso lungo 177 metri e alto 35? Ma il mare, si sa, è da sempre una macchima che impasta i destini di navi, uomini e cose.
Il 9 dicembre la CP Valour s’incaglia nella Praia do Norte, Baía da Ribeira das Cabras, sull’Isola do Faial, la più occidentale delle Azzorre. Malgrado i diversi tentativi di liberarla, alleggerendo il carico e sfruttando le maree, la nave resterà lì, a pochi metri dalla riva, per molti mesi, in balia delle onde, scaricando a mare idrocarburi e altre sostanze chimiche e causando una piccola catastrofe ecologica.

I tecnici esaminano la spiaggia della Baía da Ribeira das Cabras dopo che la CP Valour ha scaricato sostanze inquinanti.
Qualche settimana dopo, siamo ormai a gennaio, arriva un’altra tremenda mareggiata. In mare finiscono anche alcuni dei container che si trovavano a bordo, compreso quello che contiene il materiale del Piccolo Teatro di Milano. Sul sito informano che la CP Valour, tra i suoi molti tesori, trasportava anche “os adereços de um grupo de Teatro Italiano de nome "Piccoli"”.

Ecco la prova: tra i tesori che la furia dei marosi ha strappato alla CP Valour ci sono davvero “os adereços de um grupo de Teatro Italiano de nome "Piccoli"”.
Così ai primi di febbraio sulla Praia do Norte arriva un gruppo teatrale locale, il Teatro de Giz della città di Horta. Capiscono che quel materiale appartiene al Piccolo Teatro e si mettono in contatto via e-mail con via Rovello. Da Milano rispondono subito:
"(...) I am the tour and production manager of the US Tour of Arlecchino and all of us were so desperate about this incredible adventure.(...) Our container is a Hanjing clear blue one which was on the afterhold (waves' side, unfortunately) and I imagined that in a short time it would fall down. We thought everything was lost and your message was a sparkling light in this nightmare..."
Un’altra coincidenza, in questa storia piena di coincidenze. Era il 1970. Davanti al porto di Genova andò a picco una nave da carico filippina. Migliaia di genovesi furono testimoni della tragedia: i marinai vennero inghiottiti dai flutti dopo che una rudimentale teleferica non era riuscita a portarli in salvo, il capitano si suicidò dopo che sua moglie si era schiantata sugli scogli. De André scrisse allora l'unica canzone recitata della sua carriera:
"I marinai foglie di coca digeriscono in coperta...
il pasticciere di via Roma sta scedendo le scale...
E la radio di bordo è una sfera di cristallo, dice che il vento si farà lupo e il mare si farà sciacallo....
E le ancore hanno perduto la scommessa e gli artigli i marinai...".
Quella nave si chiamava la London Valour, forse la canzone di Fabrizio è la colonna sonora perfetta per questa storia.
E se volete una lettura che dia forma al ricordo ed evochi le atmosfere adatte, va benissimo il primo Tabucchi: quello dei racconti d’esordio (ne ricordiamo un paio, bellissimi, molto teatrali, e Donna di Porto Pym, che dev’essere ambientato proprio a quelle parti).

La prima edizione dell'Arlecchino servitore di due padroni, 1947.

L'ultima edizione dell'Arlecchino servitore di due padroni, 2004.

La compagnia dell'Arlecchino, a Chicago, dopo l'ultima replica, 2005; sullo sfondo il fondale che poco dopo sarà imbarcato sulla CP Valour.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Appunti per una mappatura del videoteatro
Con qualche annotazione sul bando di Concorso Italia 2006 di TTV
di Anna Maria Monteverdi e Oliviero Ponte di Pino
Il nuovo bando per il Concorso Italia e la selezione 2006
ateatro ha pubblicato tra le news sia il bando del Concorso Italia 2006 sia i nomi dei 10 fortunati selezionati dalla pre-giuria (oltre naturalmente al programma di questa edizione).
Come ricorderanno i lettori più attenti, nel 2004, in occasione della precedente edizione di TTV, la manifestazione si era conclusa con una vivace polemica. La giuria del concorso (una giuria tecnica formata dal videomaker Giacomo Verde, dalla studiosa di media Sandra Lischi, da Ciro Giorgini di Blob e da Gioia Costa) aveva diffuso un comunicato assai duro contro le discutibili scelte della commissione selezionatrice, decidendo poi - in maniera abbastanza clamorosa - di non assegnare alcun premio.
Sia la webzine sia il forum avevano ospitato un vivace dibattito che è tuttora in corso. Si ipotizzò addirittura il “ripescaggio” di alcuni video bocciati in vista di una programmazione ad hoc per Fuori orario. Nonostante la proposta fosse stata avanzata da Ciro Giorgini, purtroppo non se ne è fatto nulla. Un'occasione sprecata.
Nel presentare la nuova edizione 2006, la direzione del TTV sottolineava di aver previsto una modifica al regolamento come richiesto dalla giuria del 2004 (e come sollecitato anche da precedenti giurie, come quella del 2002 composta tra gli altri da Paolo Rosa e Franco Quadri). Tuttavia l'unica modifica di qualche peso, come è lampante a una prima lettura del regolamento, è aver sancito in maniera esplicita che il Concorso Italia è dedicato esclusivamente ai video autoprodotti.
A noi pare che questa modifica rischi di non essere d’aiuto nel risolvere i gravi problemi del Concorso Italia, e in genere del TTV, e che rischi anzi di risultare fuorviante rispetto alla complessità della tematica relativa ai media digitali a teatro (in scena o come opere autonome).
Riteniamo anacronistico mantenere in vigore nella sostanza un regolamento vecchio e superato, che trascura colpevolmente gli aspetti più attuali del versante multimediale del teatro: l'innovazione, le nuove modalità di produzione e i nuovi formati (dal live cinema allo streaming video). Quel regolamento non rispecchia più l’attuale situazione del settore né coglie il senso della sua evoluzione.
Temiamo dunque che modifiche marginali del regolamento non possano risolvere i problemi in cui il TTV si dibatte (e di cui al TTV si è dibattuto). Riteniamo che la formula del festival possa (anzi, debba) essere profondamente messa in discussione.
Quelli che seguono sono alcuni appunti che cercano di dare un contributo costruttivo al TTV e a manifestazioni analoghe, già esistenti o in corso di progettazione, e sono il frutto di una riflessione teorica condotta negli ultimi mesi.
Autoproduzioni?
In un sistema che funziona sempre più attraverso co-produzioni articolate e allargate a vari enti, qualunque definizione di autoproduzione (tranne nel caso lampante di produzioni Rai) appare vaga e discutibile, oltre che facilmente aggirabile.
Non è un caso che la giuria di preselezione per questa edizione abbia scelto tra gli altri due videodocumentari (su Ascanio Celestini e su Marco Baliani) che dalle schede a disposizione su internet risulterebbero in realtà ampiamente sostenuti da strutture private (nazionali e internazionali), con sovvenzioni anche da enti e istituzioni pubbliche e canali televisivi: Comune di Roma, National Geographic Channel, Fandango Film, Media Programme della U.E. Ovviamente va verificato se per produzione si intende esclusivamente il sovvenzionamento attraverso fondi, ma questo già mette in crisi appunto la clausola di cui sopra. La critica non è ovviamente diretta al lavoro su Celestini o su Baliani, ma sorge un lecito dubbio sulla legittimità della loro presenza al concorso. Inoltre, date le maglie troppo larghe del regolamento, i criteri generali per la pre-selezione appaiono (e non da oggi) piuttosto vaghi e misteriosi.
Il nuovo che avanza
Lo scenario - non solo nel settore dei videoteatro, come sappiamo - sta cambiando con grande rapidità, grazie alla capillare diffusione di tecnologie digitali avanzate a costi sempre minori, sia per quanto riguarda l’hardware sia per quanto riguarda il software: solo per fare un esempio, sono ormai moltissimi gli studenti e i giovanissimi che hanno familiarità con la computer graphics o usano programmi e applicativi per la modellazione tridimensionale e l'animazione, tecnologie fino a poco tempo fa accessibili solo a grandi studios cinematografici e televisivi. Oggi un progetto teatrale si incrocia con una molteplicità di altri media, avanza lentamente attraverso numerosi step e il video non è più necessariamente, come una volta, il format decisivo per una eventuale promozione o documentazione né l'ultimo anello della catena produttiva.
La progettualità
Infine, e questo ci pare l’aspetto più importante, puntare su una discriminante sostanzialmente economica - perché il problema che il criterio dell’autoproduzione cerca di affrontare è la differenza di budget tra le opere in concorso - elude i reali problemi del settore: non premia la qualità, né la professionalità e la tecnica, e trascura il dato non secondario della progettualità complessiva.
Il concorso TTV contempla - detto per inciso - un Premio di Produzione (per produrre una nuova opera da presentare l'edizione successiva, ovvero dopo due anni) che per differenziarsi dal Premio del Concorso Italia dovrebbe a logica privilegiare non tanto un'opera finita ma un'idea, un progetto in corso a opera di autori e gruppi magari emergenti che possono presentare le linee guida e le modalità di realizzazione dell'opera attraverso frammenti esemplificativi nelle vesti tecnologiche più diverse. Invece sostanzialmente i criteri di premiazione sono identici.
La promozione di realtà nuove inoltre è inesistente da questa edizione, come dimostra ampiamente anche il lotto dei video del Concorso 2006.
In ogni caso, l’aspetto più lampante riguarda l'inadeguatezza del Festival TTV nel rapporto con l’innovazione linguistica del teatro proprio grazie alle nuove tecnologie, nella prospettiva indicata da De Kerchove di una resa metaforica della complessità del tecnomondo o, come ricorda Marcel.lì Antunez, quale veicolo di “idee”.
Alcuni punti di riferimento
Il punto di partenza per una seria riflessione anche in relazione a un festival che si vuol dare una veste internazionale come il TTV sono senz'altro le esperienze dirette di spettatori e studiosi, le pubblicazioni e le ricerche in corso sull’argomento e su tematiche tangenti.
Vale la pena ricordare quelle ormai storiche e a più riprese citate e recensite da ateatro: dal volume di Balzola-Prono La nuova scena elettronica a quello di Balzola-Monteverdi sulle Arti multimediali, da quelli curati da Béatrice Picon Vallin ai saggi di Savarese-Borelli, di Infante e di Laura Gemini; è significativo sottolineare che di recente autorevoli riviste ben radicate nei filoni antropologici o sociologici del teatro dedicano speciali proprio alle tecnologie in scena:
- Steve Dixon per “The Drama Review” di Richard Schechner parla di Marcel.lì Antunez e Stelarc nel saggio Metal Performance;
- il “Performing Arts Journal” di Bonnie Marranca si dedica al Time-Image di William Kentridge;
- il "Journal of Computer-Mediated Communication" dedica un numero speciale a Play and Performance in a Computer-Mediated Communication;
- Gabriella Giannachi e Nick Kaye parlano dei progetti di ricerca sulla (tele)presenza riferita alla performance.
Tre postulati
Il nostro contributo ha tre presupposti.
In primo luogo, la centralità dello spettacolo dal vivo: questo postulato riflette la storia stessa del TTV e l’identità che caratterizza la manifestazione di Riccione rispetto ai numerosi festival di arte digitale e di videoarte in Italia e all’estero (da questo punto di vista, non ci pare sufficiente che gli artisti in concorso abbiano un curriculum artistico con esperienze teatrali: secondo noi è necessario che l’opera in questione abbia un evidente legame con attività di spettacolo dal vivo o a esso fortemente intrecciato).
In secondo luogo, riteniamo che non si possa prevedere quello che accadrà in futuro in un ambito in costante evoluzione: tecnologie e linguaggi sono cambiati in questi anni con velocità sorprendente, e probabilmente cambieranno ancora, man mano che ci approprieremo delle nuove tecnologie e padroneggeremo le loro potenzialità.
Infine, abbiamo la consapevolezza che il videoteatro non è affatto un settore omogeneo, ma che vive di una pluralità di esperienze e di approcci. Questa ricchezza è un patrimonio ancora da conoscere, studiare e valorizzare. All’interno di questa forma di comunicazione ed espressione (o, se si preferisce, all’interno di questo genere artistico) per certi aspetti magmatica riteniamo tuttavia possibile discriminare alcuni filoni e approcci.
Nell’ambito del videoteatro abbiamo dunque identificato alcuni format.
Per format Aldo Grasso, nella sua Enciclopedia della televisione (Garzanti, Milano, 2002, s.v.), intende uno “schema originale e compiuto di un programma comprendente elementi sia contenutistici (tematica, genere, scopo, ecc) sia strutturali (articolazione delle sue fasi sequenziali e/o narrative, apparato scenico, personaggi fissi ecc.), già rodato attraverso un’emissione televisiva”. Per A. Brogi e C. Cilli (Motion cross, http://www.xlab.it) i format sono “moduli che dimostrano come un unico contenuto possa essere, nei suoi aspetti contemporaneamente sintattici e semantici, una esperienza unica ma differenziabile a seconda del media per il quale è progettato”. La prima definizione privilegia gli aspetti contenutistici e strutturali, la seconda quella che possiamo definire transmedialità o intermedialità. Senza voler entrare nel merito, nel nostro uso del termine cerchiamo di tener conto di queste diverse valenze, che peraltro riflettono la ricchezza e la complessità della materia.
I format da noi identificati recuperano e aggiornano la fondamentale distinzione teorizzata da Andrea Balzola a cui rimandiamo (La nuova scena elettronica). Alcuni risulteranno immediatamente riconoscibili, altri sono volutamente più aperti e hanno confini meno definiti (a volte possono anche sovrapporsi: spetterà eventualmente all'autore l'inserimento della propria opera in una categoria o in un’altra). Ovviamente un video utilizzato in scena nel corso di uno spettacolo teatrale non ha lo stesso valore e significato del video che documenta (o interpreta) quello spettacolo, e non può avere la stessa griglia di lettura e la stessa interpretazione. La discriminante è data dall'analisi del contenuto e della forma dell'opera.
I format del videoteatro
1. il videoteatro vero e proprio, ovvero qualunque ripresa video di uno spettacolo o di un testo teatrale. E’ il format più antico e consolidato. In teoria, questo format comprende le reinvenzioni o riscritture artistiche e d’autore da spettacoli o le videocreazioni autonome ispirate a una drammaturgia/testo/autore.
2. il documentario teatrale, ovvero il video o il filmato che documenta un’esperienza in vario modo legata al teatro. Può essere un documentario dedicato a uno spettacolo, a una compagnia, a un teatro, a un laboratorio; può essere un omaggio, una biografica d'autore, d'attore, di un movimento, di un festival, di architetture teatrali storiche, eccetera. Rientrano in questo format i backstage, ma anche le opere che ricostruiscono le fasi degli interventi del teatro nel sociale, per esempio esperienze di teatro carcere o presso gli anziani. Anche questo genere è nato praticamente con la televisione e ha ormai una storia lunga, gloriosa e assai articolata. Rientrano nella categoria anche i cosiddetti Videodocumentari di creazione (su quest'ultimo tema vedi Sandra Lischi, Il linguaggio del video, Carocci, 2005).
3.
Al TTV di quest'anno non sono in programma né il geniale film-documentario di e su Marcel.lì Antunez Roca (El Dibuixant) né il ricco documentario presentato pochi mesi fa alla Berlinale sull'opera teatrale di Robert Wilson (Absolute Wilson), così come non è presente il film della Mnouchkine prodotto da Arté su uno dei suoi capolavori teatrali, Le dernier caravansérail. Si tratta di tre artisti di fama mondiale che hanno variamente sperimentato sia tecnologie in scena sia la riscrittura filmica dei loro spettacoli (tematiche dunque centrali per una manifestazione come TTV).
3. i promo e i clip: a caratterizzare questo format è la durata. Il genere si è affermato a partire dagli anni Ottanta, da un lato riprendendo analoghe esperienze in campo musicale, dall’altro sfruttando le maggiori possibilità d’accesso alle nuove tecnologie. Anche in questo caso, rientrano nel format i clip d’autore.
4.
Questa classificazione copre, secondo noi in maniera adeguata, il territorio interessato dal videoteatro fino all’inizio degli anni Novanta e all’avvento di internet.
La diffusione di nuovi supporti - cd-rom, internet, dvd, eccetera - ha però aperto la possibilità di creazione di nuovi format. Vista la tendenziale convergenza delle diverse piattaforme in un unico codice digitale, ci sembra inutile discriminare tra i diversi supporti.
4. piattaforme ipermediali: si tratta del filone che privilegia l’integrazione tra diversi media ed è indipendente dalla piattaforma che lo supporta. Rientrano dunque in questa categoria computer-mediated projects, oggetti mediali, siti internet, network e piattaforme web; blog; crossmedial projects: ipertesti drammaturgici open source, digital story telling.
5.
I format finora elencati trascurano però un aspetto centrale del rapporto tra teatro e video, ovvero - più in generale - l’utilizzo delle nuove tecnologie sulla scena, le performance teatrali che usano le tecnologie informatiche. Si tratta di un nuovo teatro virtuale che tra l’altro negli ultimi tempi sta vivendo una nuova fioritura grazie alla maggior facilità d’uso e ampia diffusione di interfacce per l'animazione e la grafica 3D Real Time, sistemi di Motion capture, interfacce aptiche e tecnologie blue o green screen sperimentando diversi livelli di interattività instaurabili con lo spettatore. Pensiamo anche ai progetti di teatro virtuale concepiti per e con la rete (streaming video-theatre, teatro chat, live performance on line, dal Desktop Theatre, al APT di Birringen)..
Sull'argomento vedi tra l’altro:
- Theatrical Performance in the World Wide Web di Gabriele Pfeiffer pubblicato sulla rivista “Trans”;
- il saggio dedicato al progetto Hamnet in Internet Relais Chat.
Possiamo raccogliere queste esperienze, certo molto differenziate, in un altro filone di sperimentazione tecnica e linguistica.
5. spettacoli dal vivo con uso di nuove tecnologie: si va da una soluzione basica, l’uso del video in scena, che appare ormai arcaica, fin troppo “facile”, diffusa e invadente, a varie forme di telepresenza, dal già citato impatto dell'animazione e della grafica 3D real time e dei sistemi di motion capture ad ambienti virtuali immersivi e interattivi fruibile tramiti connessione web, alle performance con console wireless che interagiscono direttamente e visibilmente con il landscape sonoro e visivo della rappresentazione in atto.
Si può recuperare l'utile distinzione di Franck Bauchard sui due tipi di interfacce che aprono la riflessione sul fronte del teatro interattivo:
Nel primo tipo di interfacce, il dispositivo materiale e il software serve da mediatore fra il computer e delle unità periferiche (camere, strumenti tradizionali e virtuali…). Ci si orienta allora verso la costituzione di vere e proprie regie digitali, che combinano molteplici fonti sonori e visive: immagini video in presa diretta, elaborazione digitale dell'immagine in tempo reale, immagine prese su Internet, immagini d'archivio, voci off preregistrate, elementi musicali prodotti e trasformati in diretta…Questa regia digitale può essere controllata da tecnici, o più raramente dagli interpreti, il che comporta necessariamente che gli interpreti integrino ancor più nella recitazione le loro interazioni con le interfacce.
Il secondo tipo di ricerca sulle interfacce, più frequente in ambito coreografico che in ambito teatrale, è incentrato sulla creazione di oggetti o di “esseri” digitali interattivi a partire dalla captazione di movimenti degli interpreti. L'interfaccia si pone allora fra due sistemi di natura diversa, fra i quali il computer svolge delle operazioni di traduzione. Le interazioni fra il reale e il virtuale determinano allora lo svolgimento della rappresentazione e la costruzione dell'azione scenica.
Questi cinque format coprono secondo noi l’intero settore del videoteatro così come si è sedimentato (e come si è storicizzato), e come si presenta oggi. Al contempo offrono una prima griglia di orientamento in un settore produttivo sfaccettato, in continua e rapida evoluzione, purtroppo scarsamente esplorato e studiato, soprattutto in Italia. La colpa di questa arretratezza e scarsa conoscenza collettiva della ricerca tecnologica più attuale in ambito teatrale va attribuita proprio allo scarso aggiornamento dei festival che continuano a proporre i soliti noti del “Quartiere Italia” e a guardare con sospetto - se non addirittura a osteggiare fermamente - le performance tecnologiche. Se il TTV ha un compito, dovrebbe essere quello di offrire una sorta di “finestra sul mondo del tecnoteatro”, sensibilizzare pubblico e istituzioni, orientare la programmazione dei festival, promuovere il genere nelle sue varie articolazioni, attività a cui il TTV in verità è sempre stato ben poco incline.
Più in generale l'Italia festivaliera non ha mai ospitato, per fare degli esempi significativi, il francese Jean François Peyret, i giapponesi Dumb Type, gli statunitensi Critical Art Ensemble e solo da pochi anni grazie a Polverigi e a RomaEuropa abbiamo avuto l'onore di vedere anche da noi il Big Art Group o William Kentridge (ai quali significativamente il TTV non ha mai dedicato alcuno spazio, così come non ha mai proposto una riflessione organica sul percorso di Robert Lepage). Ma anche alcuni tra gli italiani “più famosi” che si occupano di tecnologia a teatro vengono quasi del tutto oscurati in patria: Studio Azzurro, Paolo Atzori e Roberto Paci Dalò svolgono ormai la loro attività performativa quasi esclusivamente all'estero...
A cosa sono sensibili i direttori dei festival italiani? Alla carta stampata, alla moda, alle celebrazioni dei centenari, al “fenomeno” della stagione creato a tavolino? E all'estero? Quasi tutti i festival o spazi di ospitalità anche multimediale prevedono dei Call for proposal, da Fresnoy in Francia al festival di live arts “New Territories” di Glasgow, a “News Forms” in Arizona.
Crediamo che ci siano tutti presupposti affinché si apra un dibattito serio e costruttivo sulla produzione tecnoteatrale italiana e internazionale, individuando eventualmente nuovi luoghi e nuove realtà che possano ospitare un confronto continuo e proficuo.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
La tecnologia delle idee: Marcel.lí Antunez Roca El Dibuixant
Il video di Marcel.lí Antunez Roca e Miguel Rubio
di Annamaria Monteverdi

Un'immagine di El Dibuixant.
Marcel.lí Antunez Roca, l’artista mecatronico catalano, ha realizzato recentemente, insieme con Miguel Rubio, un imperdibile e autoironico film documentario sulla sua carriera artistica dal titolo El Dibuixant. Un documentario decisamente atipico come è facile immaginare, che racconta la sua intera vicenda tecnoartistica attraverso folli disegni a cartoon realizzati dallo stesso artista a mo’ di affreschi sulla parete del suo studio a Barcellona - e successivamente animati - e attraverso video testimonianze. Dalla fondazione della Fura dels baus alle performance di cabaret con Los Rinos, alla creazione insieme con Sergi Jordà, Roland Olbeter e Tony Aguillar dei robot e delle interfacce corporali delle sue installazioni e performance “sistematurgiche”: da Epizoo ad Afasia, a Pol. Passano in rassegna i giovanili lavori artistici di Marcel.lí, frammenti dei film e delle performance di strada, mentre il filo conduttore è segnato dal lungo rituale della pitturazione del suo corpo con segni tribali. Alla fine del documentario, vestito solo di biacca, accompagna i figli piccoli in giro per la città.
Un colorato e ricco documentario che parte significativamente da un’intervista alla madre che racconta di un bravissimo ragazzino che disegnava dentro il negozio di macelleria e aveva una sensibilità artistica innata.
Il grande lancio internazionale con la Fura dels Baus nel 1979 che rappresentò la corsa verso la violenza, i gesti estremi, l’esposizione del corpo, in un teatro di strada così rivoluzionario che fu subito definito “la seconda avanguardia”.
“Accions era un’epifania, una rivelazione, uno style bible, un rituale”; poi i film: Retrats e Fronton. I temi esplorati: la reinterpretazione della sessualità e della morte; “Il corpo è sacro, emotivo, sensibile, primitivo. Il corpo è la frontiera e la realtà dell’esperienza”. Epizoo segna un capitolo artistico nuovo e un cammino in solitario: è un’installazione dove la modalità di interazione, sempre differente, è gestita dal pubblico con un mouse attraverso un’interfaccia corporale, il dressskeleton, con cui si accanisce contro l’artista come un torturatore. “Si basa sull’idea della vulnerabilità del corpo, del limite, della sessualità, del controllo, del potere e della crudeltà attraverso la partecipazione dello spettatore”. Requiem, è invece il “sarcofago meccanico”, un esoscheletro robotico che ha la possibilità di muoversi fino a 19 gradi.
Ma è con i laboratori chiamati Satel-lits che prova a rimettere in gioco la metodologia collettiva della prima Fura. Come iniziati a strani rituali, orge e sacrifici umani, le persone partecipavano a un laboratorio di creazione dove si provava “un tocco di dionisiaco: il pomodoro era sangue, il latte sperma, la frutta carne; la tavola era l’altare del sacrificio, l’altare per messe nere, il talamo nuziale. Come missionario del corpo, divento la Supermarionetta che si è sacrificata per salvare tutti. Il 70% delle persone non arrivava neanche a metà dei laboratori”.
Afasia è forse la più famosa performance di Marcel.lì: “E’ basata sull’idea della ricostruzione del mito di fondazione della nostra cultura, l’Odissea, attraverso una reinterpretazione del linguaggio di oggi, un linguaggio afasico. Include un’interfaccia corporale, immagini interattive, suoni interattivi e robot musicali. Per me è bello poter essere un giorno come i classici, per i quali la tecnica non era importante ma erano importanti le idee. La tecnologia non è importante in sé, ma grazie a essa stiamo entrando in un mondo di idee. Afasia è stato un grande laboratorio di idee, è stato la costruzione di un universo di simboli”. In Afasia Marcel.lì non indossa la classica tuta ma un dresskeleton con robusti potenziometri perfettamente aderenti al corpo, composti di cavi e parti metalliche che gli permettono di intervenire in tempo reale su suoni, immagini e robot. “Parlo del mio lavoro come di una sistematurgia, una drammaturgia che ha bisogno dell’informatica, una drammaturgia basata sul principio della gestione della complessità del computer. La sistematurgia è fondamentalmente un processo interattivo che indaga attraverso nuovi prototipi, un arco di mediazione che include l’interfaccia, il calcolo e i nuovi mezzi di rappresentazione. Non è un teatro-video in cui si vedono immagini che sono state fatte prima e che si sviluppano in maniera sequenziale. La sistematurgia sta al servizio di una narrazione, di un racconto, di un organismo teatrale ma lo fa in maniera interattiva usando uno strumento ipermediale”.

Un'immagine di El Dibuixant.
Nel documentario viene illustrata la stretta collaborazione con ingegneri, informatici, software e robot designer, compagni che da tempo lo accompagnano in questo viaggio artistico. Sergi Jordà ha spesso insistito in alcuni articoli sul fatto che il concepire e costruire nuovi sistemi interattivi implica una parallela ricerca di malleabilità di funzione tra l’interfaccia e chi lo controlla in scena e contemporaneamente la messa a punto di un design tale da far intuire e comprendere al pubblico il processo. E afferma che il linguaggio interattivo è spesso più vicino a un viaggio spaziale, geografico. La metafora preferita da Jordà è quella dello spettacolo come un mare con isole e il performer può passare da uno all’altro, ciascuno con propri elementi interattivi e comportamenti, ciascuno con una propria interfaccia, con una mappa di input e output variegata e diversi gradi di libertà o restrizione di movimento.
Il film testimonia infine, le ultime installazioni, o biosculture, teche e colonne biologiche composte di organismi, di spore e funghi (Agar) che per Marcel.lí rappresentano la vita: “La vita è affascinante, non si ferma mai”.
A che punto siamo con Antonin Artaud?
Tre domande a Marco De Marinis
di Redazione ateatro
A fare il punto ci sono mostre, come quella ospitata al PAC di Milano Artaud - Volti - Labirinti. Ma anchr iniziative editoriali, come il numero monografico della rivista "Culture teatrali" in uscita a maggio, e la riproposta del saggio di Marco De Marinis La danza alla rovescia di Artaud. Il Secondo Teatro della Crudeltà (1945-1948) (Roma, Bulzoni, 2006), in una seconda edizione riveduta e corretta con l’aggiunta di una Postilla 2006. Proprio a Marco De Marinis abbiamo chiesto di fare il punto sulla fortuna di Artaud nel nostro paese.
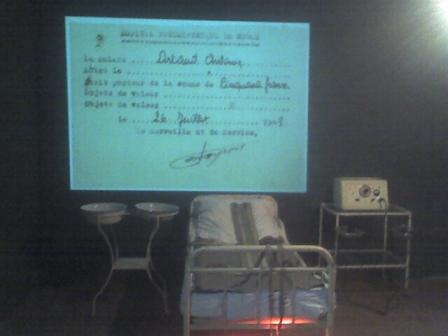
In mostra al PAC: la ricostruzione della stanza del manicomio di Rodez in cui Antonin Artaud fu sottoposto a elettroshock.
L'interesse italiano per Artaud sembra ancora assai vivo. Sia sul versante dell'editoria (per esempio con il volume adelphiano dove Manganaro e Molinari hanno tradotto appassionatamente il pressoché intraducibile Suppots e Suppliciations) che dell'arte (con la mostra ospitata di recente al PAC di Milano) ed infine della convegnistica (I-mode visions a cura di Massimo Puliani a Macerata). Come si inseriscono in questo contesto la ripresa del tuo libro e il nuovo numero di "Culture teatrali"?
Credo che, in Italia, l’interesse per Artaud non sia mai venuto meno, almeno sul piano della pubblicistica, dagli anni Sessanta in poi. E tuttavia non si possono non cogliere dei fatti nuovi. Sicuramente il centenario della nascita, giusto dieci anni fa, ha contribuito a stimolare da noi, oltre che ovviamente in Francia e un po’ in tutto il mondo, una gran quantità di studi e ricerche nuove. La conclusione, positiva, dell’annosa controversia legale sull’eredità di Artaud, all’indomani della scomparsa di Paule Thévenin, nel 1994, ha aiutato molto in questo senso, fra l’altro permettendo finalmente agli studiosi l’accesso diretto al prezioso archivio e, in primo luogo, ai mitici 406 cahiers riempiti fra Rodez e Ivry. Infine, una nuova generazione di studiosi si è affacciata alla ribalta con esordi spesso molto promettenti. Penso, per quanto riguarda l’Italia, a Florinda Cambria, Marco Dotti, Giorgia Bongiorno, Pasquale Di Palmo, Fabio Acca. Detto questo, come spiego nell’introduzione al numero 11, in uscita, di “Culture Teatrali” dedicato ad Artaud, la situazione degli studi sul grande visionario francese non è poi così soddisfacente come potrebbe sembrare a prima vista. In particolare, sugli anni Quaranta, l’ultima straordinaria stagione creativa di Artaud, c’è ancora moltissimo da scavare, indagare, capire –soprattutto per quanto riguarda il teatro. Fino a pochi anni fa, neppure si voleva accogliere seriamente l’idea che fosse esistito un nuovo, potente progetto teatrale messo in campo da Artaud negli anni di Rodez e del dopo Rodez: quello che io ho chiamato (nel libro La danza alla rovescia di Artaud, uscito nel 1999 e oggi ripubblicato in una nuova edizione in uscita presso Bulzoni di Roma) il Secondo Teatro della Crudeltà. Nonostante l’apparente disinteresse in cui la proposta sembrò cadere, debbo dire che le cose al riguardo oggi sono cambiate e nessuno più dubita dell’importanza del teatro (anche se “senza spettacolo”) per capire l’ultima straordinaria produzione grafica e letteraria, o meglio, poetica, del grande teorico della Crudeltà.
Invece sul versante teatrale, ci pare in atto una diversa tendenza. Negli anni Sessanta e Settanta, per Grotowski, il Living Theatre, Brook e tutto il teatro che si è ispirato al loro lavoro (e non solo), le teorie di Artaud erano centrali, una grande fonte d'ispirazione ed energia. Quello che si fa oggi ci pare invece un teatro meno artaudiano, o forse solo meno esplicitamente artaudiano. Condividi questa impressione?
Potrei dire di condividere questa impressione ma in realtà credo che si potrebbe sostenere anche, e forse più fondatamente, il contrario. Potremmo chiederci: nella radicale fuoriuscita dal Novecento teatrale, che è in atto da tempo, sia nelle teoresi che nelle pratiche sceniche odierne, qual è l’unica figura della Grande Riforma che continua ad essere citata e, in ogni caso, a fecondare in qualche modo la creatività delle nuove generazioni teatrali? Fateci caso: chi cita più Stanislavskij, Mejerchol’d, Copeau, Craig, ma anche Grotowski, Barba, Brook, eccetera eccetera, fra gli esponenti delle ultime leve, diciamo dalla Societas Raffaello Sanzio in avanti? Più nessuno, o quasi. I loro riferimenti sono altri ormai: letterari, filosofici, artistico-visivi, cinematografici, scientifici magari, ma sicuramente non riguardano la cultura teatrale del Novecento. A fare eccezione sono pochissimi nomi, e fra questi il primo è appunto quello di Artaud (e poi, direi, di Carmelo Bene). Quanto al fatto, poi, che oggi si proponga un “teatro meno artaudiano”, beh, mi verrebbe di dire (pensando ai guasti che certe maldestre mimesi della Crudeltà hanno provocato in passato, soprattutto da noi) per fortuna! In realtà la lezione artaudiana è stata fatta propria in maniera profonda dalla scena postnovecentesca. Per limitarmi al contesto italiano, il lavoro dei gruppi e degli artisti rappresentativi del meglio del nuovo teatro italiano oggi (come Raffaello Sanzio, Teatro della Valdoca, Pippo Delbono, Enzo Moscato, Le Albe di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, Emma Dante) tiene conto autenticamente della sua sfida impossibile. Ovviamente, non si tratta di rifare Artaud, di mettere in pratica le sue indicazioni (già nel 1964, all’epoca del lavoro per Marat-Sade, Brook avvertiva come fosse impossibile e comunque pericolosa una scelta del genere); si tratta invece di confrontarsi in profondità, coraggiosamente onestamente rigorosamente, con la sua esperienza e con le sue visioni: termini di confronto ormai imprescindibili per chi vuol fare arte interrogandosi seriamente sul senso del fare arte oggi.
La mostra ospitata al PAC sottolineava da un lato la molteplicità delle forme in cui si è espresso Artaud (oltre al teatro, le arti visive, il cinema, la poesia...), ma anche l'aspetto biografico, con una impressionante ricostruzione della stanza del manicomio di Rodez in cui Artaud veniva sottoposto a elettroshock. Questa attenzione per aspetti centrali e clamorosi della parabola artaudiana non rischia di mettere in secondo piano i suoi testi? O, se vogliamo semplificare, Artaud è stato più rivoluzionario nella vita o nei suoi testi? O i due aspetti sono inseparabili?
E’ insopportabile il voyeurismo morboso che spesso caratterizza l’interesse rivolto ad Artaud (già con lui vivente). E tuttavia non si può negare che ciò dipenda anche dal fatto che in lui l’intreccio fra vita e arte, fra esistenza e poesia, diventa fin dall’inizio talmente stretto da renderli di fatto inseparabili. Di conseguenza, per penetrare nei segreti della poesia e del teatro artaudiani, l’indagine sulla sua biografia è indispensabile, con tutti i rischi che ne possono conseguire. Teniamo, del resto, presente un dato: a dispetto delle apparenze, la vita di Artaud è ancora piena di buchi e misteri irrisolti. Si pensi, ad esempio, a due grandi viaggi, del ‘36-37, in Messico, prima, e in Irlanda, poi. Oppure al periodo dei primi internamenti, fra ‘37 e ‘42. O alla questione delle origini ebraiche della famiglia, causa di un forte shock, quando furono da lui scoperte tardivamente, eccetera eccetera. Non ci si deve chiedere se Artaud è stato più rivoluzionario nella vita o nei testi; egli è stato rivoluzionario, cioè la sua ricerca è stata fra le più coraggiose ed estreme del Novecento, proprio perché vi ha annullato quasi ogni distinzione fra l’una e gli altri; la sua opera nasce proprio dal superamento di ogni rassicurante separazione fra arte e vita. Direi come in Beckett o in Grotowski o in Julian Beck, per citare tre figure molto diverse da lui e che però con Artaud condividono questa radicalità d’approccio all’arte come casa dell’Essere.
Antonin Artaud: Postilla 2006
da La danza alla rovescia di Artaud. Il Secondo Teatro della Crudeltà (1945-1948), Roma, Bulzoni, 2006
di Marco De Marinis
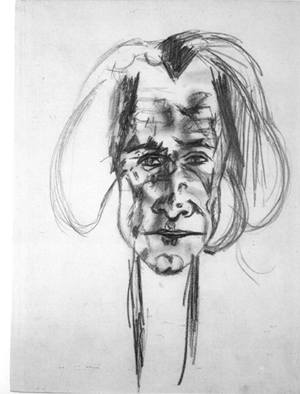
1. “Chi ha letto Artaud?”
Ancora Artaud? Ebbene sì, ancora Artaud. Perché, nonostante la montagna di carta che continua implacabilmente ad accumularsi sul suo conto, il visionario autore de Il Teatro e il suo doppio non cessa di costituire il caso estremo di una situazione negativa che riguarda, purtroppo, quasi tutti i grandi uomini di teatro del Novecento. Per riprendere quanto ebbe a scrivere Fabrizio Cruciani a proposito di Jacques Copeau, essi costituiscono, ancora oggi, dei “miti più noti che conosciuti”, della figure che “fingiamo di conoscere attraverso etichette e definizioni”.[2]
Naturalmente la questione non riguarda soltanto l’Artaud maestro (controverso) di teatro ma anche, e forse soprattutto, il complesso sterminato di un’opera che comincia a porre problemi già nel momento in cui si cerca di delimitarla in maniera troppo precisa. Ha scritto Marcelin Pleynet nella relazione introduttiva ad un convegno, del 1998, intitolato “Omaggio ad Antonin Artaud”:
Omaggio ad Antonin Artaud. Perché? Forse che oggi disponiamo a tal punto dell’opera e del pensiero di Artaud da essere effettivamente in grado di rendergli omaggio? Che sappiamo di Artaud? Fate un’indagine. Chi ha letto Artaud? Che cosa se ne è letto? E come?[3]
D’altro canto, la montagna di carta che non smette di crescere denuncia chiaramente come il problema sia, anche e soprattutto, quello di una radicale ridiscussione dei modi in cui la critica, in tutte le sue diramazioni disciplinari, si è esercitata, e forse accanita, su questo autore, finendo quasi sempre per parlare più di se stessa che dell’opera che ne costituiva di volta in volta il pre-testo. E allora forse ha ragione Camille Dumoulié quando, nelle prime righe della sua recente monografia, osserva:
Forse bisognerebbe smettere di scrivere su Antonin Artaud. E, perché no?, di pubblicarlo. Ci metteremmo allora a leggerlo veramente.[4]
Un suggerimento del genere era già venuto da Ferdinando Taviani, soprattutto in riferimento all’ultimo, difficilissimo Artaud: “Meglio ancora sarebbe trattenersi: leggere e tacere”.[5]
Ci vuol poco a trasformare posizioni come queste, ispirate a puro buon senso nella loro utile, provocatoria paradossalità, in qualcosa di molto diverso, di qualunquistico, se non di reazionario, del tipo: Artaud si spiega da solo, i suoi testi bastano a se stessi, smettiamo di studiarlo e analizzarlo, etc. etc. In realtà, è vero proprio il contrario, come si diceva all’inizio: c’è ancora tantissimo da fare, da conoscere, da capire, da indagare, in Artaud e nella sua straordinaria produzione. E la ovvia priorità che va riconosciuta all’opera, in questo come – del resto - in tutti gli altri casi, non ci esime dall’obbligo dell’impegno critico e storiografico, rappresentando invece la pre-condizione per poterne fare qualcosa di diverso da un vuoto esercizio narcisistico.
Del resto, nonostante il pessimismo di questo attacco, arrivano segnali incoraggianti dalla bibliografia artaudiana degli ultimi anni. E in particolare da noi, in Italia, sta emergendo una nuova generazione di studiosi molto agguerriti,[6] che lasciano ben sperare per il futuro, anche se non mancano i problemi, almeno per quanto riguarda il teatro. Sotto questo aspetto, infatti, la situazione italiana sembra allinearsi a quella internazionale, nella quale il punto di vista teatrale, o teatrologico, non è quasi mai stato quello privilegiato per l’indagine su Artaud e la sua smisurata operatività.
D’altro canto, questa indubbia perifericità della prospettiva teatrale nei contributi delle nuove leve della critica artaudiana è anche una conseguenza dell’appuntarsi prevalente, se non esclusivo, dei suoi interessi sull’ultimo Artaud, quello degli anni Quaranta, di Rodez e del ritorno a Parigi, nel quale – a prima vista - il teatro non sembra avere la stessa centralità che deteneva nei due decenni precedenti, almeno non il teatro-spettacolo, nel senso corrente del termine.

2. Due eventi editoriali
Esaurite le premesse, non si può non partire da due eventi editoriali recenti, mentre è annunciata, finalmente, la ripresa della pubblicazione delle Oeuvres Complètes presso Gallimard, ferma al XXVI volume dal 1994, anno della scomparsa della curatrice Paule Thévenin.
Il primo dei due eventi riguarda la pubblicazione della traduzione italiana dell’ultima opera concepita da Artaud (che tuttavia non poté vederne l’uscita), e cioè Suppôts et suppliciations, apparsa da Adelphi in un’edizione a cura di Jean-Paul Manganaro, che ne è stato anche il traduttore, e Renata Molinari.[7] Questa edizione è basata interamente su quella curata da Paule Thévenin nel 1978 e uscita, in due tomi, come XIV volume delle Oeuvres Complètes.[8] Si tratta di un avvenimento importante, che mette finalmente a disposizione del lettore italiano, nella sua interezza,[9] una delle opere capitali di Artaud, forse la più difficile e complessa.
Una vera e propria presentazione di Succubi e supplizi non può ovviamente rientrare fra gli scopi di questa Postilla. Mi limiterò a poche osservazioni riguardanti l’operazione editoriale, sperando che non sembrino eccessivamente pedanti. Scrivono i due curatori nella breve Nota all’edizione italiana:
Il dattiloscritto, parzialmente rivisto da Artaud, presentava, soprattutto nella parte intitolata Interjections numerosissime lacune, dovute a diversi fattori; e molti testi, che pure figuravano nell’indice dell’edizione K [ci si riferisce al progetto originario di Artaud, predisposto per l’editore Louis Broder e poi, in seguito al ritiro di questi, ceduto appunto alle edizioni K, che non daranno seguito alla pubblicazione a causa di sopraggiunte difficoltà finanziarie], erano addirittura scomparsi […] Malgrado una prima ricostruzione compiuta dall’autore, Paule Thévenin dovette ricorrere, per giungere a stabilire la forma attuale del testo, sia ai manoscritti di Artaud sia ai quaderni scritti sotto dettatura da Luciane Abiet [la segretaria messa a disposizione da Broder] sia agli ospuscoli pubblicati da case editrici minori e non sempre rivisti da Artaud.[10]
Questo significa che, con Suppôts et suppliciations, ci troviamo in quella zona della produzione di Artaud in cui le scelte della curatrice hanno avuto una grandissima incidenza, arrivando a decidere anche quale versione di un certo testo preferire, eleggendola così ad autentica, e persino, talvolta, quali testi includere. Da alcuni anni, e senza con ciò voler togliere nulla all’importanza decisiva della sua dedizione di un’intera vita per la conoscenza dell’opera artaudiana, i criteri editoriali e filologici utilizzati da Paule Thévenin nel pubblicare i testi di Artaud, soprattutto nel caso di quelli rimasti inediti o comunque non rivisti interamente per la stampa dall’autore o addirittura neanche da lui predisposti per la pubblicazione, sono oggetto di discussione.
In ogni caso, la messa a disposizione, presso la Bibliothèque Nationale di Parigi, dei 406 quadernetti di scuola che egli riempì ininterrottamente dal gennaio del ‘45 al marzo del ’48, e che costituiscono il laboratorio di tutti i suoi scritti degli ultimi anni, compresi Suppôts et suppliciations, consente ormai di compiere verifiche e riscontri preziosi. Dai quali, forse, oggi non si può più prescindere quando si pubblicano, o si traducono, testi inediti e controversi come quello in questione; e, più in generale, per tutti i Cahiers de Rodez (O.C. XV-XXI) e i Cahier du Retour à Paris (O.C. XXII-XXV).
Il fatto di aver avviato (e su vasta scala) questo indispensabile lavoro di ritorno diretto agli originali artaudiani è uno dei meriti principali del secondo evento editoriale di cui intendo parlare. Per tutta una serie di ragioni oggettive, esso costituisce di gran lunga il più importante fra i due.
Mi riferisco all’apparizione, per le edizioni Gallimard (collana “Quarto”), del gigantesco volume di 1792 pagine (al prezzo di soli 35 euro, mi si scuserà la volgarità del riferimento al vile danaro) Oeuvres, curato da Evelyne Grossman.[11] Si tratta di una pubblicazione dalla quale, per molto tempo, gli studiosi o semplicemente gli appassionati di Artaud non potranno prescindere. Essa mette a disposizione tutte le sue grandi opere, i libri composti come tali e quasi sempre da lui stesso pubblicati, ma con non poche eccezioni: infatti, oltre al già citato Suppôts et suppliciations, anche Messages revolutionnaires e Les Tarahumaras sono usciti postumi. Inoltre, il maxi-volume propone una larghissima scelta di articoli, scenari e testi diversi, di cui numerosi ancora inediti o introvabili, più di 200 lettere di cui alcune mai pubblicate, una iconografia abbondante, una biografia con molte informazioni nuove.
Anche in questo caso, un’ illustrazione esauriente del lavoro in questione (che avrò modo, comunque, di citare spesso nelle pagine seguenti) non può rientrare fra i compiti della presente Postilla. Mi limiterò a segnalarne due pregi. Il primo riguarda, appunto, il già ricordato ritorno alle fonti manoscritte. Anche la edizione di Suppôts et suppliciations se ne avvale e ciò permette alla curatrice di prendere in più occasioni le distanze dall’edizione Thévenin, che resta per altro imprescindibile.[12]
Riguardo ai criteri spesso troppo disinvolti della Thévenin, osserva, ad esempio, Evelyne Grossman:
La preoccupazione di Paule Thévenin di dare da leggere dei testi completi l’ha in effetti portata a volte a gettarsi in montaggi o ricostruzioni azzardati.[13]
In proposito, il caso forse più clamoroso è quello della celebre conferenza al Vieux-Colombier del gennaio 1947,[14] per la quale si può dire che il testo pubblicato nel vol. XXVI delle O.C. sia “inventato” di sana pianta, in quanto composto dalla stessa Thévenin:
Precisiamo per cominciare che non esiste un testo vero e proprio di questa conferenza. […] I testi pubblicati da Paule Thévenin sotto il titolo Histoire vécue d’Artaud-Mômo-Tête à tête par Antonin Artaud (O.C. XXVI) sono costituiti da tutta una serie di frammenti, note e abbozzi diversi che ha prelevato da quasi una trentina di quaderni redatti da Artaud nei mesi che precedettero la seduta.[15]
Del resto, obiezioni molto pertinenti le erano già state rivolte da Serge Malausséna, nipote di Artaud e suo erede universale, alla conclusione delle infinite controversie legali che hanno caratterizzato il lascito letterario e artistico di Artaud, e dopo aver proceduto, nel 1995, alla comparazione fra i manoscritti e la loro edizione nelle O.C., dal vol. XV in avanti.[16]
Il secondo pregio fondamentale del “Quarto” gallimardiano riguarda il modo in cui è organizzata la materia. Scartato il criterio tematico o di genere (poesia, teatro, cinema, pittura etc.), la Grossman ha optato per un’ organizzazione rigorosamente cronologica, che presenta a conti fatti numerosi vantaggi, non tutti scontati. In primo luogo, essa conferma inoppugnabilmente come la frequentazione, pratica e teorica, di più linguaggi e di più mezzi espressivi sia originaria in Artaud: fin dagli inizi, egli si interessa attivamente di poesia-cinema-teatro-narrativa-arti visive, animando un formidabile, ininterrotto laboratorio pluridisciplinare, di cui colpiscono la prolificità e l’originalità. In secondo luogo, la composizione cronologica, liberando il teatro dal ghetto, sia pure dorato, in cui lo si è spesso rinchiuso, permette di far emergere in tutta la sua evidenza l’importanza decisiva che esso ha avuto quasi ininterrottamente, lungo tutto l’itinerario artistico-intellettuale-esistenziale di Artaud, e che va molto al di là del pur capitale Il Teatro e il suo doppio.
Si tratta di una presenza qualitativa, piuttosto che quantitativa, la quale fa del teatro (naturalmente nelle accezioni anche profondamente diverse che questo termine, con gli altri ad esso correlati, assume via via) il vero fil rouge dell’immenso corpus artaudiano, come già la predilezione per la forma-lettera lascia, del resto, intuire.[17]
Teatro, quindi, come dimensione unificante di un’opera per altri versi quanto mai diversificata, eterogenea, irriducibile a formule e a generi; teatro come dimensione unificante delle varie pratiche e dei vari livelli di attività di Artaud (dei suoi “doppi”, come mi è accaduto di chiamarli nel presente volume); teatro come tensione costante dell’uomo, dell’intellettuale, dell’artista, dello scrittore, da non banalizzarsi in teatralità, esibizionismo, istrionismo; teatro, insomma, come chiave privilegiata per penetrare il senso più profondo e profondamente coerente, da un punto di vista filosofico e direi anche direttamente politico, del disperato ma potente e ininterrotto ricercare di Artaud.
Questa chiave sta nascosta, venendo via via diversamente elaborata, in termini e immagini folgoranti come crudeltà, metafisica, alchimia, peste, atletismo affettivo, soffio, corpo senz’organi, danza alla rovescia; ma essa è già racchiusa tutta nella “posizione della carne”, densa formulazione di un articolo del 1925, cui giustamente la Grossman assegna grande rilievo, estraendone il tema decisivo, forse, dell’intera quête artaudiana: fondamento della sua concezione dell’arte, della poesia, del teatro, e giustificazione, diciamo pure filosofica, se non proprio metafisica, della permanente centralità di quest’ultimo.
Secondo l’analisi della studiosa, dalle straordinarie opere dell’esordio letterario, che resteranno fra le più importanti e le più lette dell’intera sua produzione (la Correspondance con Jacques Rivière, del ’24, L’Ombilic des limbes e Le Pèse-Nerfs, usciti a distanza di poche settimane l’uno dall’altro nel ’25, e, appunto, il breve testo Position de la chair, apparso in quello stesso anno sulla “Nouvelle Revue Française”),[18] prende consistenza una vera e propria “teoria energetica”, secondo la quale “il pensiero sorge dalla carne, nel più profondo dell’impulsività della materia, nella vibrazione dei nervi”.[19]
Non è certo un caso se, nella notevole, limpidissima sintesi della teoresi teatrale di Artaud, approntata poco prima dell’improvvisa scomparsa da quello che dobbiamo considerare forse il suo maggior esegeta italiano, e cioè Umberto Artioli, è lo stesso articolo a trattenere l’attenzione. La premessa di Artioli consiste nel riconoscere che nei primi scritti di Artaud, quelli che ho appena menzionati,
domina l’idea, di chiara matrice gnostica, di un cosmo avvelenato, retto da una divinità malvagia o insipiente che, condannando l’uomo al carcere della materia, vanifica ogni slancio dello spirito diretto alla sua emancipazione. […] Per sfuggire al suo io frammentato, [Artaud] vorrebbe sciogliersi dal corpo, acquisire la levità del vento o del pneuma, tramutarsi in aria sottile. Egli sa che per vivere occorre accettare la carne ingombrante, sfidare l’impulsività della materia, l’emergenza ferina della parte istintuale dell’essere.[20]
Ma è proprio Position de la chair ad aprire un’altra prospettiva, e una possibile via d’uscita:
Forse la carne non è solo male; forse la fisicità, che per esistere richiede materia e spessore, è spirito imprigionato in attesa di riscatto; forse nei bassifondi della Creazione, nel cosmo sotterraneo delle pulsioni più scandalose, c’è un’aspirazione malcelata a sollevarsi e ad ascendere.[21]
E Artioli cita dall’articolo:
Queste forze informulate che mi assediano, occorrerà che la mia ragione un giorno le accolga, che si installino al posto del pensiero elevato, queste forze che al di fuori hanno la forma di un grido. Ci sono gridi intellettuali, gridi che provengono dalla sottigliezza delle midolla. E’ ciò che chiamo la Carne. Io non separo il mio pensiero dalla mia vita. A ogni vibrazione della mia lingua, io rifaccio tutti i percorsi del mio pensiero nella mia carne.[22]
La conclusione, provvisoria, è la seguente:
Sempre più il palcoscenico gli appare l’unica via di salvezza, un modo per riappropriarsi del flusso energetico da cui è separato.[23]

3. Questioni biografiche
In Artaud il nesso arte-vita è talmente stretto, inestricabile, fin dall’inizio, che nel suo caso l’indagine biografica assume un’importanza e una necessità ben superiori agli inevitabili rischi insiti in ogni biografismo, freudiano e non.
Ora, se – come si diceva in apertura di queste note - l’opera artaudiana risulta ancora oggi una galassia testuale più citata che letta e conosciuta veramente, lo stesso si deve dire della sua esistenza: sappiamo molto di più, ovviamente, dell’autobiografia mitica, alla cui costruzione Artaud si dedicò febbrilmente negli anni Quaranta, che della sua vita reale. Qualche esempio.
L’ebraicità rimossa. Sylvère Lotringer, di recente, ha rilanciato la questione delle radici ebraiche della famiglia di Artaud: radici che, scoperte tardivamente a diciotto anni, avrebbero avuto un effetto di shock su di lui, a causa dei pregiudizi antisemiti inculcatigli dalla rigida educazione cattolica, e sarebbero state oggetto di una vera e propria rimozione, attuata lungo tutta la vita. A questa traumatica scoperta Lotringer associa i primi disturbi nervosi, che in effetti cominciano a manifestarsi proprio in quell’anno, il 1914, e non lo abbandoneranno più. Tutte le controversie sulla problematica religiosità di Artaud dovrebbero –a suo parere- partire da questo dato di fondo, così riassumibile: “Egli non era né cristiano né anticristiano, ma peggio: un ebreo che non poteva dire il suo nome”; come Simone Weil (secondo lo studioso associata ad Artaud anche dalla scoperta tardiva e dolorosa della propria ebraicità), egli apparterrebbe alla schiera “degli ebrei gnostici che avevano fatto della loro impossibilità a credere una sfida al Dio cristiano ad esistere”.[24]
Forse era questa ebraicità, nascosta come una vergogna inconfessabile, il “segreto” di cui Artaud parla in una lettera a Anne Manson (14 settembre 1937);[25] e forse in questo segreto risiede un’altra chiave interpretativa delle innnegabili “ossessioni antisemite” che ricorrono con frequenza nei suoi scritti, soprattutto da una certa data in poi (a cominciare dal Sort del 5 settembre ‘37 contro Lise Deharme[26]). Queste ossessioni Lotringer le accosta –come ho già ricordato- a quelle di una scrittrice-filosofa dal cattolicesimo almeno altrettanto problematico, Simone Weil, e addirittura a quelle del Céline di Bagatelle per un massacro, che è del 1937.[27]
Interessanti risultano anche le considerazioni di Lotringer sul lungo calvario di Artaud negli ospedali psichiatrici durante la guerra. A suo parere, questi internamenti (non a caso chiamati, nella letteratura scientifica, lo “sterminio dolce”) gli fecero fare un’esperienza in tutto simile a quella degli ebrei nei veri campi di sterminio, a cominciare dalla fame.[28] Ben 40.000 furono i malati di mente che morirono di stenti e di abbandono nei manicomi francesi negli anni della guerra e dell’occupazione nazista. Lo stesso Artaud, del resto, si trovò a definire “deportazione” la propria esperienza, scrivendo nel ’46 a un vero deportato, Pierre Bousquet.[29]
Il trasferimento a Rodez, nel gennaio del ’43, sicuramente gli salvò la vita: questo nessuno lo nega ormai e – secondo Lotringer - dovrebbe bastare a rivedere con maggiore equilibro, e anche – perché no? - con una certa pietas, la figura del dr. Ferdière e il rapporto che ebbe con il suo più celebre paziente.[30]
I viaggi. Artaud viaggiò moltissimo, soprattutto con la mente: viaggi nello spazio e nel tempo (la Grecia antica, la Siria di Eliogabalo, il Messico di Montezuma e Cortés, le Galapagos e la Cina dei suoi reportage di giornalista da tavolino, l’Egitto esoterico del Libro dei Morti, il Tibet buddista, sede, da ultimo, delle sette che lo insidieranno con gli envoûtements, etc.); viaggi immaginari, fantastici o soltanto progettati e mai realizzati. Tutto sommato, sono quelli meglio documentati, dato che iniziano e finiscono sulla carta e nello scritto. Ma, qualche volta, Artaud viaggiò anche con il corpo e, in questi casi, si tratta quasi sempre degli episodi maggiormente controversi della intera sua esistenza.
Da bambino visitò regolarmente Smirne, la città d’origine della madre; e si sa di viaggi a Berlino e in altre città europee per il lavoro di attore cinematografico ma anche come spettatore teatrale. Si parla poco del primo viaggio extraeuropeo, che non fu quello in Messico ma un breve soggiorno in Algeria, nel luglio del 1934, ancora una volta per girare un film. Tuttavia, che si sia trattato di un episodio significativo, come primo contatto diretto con una cultura in buona parte estranea (nonostante la colonizzazione) a quell’Occidente che da tempo aveva messo al centro delle sue critiche, lo dimostra la lettera scritta a Jeanne Ridel, in data 21 giugno 1934.[31]
Quanto poi alla spedizione presso gli indiani Tarahumara, nel nord del Messico, c’è stato e c’è ancora chi (come Le Clézio, ad esempio) dubita che si sia realmente svolta.[32] Tuttavia, alcuni anni fa, Michel Camus ha pubblicato brani di una lettera ancora inedita di Artaud, datata 26 agosto 1936 e spedita da Chihuahua, dunque già in territorio Tarahumara, a un amico di Città del Messico: gli chiede di farsi dare del denaro dall’editore Botas per poter pagare cavalli, muli e guide, senza i quali – scrive - “rischio di non poter rientrare dai Tarahumara fra i quali mi trovo”.[33]
Del viaggio in Irlanda, nell’agosto-settembre 1937, nessuno dubita, invece, ma se possibile ne sappiamo ancora meno di quello sulla Sierra Madre del Norte. Perché qui mancano anche i rapporti di Artaud, che su questa esperienza, conclusasi drammaticamente con il rimpatrio coatto e il primo internamento psichiatrico, non scrisse nulla, né durante né dopo, se si eccettuano pochissime lettere, qualche cartolina e qualche disegno magico (i cosiddetti Sorts).
Quello che si sa, la Grossman lo riassume con precisione.[34] Tuttavia, nel 1999, un cineasta, Matthias Sanderson, si è messo sulle sue tracce in Irlanda, sessantadue anni dopo, girando un film documentario, Une histoire de fantôme: le voyage irlandais d’A. Artaud, (43 mm), da me consultato alla Bibliothèque Nationale di Parigi. Sanderson ripercorre le tappe e gli andirivieni di Artaud in terra irlandese, da Cobh a Dublino, da Dublino a Galway, fino a Kilronan, nelle nordiche isole Aran, sulle orme del drammaturgo Synge, e anche di Robert Flaherty, che vi aveva girato solo pochi anni prima il film L’uomo di Aran (1932-4). A Kilronan rintraccia la figlia della coppia che lo ospitò per quindici giorni (era molto piccola all’epoca e racconta di una persona vestita sempre di nero, che faceva lunghe passeggiate solitarie fuori dalle strade più battute e che spaventava i bambini agitando contro di loro un bastone; probabilmente proprio quel bastone, dotato a suo dire di proprietà magiche, che si era convinto fosse appartenuto a San Patrizio); poi di nuovo a Galway e infine a Dublino, dove Artaud venne rinchiuso per disturbo alla quiete pubblica nella prigione di Mountjoy. Il documentario si chiude con la lettera che Artaud scriverà mesi dopo, in data 23 febbraio 1938 (è la sua unica conosciuta per quell’anno), dal manicomio di Sotteville-lès-Rouen, indirizzandola a “Mr le Ministre d’Irlande” per informarlo del suo internamento e chiedergli di darsi da fare per la sua liberazione. Si firma Antoneo Arlanapulos e si dice cittadino greco nato a Smirne. Questa lettera è stata pubblicata per la prima volta nel 1999 e oggi la si può leggere nel “Quarto” di Gallimard.[35]
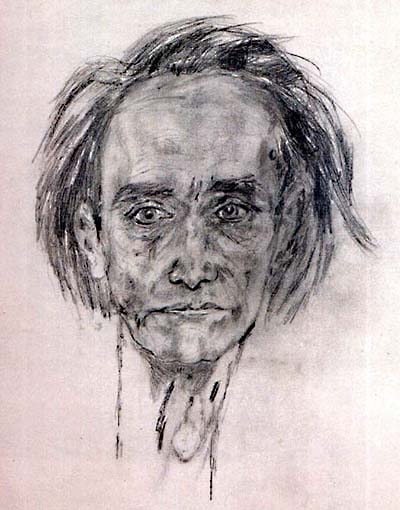
4. Microstorie
In molti contributi recenti abbondano i consigli su come uscire dall’impasse da cui sono partito in questa Postilla: da un lato, una montagna di carta che continua a crescere senza sosta e, dall’altro, nello stesso tempo, la sensazione frustrante che Artaud continui a sfuggirci, che non siamo ancora in grado di capirlo veramente. Si vedano, ad esempio, Camille Dumoulié, il quale enumera ben sei “criteri discriminanti, […] imperativi per una critica intensiva e vivificante”,[36] che sarebbe troppo lungo riportare qui, o, di nuovo, Evelyne Grossman, che propone una sua “ricetta” in tre punti (per altro di non semplice applicazione): “leggere tutto”, “leggere di traverso”, “imparare a leggere”.[37]
Per parte mia, da storico e più specificamente da storico del teatro, vorrei sfiorare un problema fra i tanti che rendono ancora oggi molto complicato capire per davvero Artaud: esso riguarda la frequente difficoltà, nonostante l’apparenza di una mole sterminata di dati e di testi a disposizione, di un’adeguata fondazione documentaria del discorso storico-critico su di lui; e ciò anche rispetto ad un campo, quello teatrale, sul quale - a torto - crediamo che si sappia già tutto e tutto sia stato già detto. Di conseguenza, più che di approcci globali e totalizzanti, che abbiano la presunzione di spiegarci per l’ennesima volta – più o meno definitivamente - chi è Artaud, di fornirci la chiave giusta per svelare, una volta per tutte, il suo segreto (o mistero), ritengo che ci sia bisogno nuovamente di approcci parziali, che abbiano l’umiltà di ripartire dai testi e dai documenti, cercandoli, quando mancano, sempre sforzandosi di interrogarli diversamente, sulla base di nuove contestualizzazioni e di domande inedite.
Si tratta, insomma, di ricominciare a fare i conti più direttamente con l’opera di Artaud, di leggerla sul serio (anche nelle sue zone meno frequentate), senza dare niente per scontato e accontentandosi di risultati limitati, addirittura modesti, ma fondati, e perciò in grado di far progredire, magari di poco ma realmente, la conoscenza di singoli e anche, perché no?, marginali aspetti dell’universo artaudiano. Insomma, c’è bisogno di indagini microstoriche, dedicate magari a questioni di rilievo circoscritto, almeno a prima vista.[38]
Prima di dire qualcosa su alcune delle piste più interessanti, a mio giudizio, per gli studi artaudiani dei prossimi anni, vorrei venire finalmente e più direttamente al teatro. In parte per contraddirmi subito e mettere in campo la necessità di ipotesi di ampio respiro, che facciano da sfondo e da contrappeso indispensabile ai sondaggi microstorici.

5. Il Secondo Teatro della Crudeltà
Nel 1999, cioè nella prima edizione del presente volume, ho proposto di parlare di un’ulteriore stagione del Teatro della Crudeltà per le teorie e le pratiche che, in qualche modo, possono essere riferite al teatro (sia pure in un’accezione estremamente dilatata) negli ultimi anni di vita di Artaud, quelli del “dopo la follia”.
E’ evidente che non si tratta di questione meramente nominalistica ma sostanziale: ipotizzare un 2° Teatro della Crudeltà, per gli anni Quaranta, significa finalmente cominciare a riconoscere organicità e originalità di visione a una congerie di scritti e di riferimenti “teatrali” (compresa la fondamentale opera grafica) su cui, per troppo tempo, ha gravato il pregiudizio congiunto della follia e della inarrivabilità del capolavoro degli anni Trenta, Il Teatro e il suo doppio, e per i quali, nel migliore dei casi, si era parlato di deriva frammentaria e delirante delle affascinanti elaborazioni del decennio precedente.
Se tale ipotesi (caduta in un apparente disinteresse)[39] ha un qualche fondamento, allora bisognerà chiedersi che cosa stia in mezzo a queste due grandi teatrologie, quella degli anni Trenta e quella degli anni Quaranta; più esattamente, e per usare un’espressione di Franco Ruffini,[40] diventa importante ricostruire, almeno nei suoi passaggi essenziali, l’”itinerario” di Artaud dal 1° al 2° Teatro della Crudeltà. Compito particolarmente complicato, visto che si tratta di fare i conti con gli anni dei vari internamenti manicomiali, e soprattutto con il “buco nero” che va dall’autunno del 1937 (primo internamento a Le Havre, appena sbarcato in camicia di forza dal traghetto “Washington”, e poi a Quatre-Mares a Sotteville-lès-Rouen) al gennaio 1943 (quando –l’ho già ricordato- Artaud viene trasferito nella clinica di Rodez): un periodo per il quale si è fatto ricorso in modo troppo disinvolto, quasi a mo’ di alibi, alla celebre definizione foucaultiana della follia come “assenza di opera”.[41]
In effetti, scavando un po’ più a fondo, si scopre che persino quegli anni bui (caratterizzati, fra l’altro, dalla perdita o comunque dal rifiuto della propria identità anagrafica) non furono del tutto privi di operatività, se non di opere: disegni (i già citati Sorts e i Gris-gris, fra l’altro),[42] molte lettere[43] e soprattutto l’embrione del singolare lavoro su di sé che prenderà forma più compiuta a Rodez e che credo di aver contribuito a restituire in maniera più appropriata all’attenzione degli studiosi di teatro.[44]
Nel “ritorno” di Artaud alla vita, al lavoro e al teatro (tre aspetti di un solo processo, a ben vedere), nel 1943-44, contarono molte cose: naturalmente, in primo luogo –come si è già avuto modo di ricordare- il netto miglioramento delle sue condizioni materiali nella clinica di Rodez, che si trovava nel sud della Francia, già liberato dall’occupazione tedesca, e dove egli poté riprendere ad alimentarsi in maniera più adeguata; il recupero progressivo di una rete di relazioni famigliari e amicali, che si era interrotta quasi del tutto negli anni più difficili, anche per sua volontà; gli effetti benefici del singolare training fisico-vocale, a cui si dedica incessantemente, versione aggiornata e adattata ai propri bisogni attuali dell’ “atletismo affettivo” degli anni Trenta; e poi, più specificamente: la scoperta di Lewis Carroll; la “riscoperta” del suo stesso libro dimenticato, Il Teatro e il suo doppio; il ritorno intensivo alla pratica del disegno, sempre più strettamente intrecciato con la scrittura (come nei cahiers, ma non soltanto); infine, last but not least, il viaggio nel Messico dei Tarahumara, sul quale – dopo averlo fatto “a caldo”, fra 1936 e 1937 - torna a scrivere a più riprese, dal dicembre 1943 fino a pochi giorni prima della morte, avvenuta il 4 marzo 1948.
Traduzioni da Carroll, scritti sui Tarahumara, disegni. Si tratta degli argomenti di tre contributi ospitati nel recentissimo numero di “Culture Teatrali” su Artaud, che ho già avuto occasione di menzionare. Vorrei toccarli brevemente, per poi aggiungere qualche considerazione su di un altro oggetto di studio che si sta affermando sempre più come cruciale per fare i conti con l’Artaud degli anni Quaranta, teatro compreso: alludo alle glossolalie, considerate all’interno di quello che ritengo sia il loro contesto più pertinente (non l’unico, ovviamente) anche da un punto di vista genetico, e cioè il lavoro “teatrale” dell’ultimo Artaud, riguardante la lettura della poesia come sua (ri)messa in vita.

6. Il sogno messicano
Partiamo dal viaggio in Messico e dagli scritti sui Tarahumara. Come ho già avuto modo di sostenere in altra sede,[45] nell’itinerario dal 1° al 2° Teatro della Crudeltà l’esperienza messicana presso gli indiani Tarahumara rappresenta una delle chiavi fondamentali, uno dei pochissimi fili che congiungono materialmente gli anni Trenta al decennio successivo e che, in qualche modo, non si spezzano del tutto neppure quando tutto il resto sembra spezzarsi irreparabilmente. Di più: il viaggio in Messico rappresenta, nella vita di Artaud, una cesura profonda, una svolta decisiva –nel bene e nel male, per quello che lì ad Artaud accadde e per quello che non gli accadde, per quello che “vide” e per quello che non riuscì a "vedere"– forse più profonde e decisive di altre svolte e di altre cesure giustamente segnalate dagli studiosi nella sua biografia: il fallimento come attore nel 1923-24, la “folgorazione” del teatro balinese nel 1931, l’insuccesso dei Cenci nel 1935, il già ricordato viaggio “mistico” in Irlanda nel 1937, il cosiddetto “ritorno a Parigi” nel maggio del 1946.
Non possiamo pensare di penetrare veramente in tutta l’opera successiva di Artaud, e quindi anche nella “rinascita” degli ultimi anni (in particolare, in quella straordinaria scena del rifacimento corporeo, ovvero della “curazione crudele”, che fu il 2° Teatro della Crudeltà), senza fare i conti sul serio con il viaggio in Messico e con la controversa esperienza presso gli indiani Tarahumara.
A parte il meritorio precedente di Carlo Pasi (ma anche quelli di Monique Borie, Marcello Gallucci e Elisabetta Brusa),[46] alcuni contributi recenti sembrano finalmente muoversi in questa direzione: mi riferisco, soprattutto, ai lavori di Florinda Cambria (di formazione non teatrologica ma filosofica), la quale tuttavia ancora evita un confronto approfondito con la stagione degli anni Quaranta,[47] e alla tesi di laurea di Luisa Ercolanelli sul viaggio messicano di Artaud come “viaggio teatrale”.[48]
In particolare, secondo quest’ultima, giovanissima studiosa, è nel soggiorno presso i Tarahumara, e più precisamente nell’impatto con la loro lingua, che andrebbe rintracciata una delle radici della ricerca glossolalica degli anni Quaranta; inoltre, a suo parere, l’intera esperienza della Sierra si presterebbe ad essere letta come una sorta di fatale “attraversamento dello specchio”: un andare al di là, un passare dall’altra parte delle cose, della realtà (e quindi, in primo luogo, del teatro, soltanto dopo il Messico, e forse in conseguenza del Messico, ripudiato definitivamente come rappresentazione e come spettacolo), che farebbe vivere ad Artaud una sorta di anticipazione psicofisica reale dell’ importante esperienza di traduttore dell’Alice carrolliana, con cui si confronterà a partire dall’estate del 1943. E (come suggerisce anche Camille Dumoulié)[49] nei riti del peyotl, tutti basati ossessivamente sulla disgiunzione/ricongiunzione dei due principi cosmogonici, il maschile e il femminile, e consistenti in gran parte in protocolli iniziatici di morte e rinascita, possiamo individuare una fonte preziosa per quelle pratiche di violenta destrutturazione/ricomposizione del corpo (in tal modo rigenerato miticamente come corpo “nuovo”, “glorioso”, “senz’organi”) che stanno alla base delle visioni del 2° Teatro della Crudeltà.
Senza dimenticare che, ovviamente, l’influenza è sempre in entrambi i sensi: senza alcun dubbio, la terribile esperienza degli internamenti, e in particolare quella degli oltre cinquanta elettroshock subiti a Rodez, servì ad Artaud per rivisitare, rileggere, rivivere l’iniziazione ai riti Tarahumara e, soprattutto, al fungo allucinogeno.
Quanto alle indagini della Ercolanelli, va aggiunto che esse hanno anche avviato un’importante operazione di riscontro fra tre elementi: i costumi e i riti Tarahumara nei testi disponibili all’epoca di Artaud, i costumi e i riti Tarahumara nel racconto di Artaud, i costumi e i riti Tarahumara oggi, nell'esperienza diretta della ricercatrice.[50] I primi risultati di questo triplice riscontro forniscono una conferma preziosa della sostanziale veridicità e, al solito, della incredibile precisione dei dettagli forniti da Artaud. E si tratta di dettagli che le sue probabili fonti scritte (da Basauri a Rouhier) non avrebbero potuto mettergli a disposizione e che quindi costituiscono una prova conclusiva (per quanto, ovviamente, è possibile essere conclusivi in casi del genere) del fatto che Artaud viaggiò veramente sulla Sierra.

7. “Alchimia salivare”
Il lavoro di Artaud su (e alla fine contro) Lewis Carroll copre complessivamente un arco di quasi quattro anni, dall’estate del ’43 (traduzione di Thema with variations, commissionatagli-impostagli dal dr. Ferdière, nel quadro dei suoi esperimenti di Art-thérapie) al marzo del ’47, quando esce sulla rivista “L’Arbalète”, con il nuovo titolo L’Arve et l’Aume, una versione di Humpty Dumpty, VI capitolo di Through the Looking-glass, profondamente diversa da quella a cui aveva lavorato anni prima a Rodez, e le cui intenzioni sono rese esplicite fin dal sottotitolo: “Impresa anti-grammaticale su Lewis Carroll e contro di lui”.[51] La pubblicazione, nel 1989, presso le edizioni L’Arbalète, di una nuova edizione de L’Arve et l’Aume (corredata dalla riproduzione anastatica delle bozze con le correzioni manoscritte di Artaud alla vecchia traduzione) ha permesso a tutti di rendersi conto delle dimensioni e del valore dell’”impresa” di Artaud, che quindi oltrepassa di gran lunga gli altri lavori di traduzione (da Poe, Southwell, Keats) intrapresi a Rodez, sempre su istigazione di Ferdière.
La scoperta dell’opera carrolliana, e delle sue invenzioni linguistiche, nell’estate del ’43 segna il ritorno di Artaud al lavoro letterario e scandisce – nei quattro anni successivi – i momenti fondamentali del suo ultimo, straordinario laboratorio creativo, all’insegna della reinvenzione corporea del linguaggio e della scrittura, con la “scrittura vocale”, “per analfabeti”, di cui le glossolalie costituiscono uno degli esiti più clamorosi.
Come ci mostra Lucia Amara nel suo recente, documentatissimo contributo (che fa giustizia, fra l’altro, di tante imprecisioni e di alcuni fraintendimenti accumulatisi su questa piccola ma significativa vicenda),[52] l’incontro-scontro fra Artaud e Carroll può essere diviso in tre momenti fondamentali: il primo, appena ricordato, della scoperta, con le traduzioni iniziali, in realtà già “adattamenti-variazioni”, come li chiama lui stesso; il secondo, della presa di distanze e del rigetto (ne sono un documento le violente lettere del settembre 1945 ad Henri Parisot, nelle quali egli muove due accuse pesantissime all’autore di Alice: in primo luogo, di essere “un profittatore che ha voluto pascersi intellettualmente, lui, già ben pasciuto di un pasto abbondante, pascersi del dolore altrui. […] un vile che non ha voluto patire la propria opera prima di scriverla e questo si vede”; inoltre, di essere un volgare scopiazzatore, giacchè "lo Jabberwocky è solo un plagio sdolcinato e senza accento di un’opera scritta da me e che hanno fatto scomparire”; cioè quel mitico libro perduto, dal titolo Letura d’Eprahi etc., che Artaud diceva di aver scritto nel ’34);[53] il terzo, della riappropriazione-reinvenzione, testimoniato appunto dalla versione del ’47 e dalla lettera all’editore Marc Barbezat (del 23 marzo di quell’anno) in cui si dice che essa “[gli] appartiene in proprio e non è affatto la versione francese di un testo inglese”.[54]
Ma ciò che più conta è che questo incontro-scontro con Carroll “sobillatore del linguaggio” (quale appare ai suoi occhi, secondo Lucia Amara) risulta interamente improntato all’oralità e alla corporeità, preludio ed esempio della estrema ricerca espressiva di Artaud all’insegna, come ho appena ricordato, del rifacimento del corpo e della rigenerazione fisica della lingua e della scrittura.[55] A questo proposito, non va trascurata la circostanza che, per Artaud, il primo Carroll, quello della poesia Thema with variations, è sonoro: infatti, egli ascolta la traduzione letterale e la lettura che glie ne fa a voce alta l’abbé Julien, il cappellano di Rodez. E’ da questa versione orale che Artaud (il quale conosceva male l’inglese) parte per il suo adattamento-variazione. Si legga, a conferma, quanto egli scrive in Variations à propos d’un thème, nel preambolo in prosa che precede la traduzione della poesia di Carroll:
C’è in questa poesia un aspetto che determina gli stati per cui passa la parola-materia prima di fiorire nel pensiero, e le operazioni di alchimia per così dire salivare che ogni poeta nel fondo della sua gola fa subire alla parola, musica, frase, variazione del tempo interno, prima di rigurgitarle in materia per il lettore.[56]
Se questa rappresenta, per così dire, la riflessione critica iniziale di Artaud sull’autore inglese, l’ultima è contenuta nella già citata lettera a Barbezat del marzo ’47. Qui, dopo una prima, anacronistica rivendicazione della primogenitura (“ho avuto la sensazione […] che quella poesia [la poesia di Carroll sui pesci, inclusa in Humpty Dumpty] sono io ad averla pensata e scritta in altri secoli”), cui seguirà quella riportata in precedenza, Artaud insiste sull’originalità e sull’autonomia della propria ricerca:
I miei quaderni scritti a Rodez durante tre anni di internamento, e mostrati a tutti, scritti in un’ignoranza completa di Lewis Carroll che non avevo mai letto, sono pieni di esclamazioni, d’interiezioni, d’abbai, di grida, sull’antinomia fra vivere e essere.[57]
In questa specie di excusatio non petita c’è – a mio parere - l’ammissione candida, quasi disarmante, dell’importanza che il corpo a corpo con Carroll e i suoi portemanteau-words ha avuto per la ricerca artaudiana di una “scrittura vocale”, per l’invenzione di quelle “xilofonie verbali” di cui le glossolalie costituiscono l’esempio più vistoso. Del resto, non è probabilmente un caso che il primo riferimento esplicito alle glossolalie sia contenuto proprio in una delle lettere a Parisot del settembre ’45, con le quali – lo abbiamo visto - si scaglia violentemente contro Carroll accusandolo di plagio; come non è un caso se il leitmotiv artistico e teatrale degli ultimi anni, quello del “vivere” la poesia, viene esplicitato in un’altra lettera a Parisot, di poco successiva a quelle contro Carroll. Ne riparleremo più avanti.
Ma ora occupiamoci dei disegni.

8. “Anatomie in azione”
La straordinaria opera grafica di Artaud è una delle zone del suo lavoro più citate che realmente conosciute o seriamente studiate. Dopo i fondamentali contributi critici e documentari di Paule Thévenin e Jacques Derrida,[58] sono stati tutto sommato pochi gli interventi approfonditi sulla molteplicità di questioni che, come al solito, anche i disegni sollevano.[59]
Dal ‘39 – lo confessa lui stesso - Artaud non scrisse più senza disegnare. E’ chiaro, quindi, che il lavoro grafico degli ultimi dieci anni di vita va considerato in maniera molto diversa rispetto a quanto egli aveva fatto in precedenza (già dal 1918 comincia a disegnare, durante uno dei ricorrenti ricoveri in clinica, e più o meno negli stessi anni inizia a scrivere di pittura). Fin dai primi anni di internamento (1937-‘39), il disegno diventa uno degli strumenti essenziali della sua ricerca e della sua attività di autodifesa e di ricostruzione, in un legame con la scrittura che verrà facendosi sempre più stretto e nel quadro delle attività del 2° Teatro della Crudeltà, con al centro la “curazione crudele” e il “rifacimento corporeo”.[60]
Come ricorda Caterina Pecchioli nel suo recentissimo contributo, si possono distinguere quattro fasi nella produzione grafica di Artaud: tre più o meno successive e una continuativa.[61] La prima fase (1937-1944) è quella caratterizzata dalla produzione di Sorts e Gris-gris, lettere sortilegio, provviste per il loro autore di poteri magici, benefici o malefici a seconda dei casi, e che egli comincia a inviare dall’Irlanda. La seconda fase va, all’incirca, dal gennaio ’45 al maggio ’46 (epoca in cui Artaud – lo sappiamo - lascia Rodez) ed è quella dei Grandi Disegni o Disegni Scritti, nei quali – come dice anche la loro denominazione d’autore - si realizza quell’intreccio a più livelli di parola e immagine, segno linguistico e segno grafico, a cui ho appena fatto allusione. La terza fase, che va dal maggio ’46 fino alla morte, nel marzo del ’48, è caratterizzata dalla prevalente produzione di Ritratti e Autoritratti. C’è poi un quarto tipo di produzione, che scorre parallelo alle tre fasi, fra ’45 e 48, ed è quello contenuto nei cahiers, dove Artaud attua una vera e propria fusione e una totale intercambiabilità fra scrittura e disegno.
Soffermandoci sui Grandi Disegni forse possiamo capire meglio la funzione che questa straordinaria impresa grafico-scritturale assolve per Artaud, in quegli anni. E tanto per cominciare va ricordato che, in essi, è riscontrabile una duplice presenza della parola: nel foglio, sotto forma di frasi o singoli termini, e fuori dal foglio, sotto forma di commento al disegno.[62] Del resto, è lo stesso Artaud ad aver parlato chiaramente, e a più riprese, in proposito e quindi è a lui che dobbiamo rifarci, almeno in prima battuta.
Quanto alla funzione delle parole nei Grandi Disegni, egli la definisce con forza fin dal loro primo annuncio, in una lettera a Paulhan del 10 gennaio ’45, che ho già avuto modo di citare in precedenza:
Mi sono messo a fare dei grandi disegni a colori. […] Sono dei disegni scritti, con delle frasi che si inseriscono nelle forme allo scopo di farle precipitare. Credo di essere arrivato anche in questo a qualcosa di speciale come nei miei libri o a teatro.[63]
E un anno dopo (in una lettera a Ferdière), egli chiarisce la genesi orale-corporea di queste frasi esplicative, che in realtà costituiscono delle “sonorità verbali”:
le frasi che ho annotato sul disegno che le ho dato le ho cercate sillaba per sillaba ad alta voce lavorando, per vedere se le sonorità verbali capaci di aiutare la comprensione di chi guardasse il disegno erano state trovate.[64]
Ma che cosa sono, in realtà, i suoi disegni, come bisogna considerarli, come guardarli?
I miei disegni non sono dei disegni ma dei documenti [c. m.], bisogna guardarli e comprendere quello che c’è dentro.[65]
Questo disegno [non meglio identificabile] come tutti i miei disegni non è quello di un uomo che non sa disegnare, ma quello di un uomo che ha abbandonato il principio del disegno e vuole disegnare alla sua età, la mia, come se non avesse imparato niente per via di principio, legge o arte, ma unicamente per esperienza di lavoro.[66]
Il genio di un disegno non sta nella sua arte, ma nell’azione delle forze che hanno presieduto al calcolo delle forme e dei segni che le linee disegnate abbandonano, formano, svuotano, fanno rimpiangere.[67]
In ogni caso, sta nel rapporto fra il disegno, anzi il disegnare, come atto, lavoro, e il rifacimento corporeo, che Artaud persegue a tutti i livelli in quegli anni, il senso più profondo di questa impresa grafico-scritturale (“Questo disegno è dunque la ricerca di un corpo”).[68] In proposito, il testo 50 disegni per assassinare la magia (scritto nel gennaio ’48, su richiesta dell’amico gallerista Pierre Loeb, per presentare una scelta di disegni dei cahiers) si spiega in maniera inequivocabile:
[Questi disegni] […] sono puramente/ e semplicemente la/ riproduzione sulla/ carta/ d’un gesto/ magico/ che ho esercitato/ nello spazio vero/ con il soffio dei miei/ polmoni e le mie/ mani,/ con la testa/ e i miei 2 piedi/ col mio tronco e le mie/arterie ecc.[69]
Del tutto evidente risulta qui il rapporto osmotico, il va e vieni ininterrotto che Artaud instaura fra il lavoro grafico (disegno e scrittura) e il lavoro su di sé, cioè il lavoro fisico e vocale che in quegli anni era venuto sviluppando come “metodo rivisitato e corretto dell’atletismo affettivo” e che costituisce la base del 2° Teatro della Crudeltà.
Grazie allo studio della Pecchioli possiamo addentrarci nell’analisi di un esempio concreto di queste “anatomie in azione” che sono, per lui, i suoi disegni.[70] Si tratta del Disegno Scritto Couti l’anatomie (di datazione incerta, fra ’45 e ’46, e spesso citato dall’autore con altri titoli: La recherche de l’anatomie; Le coccyx; L’anatomie).
Afferma Artaud nel Commento: “Questo disegno rappresenta lo sforzo che tento in questo momento per rifare corpo con l’osso delle musiche dell’anima”.[71] Ma in realtà, con questo disegno, e con gli altri, in generale con il disegnare (come del resto con lo scrivere e il leggere ad alta voce), Artaud cerca di fare molto di più: in questa vera e propria “drammaturgia in atto”,[72] lo sforzo “per rifare corpo” non è solo rappresentato ma anche attuato, appunto, con i mezzi e i supporti specifici del lavoro grafico e con l’aiuto della parola, nella fattispecie di formule glossolaliche, che giocano su etimi greci, a partire dal termine couti, “scatola”, una parola che ritorna sovente nei cahiers associata al corpo.[73] Appropriatamente la Pecchioli parla, a proposito di queste glossolalie, di “formula magica da enunciare perché il processo di ricostruzione abbia luogo” e nota come molte di esse ricorrano quasi identiche sia nel disegno che nella parte finale del commento.[74]
Ulteriore elemento di interesse nell’analisi della giovane studiosa è l’aver messo in luce come in questo disegno, al pari che in altri, il processo di ricostruzione corporea si svolga interamente all’insegna del rovesciamento, attuato contemporaneamente nel suono (la glossolalia couti d’arbac che diventa arbac cata), nel significato delle parole (che alludono, fra l’altro, a un albero della vita rovesciato: arbac cata, ma anche a un corpo a rovescio, ridotto alle ossa-segno, come suo elemento primo-minimo: les os sema) e nel soggetto del disegno, che mostra in effetti un corpo-osso capovolto, il nucleo generativo da cui partire per ricostruire, alla rovescia, la vera struttura anatomica dell’uomo. Scrive la Pecchioli (riferendosi alla celebre immagine della “danza alla rovescia” che chiude Per farla finita col giudizio di dio):
Come in una danza alla rovescia, il disegno offre l’immagine fisica di un corpo rovesciato, capace di sfidare le leggi dello spazio sul foglio, che non poggia i piedi in basso ma sceglie di ribaltarsi.[75]

9. “Vivere” la poesia
Per lungo tempo – e lo si è già ricordato - l’Artaud degli anni Quaranta con la sua anomala, straordinaria produzione, è stato guardato con sospetto; e anche quando veniva dichiarata ammirazione nei suoi confronti sembrava che non si potesse ugualmente fare a meno di evocare lo spettro della follia. Il ricorso alla schizofrenia nell’analisi del linguaggio delle sue ultime opere, e in particolare dei cahiers, è stato ininterrotto e ancora oggi non si può certo dire che sia cessato: conosciamo tutti i contributi ormai classici, e di grandissimo spessore in ogni caso, di Gilles Deleuze; ma ancora qualche anno fa Julia Kristeva è tornata a collocare l’opera di Artaud “tra psicosi e rivolta”.[76]
D’altra parte, è comprensibile che nella produzione artaudiana degli anni Quaranta, tutta all’insegna del superamento dei limiti, le glossolalie abbiano attirato più ancora del resto una lettura in chiave patologica come sintomo psichiatrico, e più specificamente schizofrenico.[77]
Tuttavia, da più parti si stanno intensificando le indicazioni per sottrarre la ricerca glossolalica di Artaud a letture unilaterali (che sia quella psicopatologica, appena ricordata, o quella, opposta, in chiave di mero sperimentalismo linguistico, sulla scia dei tentativi delle avanguardie storiche, secondo la linea, per intenderci, Carroll-Joyce-dadaismo-cubofuturismo etc.), per indagarla invece nel contesto complessivo del suo ultimo, grandioso laboratorio creativo, quello – già ripetutamente richiamato nella presente Postilla - del 2° Teatro della Crudeltà, con al centro la reinvenzione corporea del linguaggio.
Muovendosi - come il resto dell’ultima produzione letteraria di Artaud, ma con ancora maggiore radicalità - fra scrittura e oralità, visione e ascolto, xilofonia e xilofenia, le glossolalie rappresentano un momento e un aspetto importante dell’estrema ricerca “teatrale” di Artaud; quella attestata dalla Séance del 13 gennaio ’47 al Théâtre du Vieux-Colombier, dalle letture pubbliche alla Galérie Pierre e, soprattutto, dall’opus conclusivo, la trasmissione radiofonica Pour en finir avec le jugement de dieu.[78]
Denomino “teatrale” questa ricerca perché essa ebbe lo scopo, fra l’altro (forse, soprattutto), di affinare specifiche tecniche d’attore per riuscire a “vivere” la poesia (come si dice nella lettera a Parisot del 6 ottobre ’45 che cito più avanti), cioè a (ri)darle vita nel leggerla, fonetizzandola-cantandola.
E’ una ricerca che parte da lontano, si può dire quasi dagli inizi, a riprova dello strettissimo legame che è stato sempre sentito fra poesia e teatro [79] da un Artaud alla perenne ricerca di una parola efficace, in grado di recuperare – al di là del significato e della psicologia - l’originario potere di incantazione, legato alla sua matericità vocalico-sonora.
I saggi de Il Teatro e il suo doppio sono pieni di osservazioni e indicazioni inequivocabili al riguardo, a partire dalla celebre immagine della “poésie dans l’espace”, proposta ne La messa in scena e la metafisica, del 1931, dove si dice inoltre:
Fare la metafisica del linguaggio articolato significa indurlo ad esprimere ciò che di solito non esprime; significa servirsene in modo nuovo, eccezionale e inusitato, significa restituirgli le sue possibilità di scuotimento fisico, significa frazionarlo e distribuirlo attivamente nello spazio, significa prendere le intonazioni in modo assolutamente concreto restituendo loro il potere originario di sconvolgere e di manifestare effettivamente qualcosa, significa ribellarsi al linguaggio e alle fonti bassamente utilitarie, alimentari si potrebbe dire, alle sue origini di bestia braccata, significa infine considerare il linguaggio sotto forma di Incantazione.[80]
Questa linea di ricerca trova la sua prima fissazione operativa nel Il Teatro della Crudeltà. Primo manifesto, dell’ottobre 1932:
Abbandonando l’utilizzazione occidentale della parola, [“questo linguaggio oggettivo e concreto”] trasforma le singole parole in sortilegi. Alza la voce. Ne utilizza le vibrazioni e le qualità. Fa martellare violentemente i ritmi. Macera i suoni. Mira a esaltare, intorpidire, sedurre, fermare la sensibilità. […] Non si tratta di sopprimere la parola articolata ma di dare alle parole all’incirca l’importanza che hanno nei sogni.[81]
E il Secondo manifesto ribadisce:
Ma le parole, oltre che nel senso logico, saranno usate anche in un senso ammaliante, veramente magico –non soltanto, cioè, per il significato, ma anche per la forma e le loro emanazioni sensibili.[82]
Subito prima del viaggio in Messico (durante il quale potrà fare esperienza del salmodiare incantatorio degli stregoni Tarahumara), ne Un atletismo affettivo Artaud vagheggia del “geroglifico di un soffio”, col quale “ritrovare un’idea di teatro sacro”, e chiude rimproverando agli attori occidentali odierni l’incapacità di gridare:
Non c’è più nessuno che sia capace di gridare, in Europa, e specialmente gli attori in transe non sanno più emettere il proprio grido. Non sanno più fare altro che parlare, in teatro, hanno dimenticato di avere un corpo.[83]
Dopo il black-out della “follia”, quando torna alla vita, al lavoro e al teatro, Artaud riparte da qui, nella sua ricerca di un linguaggio al di là del linguaggio, di una scrittura oltre la scrittura.
Non a caso, i primi tentativi di elaborazione glossolalica, cioè di quelli che chiamerà “saggi di linguaggio”, “sillabe inventate” etc., emergono già nella primavera del ‘43,[84] subito dopo il trasferimento a Rodez, in una con il ritorno alla scrittura, la scoperta di Carroll, il riaffiorare dell’esperienza presso i Tarahumara, la riscoperta de Il Teatro e il suo doppio e naturalmente, last but not least, l’intensificarsi del lavoro su di sé come versione riveduta e corretta dell’ “atletismo affettivo” degli anni Trenta.
Gli esperimenti glossolalici stanno – giova ripeterlo - dentro la formidabile impresa di una radicale rigenerazione fisica del linguaggio che Artaud porta avanti in quegli anni, prima a Rodez e poi a Ivry, nella direzione di una ricerca estrema sull’espressività totale, pre- e post-verbale, della parola.
Da questo sforzo la lingua sembra uscire come disintegrata e purificata, ricondotta ai suoi elementi primari: la materia sonora, il respiro, il grido, il ritmo, l’onomatopea e, appunto, le glossolalie; queste ultime –avverte Artaud- non possono essere lette “che scandit[e], su un ritmo che il lettore deve trovare per capire e pensare”;[85] e devono essere pronunciate a voce alta, anzi altissima: urlate, insomma.[86]
E’ la “scrittura vocale”, o “senza lettere”, che nasce dall’oralità e all’oralità è destinata elettivamente a tornare, nella dettatura e nella lettura. Anzi, è solo nel proferimento a voce alta che essa (ri)vive. Dopo aver presentato, per la prima volta, in maniera esplicita una sequenza glossolalica come “saggio di linguaggio”, nella lettera a Parisot appena citata Artaud aggiunge, con fare apparentemente misterioso:
scritto qui [questo “saggio di linguaggio”] non dice niente ed è solo cenere; perché scritto possa vivere occorre un altro elemento che si trova in quel libro che è andato perduto [allusione al già ricordato libro mitico Letura d’eprahi etc., a cui viene attribuita l’invenzione del suo linguaggio glossolalico].[87]
Pochi giorni dopo, in un’altra lettera a Parisot, egli spiega, appunto, che per lui le poesie non si tratta di scriverle o declamarle ma di viverle: “Se sono poeta o attore non lo sono per scrivere o declamare poesie, ma per viverle”.[88]
Ecco, dunque, cosa intende dire Artaud: per vivere la poesia bisogna far ricorso a “un altro elemento”, o meglio, a un elemento altro rispetto alla forma scritta e ai significati che essa fissa (e raggela o pietrifica). E questo elemento altro è rappresentato, per lui, dalla lettura come sonorizzazione-fonetizzazione, ovvero come gesto vocale.[89]
Questo lavoro sulla lettura intesa come sonorizzazione/fonetizzazione della parola, ovvero come gesto vocale, recupera e porta fino in fondo le suggestioni degli anni Trenta sulle intonazioni, le vibrazioni, l’uso magico e incantatorio della parola, il grido. Alla base –non lo si dimentichi- c’è il quotidiano training del souffle, il suo nuovo atletismo affettivo, fatto di chantonnements, reniflements, tournoiements.[90]
Agli occhi di Artaud, si trattava soprattutto di cominciare a mettere in pratica, a realizzare veramente, quanto nel Teatro e il suo doppio si era limitato a enunciare e a teorizzare. Insomma, ma la cosa vale per tutte le altre svolte negli anni Quaranta (scrittura, disegno etc.), con questa ricerca sulla lettura, come (ri)messa in vita della poesia, siamo di fronte a un lavoro con obiettivi fondamentalmente extra-artistici, cioè finalizzato primariamente al ricostruirsi, al tornare a vivere, ovvero al “nascere veramente” (come egli dice per Colette Thomas, la più cara e la più sfortunata dei suoi ultimi “allievi”)[91] e tuttavia capace di produrre delle straordinarie “ricadute” espressive.
L’ultima metamorfosi dell’homme-théâtre è quella del sapiente maestro di lettura, che cerca di passare ai giovani adepti (oltre a Colette Thomas, Marthe Robert, Jacques Prevel e la stessa Thévenin) i segreti della sua inconfondibile maniera di vivere le poesie.
In proposito disponiamo della illuminante testimonianza di Paule Thévenin, riportata estesamente nel presente volume.[92] Fra i tanti indizi preziosi da lei forniti, qui mi limito a sottolineare quello riguardante l’uso delle glossolalie come esercizio d’attore; circostanza che trova varie conferme, anche da parte dello stesso Artaud.[93]
Altre informazioni essenziali, concordanti con quelle fornite dalla Thévenin, circa il lavoro estenuante che secondo Artaud era necessario per arrivare a leggere efficacemente una poesia, e dunque a viverla, le fornisce la tormentata collaborazione con la giovane attrice Colette Thomas fra ’46 e ’47. Grazie a un impegno di questo tipo, nel corso della Séance del 7 giugno ’46 al Théâtre Sarah Bernhardt in onore dello stesso Artaud, Colette aveva conseguito un risultato notevolissimo, leggendo “in una maniera straordinaria” (secondo il critico di “Combat”, che era presente in sala) un breve testo di Artaud (Car les enfants de la mise en scène principe), che poi sarebbe diventato una delle Frammentazioni di Succubi e supplizi.[94]
Della dura meticolosità del lavoro di prove, che i due svolsero insieme nelle settimane precedenti, è rimasta traccia nella loro corrispondenza.[95] Ciò rende pienamente plausibile l’ipotesi di Franco Ruffini che esso consistesse nell’arrivare
a mettere la vita – il soffio - non in ogni parola del testo pronunciato, ma in ogni sillaba e lettera e, al fondo, in ogni impulso di suono articolato prima dell’articolazione.[96]
Del resto, è lo stesso Artaud a parlare, pochi mesi dopo,
di molteplici modi di scandire un testo non solamente frase per frase o parola per parola, ma sillaba per sillaba e lettera per lettera.[97]
Forse è proprio di questo lavoro che Colette Thomas si ricorderà, più di quarant’anni dopo, durante l’incontro con il regista cinematografico Gérard Mordillat, parlando, in maniera apparentemente insensata, “[del] numero di lettere nelle parole, [del] numero di parole nelle frasi”.[98]
L’anno dopo, luglio ’47, Colette riappare (insieme a Roger Blin e a Marthe Robert) nelle due sessioni di letture che Artaud orchestra alla Galerie Pierre in occasione di una sua esposizione di disegni.[99] Nella prima, del 4 luglio, complessivamente deludente, la prova di Colette fu addirittura fallimentare (Prevel la definisce “insieme patetic[a] ed estremamente penos[a]”); nella seconda, del 20 luglio, risultò invece nuovamente “straordinaria”; secondo le parole dello stesso Artaud, “come uno spirito pronto a materializzarsi”.[100] Artaud, da vero regista inflessibile, l’aveva rimproverata fra una sessione e l’altra, attribuendo il cattivo esito della prima al fatto che non avessero provato.[101]
Come ha scritto Carlo Pasi, le letture alla Galerie Pierre costituiscono il preludio al lavoro per lo straordinario opus finale: Pour en finir avec le jugement de dieu.
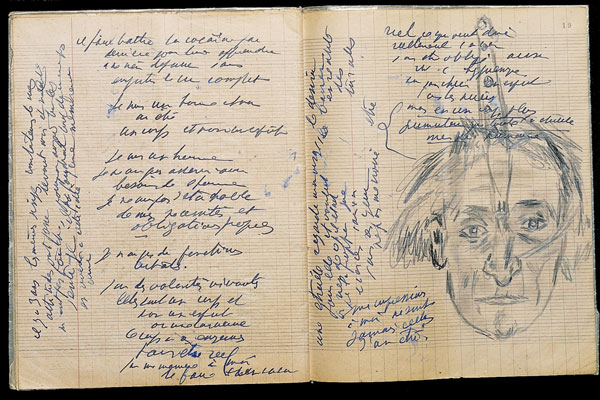
Paule Thévenin, nella sua testimonianza circa l’apprendistato sulla lettura fatto con Artaud, parla di canto, di melodia. Molti ascoltatori hanno avuto la stessa impressione di fronte alla registrazione di Pour en finir avec le jugement de dieu: e cioè che si tratti di canto, che qui – come ebbe a scrivere Julia Kristeva - “ciò che interessa ad Artaud sia di cantare”.[102]
Pour en finir… non è soltanto l’ultimo lavoro di Artaud ma è anche un’opera capitale, una summa, pur nelle ridotte dimensioni. Consapevole che, messa in onda, essa avrebbe raggiunto un pubblico ben più vasto delle platee teatrali, Artaud cercò di condensarvi i risultati delle intensissime ricerche degli ultimi anni intorno alla rigenerazione corporea della parola e del linguaggio, in un’osmosi strettissima, e a più livelli, fra oralità e scrittura, fra rumore, voce, parola e suono.
Dopo il semi-infortunio del tête à tête al Vieux Colombier, dopo i risultati decisamente migliori delle letture alla Galerie Pierre, egli si sentiva finalmente in grado di conseguire in pieno un obiettivo che fino ad allora aveva mancato o raggiunto solo parzialmente.
E’ molto interessante, scorrendo il dossier di Pour en finir…,[103] scoprire che Artaud, il quale per settimane aveva scritto e scritto testi, more solito, da un certo momento comincia a capire come, in un’opera radiofonica quale lui la sta concependo, le parole in sé non siano la cosa più importante (e infatti proporrà due tagli riguardanti i suoi due interventi, in apertura e in chiusura, oltre a lasciar cadere la lunga poesia Le Théâtre de la Cruauté, di cui una scaletta del novembre del ‘47 ancora inserisce il finale), come gli effetti che si prefigge di ottenere siano invece legati, fondamentalmente, alle sonorizzazioni e alle xilofonie, da un lato, e al montaggio super-accurato, dall’altro.
Ecco perché Pour en finir…, inteso in quanto “emissione”,[104] si presenta come una vera e propria partitura stratificata, dove tutto è sapientemente calcolato: dall’equilibrio tra le due voci femminili (Maria Casarès e Paule Thévenin) e le due voci maschili (Roger Blin e lui stesso)[105] al modo in cui si alternano o sovrappongono segmenti appartenenti ai quattro principali strati sonori dell’opera: testi detti, sonorizzazioni vocali (xilofonie verbali) e corporee: grida, rumori, battiti, xilofonie strumentali (prodotte da xilofono, tamburo, timpani e gong), glossolalie. Si veda, al riguardo, la scaletta del montaggio in dieci sequenze inserita da Artaud in una lettera a Fernand Pouey del 16 gennaio ’48.[106]
Alla fine – insiste Artaud - tutto sarebbe dipeso dal montaggio e, naturalmente, dalla messa in onda, visto che ogni dettaglio era stato calcolato in funzione sua.
In quella che viene di solito citata come la sua “ultima lettera sul teatro”, scritta solo nove giorni prima della morte, la fortissima delusione per l’ennesimo échec (la mancata messa in onda, a causa del divieto sopraggiunto all’ultimo momento da parte del direttore della Radiodiffusione francese) e i dubbi affioranti nei confronti della “macchina” e della sua inevitabile “interposizione tecnica”, lo spingono a rilanciare con disperato entusiasmo il proprio progetto teatrale, che ora chiama “teatro di sangue”, ennesimo e ultimo nome del 2° Teatro della Crudeltà:
Per questa ragione non mi occuperò mai più di Radio,/ e mi consacrerò ormai/ esclusivamente/ al teatro/ così come lo concepisco,/ un teatro di sangue,/ un teatro che a ogni rappresentazione avrà fatto guadagnare/ corporalmente/ qualcosa/ sia a che recita [joue] sia a chi viene a veder recitare,/ del resto non si recita,/ si agisce./ Il teatro è in realtà la genesi della creazione./ Questo si farà.[107]
Questo progetto ancora ci riguarda e ci sfida. E’ una delle eredità impossibili del Novecento teatrale.
11. Nota bibliografica
Indico qui le principali pubblicazioni in italiano di e su Artaud uscite nell’ultimo decennio, 1995-2005.
I. Principali traduzioni italiane di scritti di Artaud:
- Storia vissuta di Artaud-Mômo, a cura di Giorgia Bongiorno, Brescia, L’Obliquo, 1995.
- Il Pomerio, supplemento a “In forma di parole”, dicembre 1996, a cura di Carlo Pasi (contiene: Alienare l’attore; Il teatro e la scienza; Il rituale è quando l’uomo ha già trovato e fissato; Viviamo in un mondo malsano da cui; il mondo degli spiriti è quel mondo che ha).
- Per farla finita con il giudizio di dio, Viterbo, Stampa Alternativa, 2000.
- Vivere è superare se stessi. Lettere a Jean-Louis Barrault 1935-1945 style='font-style:normal'>, a style='font-style: normal'> cura di Enrico Badellino, Milano, Archinto, 2000.
- Del meraviglioso. Scritti di cinema e sul cinema, a cura di Goffredo Fofi, Roma, Minimum Fax, 2001.
- Cinquanta disegni per assassinare la magia, a cura di Carlo Pasi, Brescia, L’Obliquo, 2002.
- Poesie della crudeltà, a cura di Pasquale Di Palmo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2002.
- Artaud le Mômo, Ci-Gît e altre poesie, a cura di Giorgia Bongiorno, Torino, Einaudi, 2003.
- CsO: il corpo senz’organi, a cura di Marco Dotti, Milano, Mimesis, 2003 (con ampia bibliografia).
- Succubi e supplizi, a cura di Jean-Paul Manganaro e Renata Molinari, Milano, Adelphi, 2004.
II. Principali contributi critici:
- Franco Ruffini, I teatri di Artaud: Crudeltà, corpo-mente, Bologna, Il Mulino, 1996.
- Gianni Poli, Antonin Artaud. La poesia in scena, Genova, Erga Edizioni, 1997.
- Nicola Savarese, Paris/Artaud/Bali. Antonin Artaud vede il teatro balinese all’Esposizione Coloniale di Parigi del 1931, L’Aquila, Textus, 1997.
- Camille Dumoulié, Antonin Artaud, Genova, Costa & Nolan, 1998 (ed. orig. 1996).
- Carlo Pasi, La comunicazione crudele. Da Baudelaire a Beckett, Torino, Bollati Boringhieri, 1998 (in particolare, il capitolo Lo specchio della crudeltà: Antonin Artaud).
- Ida Savarino, Antonin Artaud nel vortice dell’elettrochoc, Tivoli, Sensibili alle Foglie, 1998.
- Carlo Pasi, Artaud attore, Torino, Bollati Boringhieri, 2000 (edizione aggiornata della precedente del 1989).
- Florinda Cambria, Corpi all’opera. Teatro e scrittura in Antonin Artaud, Milano, Jaca Book, 2001.
- Alessandro Cappabianca, Artaud, Palermo, L’Epos, 2001.
- Lorenzo Chiesa, Antonin Artaud. Verso un corpo senz’organi, Verona, Ombre Corte, 2001.
- Franco Ruffini, Alessandro Berdini (a cura di), Antonin Artaud. Teatro, libri e oltre, Roma, Bulzoni, 2001.
- Franco Ruffini, Per piacere. Itinerari intorno al valore del teatro, Roma, Bulzoni, 2001 (in particolare, I libri di Stanislavskij e di Artaud; I “Sei personaggi” di Antonin Artaud; Artaud alla lettera).
- Antonio Attisani, Théâtre le lieu où l’on s’en donne à coeur joie, in AA.VV., Frammenti di un discorso sullo spettacolo. Per Roberto Tessari, Torino, Edizioni del DAMS di Torino, 2003.
- Luca Berta, Derrida e Artaud. Decostruzione e teatro della crudeltà, Roma, Bulzoni, 2003.
- Giorgia Bongiorno, Introduzione a A. A., Artaud le Mômo, Ci-Gît e altre poesie, Torino, Einaudi, 2003.
- Marco Dotti, Il corpo e il suo doppio, in A. A., CsO: il corpo senz’organi, Milano, Mimesis, 2003.
- Umberto Artioli, Antonin Artaud e il teatro della crudeltà, in AA. VV., Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione (1870-1950), a cura di U. A., Roma, Carocci, 2004.
- Francesco Cappa, La materia invisibile. Corpo e carne in Antonin Artaud, Milano, Ghibli, 2004.
- Marco De Marinis, Visioni della scena. Teatro e scrittura, Roma-Bari, Laterza, 2004 (in particolare, Artaud fra Seneca ed Eliogabalo: riscrittura tragica e romanzo teatrale).
- Fabio Acca, La fortuna di Artaud in Italia 1935-1970, tesi di dottorato, Università di Bologna, Studi Teatrali e Cinematografici, a.a. 2004-1005 (con vasta bibliografia).
- Jacques Derrida, A. Artaud. Forsennare il soggettile, Milano, Abscondita, 2005.
- Marco De Marinis, A Est di Bali: Artaud, i Tarahumara e il vero Oriente, in L’Oriente. Storia di una figura nelle arti occidentali (1700-2000), a cura di Paolo Amalfitano, Silvia Carandini e Loretta Innocenti, Roma, Bulzoni, 2006, vol. II: Il Novecento.
- Artaud/microstorie, a cura di Marco De Marinis, numero monografico di “Culture Teatrali”, 11, autunno 2004 (in realtà, 2006), con contributi di: Fabio Acca, Lucia Amara, Marco De Marinis, Alfredo De Paz, Luisa Ercolanelli, Evelyne Grossman, Caterina Pecchioli.
[1] Per comodità del lettore in questa Postilla, che funge fra l’altro da nota bibliografica riepilogativa e integrativa, si riporteranno in forma completa anche i riferimenti riguardanti testi e studi già citati nelle tre parti del volume.
[2] Fabrizio Cruciani, Copeau, o la tradizione della nascita, “Teatro Festival”, 5, 1986, pp. 19-20. Si vedano le analoghe considerazioni svolte da chi scrive nell’Introduzione alla sezione monografica del numero 9 (autunno 2003) di “Culture Teatrali”, dedicata a Grotowski.
[3] Marcelin Pleynet, Antonin Artaud, le suicidé de la société, in Les Théâtres de la Cruauté. Hommage à Antonin Artaud, a cura di Camille Dumoulié, Paris, Desjonquères, 2000, p. 23.
[4] Camille Dumoulié, Artaud, la vie, Paris, Desjonquères, 2003, p. 7.
[5] Ferdinando Taviani, Ciarla a voce sommessa, in Antonin Artaud. Teatro, libri e oltre, a cura di Franco Ruffini e Alessandro Berdini, Roma, Bulzoni, 2001, p. 90.
[6] Citando un po’ alla rinfusa, ricorderei: Marco Dotti, Florinda Cambria, Giorgia Bongiorno, Luca Berta, Francesco Cappa, Pasquale di Palmo e Fabio Acca. A quest’ultimo, in particolare, dobbiamo una recente ricerca su La fortuna di Artaud in Italia. 1935-1970, tesi di dottorato, Università di Bologna, Studi Teatrali e Cinematografici, a.a. 2004-5, un estratto della quale è ora pubblicato nel n. 11 di “Culture Teatrali” (autunno 2004, ma in realtà 2006), dedicato a Artaud/microstorie.
[7] A. Artaud, Succubi e supplizi, edizione italiana a cura di Jean-Paul Manganaro e Renata Molinari, cura redazionale di Paola Cigala Fulgosi, Milano, Adelphi, 2004.
[8] D’ora in poi: O.C.+numero del volume+(se necessario) numero delle pagine. Per inciso, ritengo che sarebbe stato giusto apporre il nome della Thévenin sul frontespizio del volume in questione, come venne fatto per Van Gogh il suicidato della società, apparso sempre da Adelphi, e sempre nella traduzione di Jean-Paul Manganaro, nel 1988.
[9] La prima delle tre parti di cui si compone l’opera (Frammentazioni, Lettere, Interiezioni) era già stata proposta in un’altra traduzione (a cura di H. J. Maxwell e Claudio Rugafiori) dallo stesso editore nel volume Al paese dei Tarahumara e altri scritti, nel 1966. Più di recente, Giorgia Bongiorno ha pubblicato, nella traduzione di Emilio e Antonia Tadini, i primi due testi di Interiezioni (cfr. A. Artaud, Artaud le Mômo, Ci-Gît e altre poesie, Torino, Einaudi, 2003).
[10] A. Artaud, Succubi e supplizi, cit., p. 14. Ma, in proposito, si legga soprattutto la lunga nota di Paule Thévenin: ivi, pp. 467-474.
[11] A. Artaud, Oeuvres, a cura di Evelyne Grossman, Paris, Gallimard, “Quarto”, 2004 (d’ora in poi citerò questo volume così: Grossman 2004). Fra i molti contributi artaudiani della Grossman, si vedano almeno (oltre a Artaud/Joyce. Le corps et le texte, Paris, Nathan, 1996, ripetutamente citato nel corso del presente volume): Artaud, “l’aliéné authentique”, Tours, Ed. Farrago-Léo Scheer, 2003; La Défiguration. Artaud-Beckett-Michaux, Paris, Minuit, 2004.
[12] Cfr. anche Grossman 2004, p. 12. Nel 2006 la Grossman ha pubblicato una nuova edizione, in volume separato, di Suppôts et Suppliciations nella collana Poésie/Gallimard.
[13] Grossman 2004, p. 1049.
[14] Ved. sopra, pp. 211 sgg.
[15] Grossman 2004, p. 1172.
[16] Ved. sopra, II.5., p. 86, dove viene riportato anche un esempio delle risposte che la Thévenin ha dato, in più occasioni, a questo tipo di obiezioni.
[17] Particolarmente interessante risulta, da questo punto di vista, la proposta della Grossman di considerare la piccola pagina dei cahiers degli ultimi anni alla stregua di una vera e propria “scena di teatro”, di “poesia nello spazio” (ivi, p. 16): insomma, come il luogo in cui “si disegna poco a poco la concezione di un teatro vivente, letteralmente, verticalmente e in tutti i sensi, sulla pagina e nel corpo, in un corpo che si fa ‘trama’, ‘tessuto’, testo […]. Allora, ‘Artaud’ si dice anche ‘Teatro’: TE ARTO-TEATRO, scriverà più tardi” (ivi, p. 956). Sostanzialmente dello stesso avviso sembra essere uno specialista artaudiano di lungo corso, ancorché anomalo e appartato, come Claudio Rugafiori, il quale ha dichiarato di recente: “L’ultima parte dell’opera di Artaud, i molti volumi delle opere complete, sono fondamentalmente opera teatrale” (cfr. Fabio Acca, La fortuna di Artaud in Italia 1935-1970, cit., p. 82).
[18] Con la sola eccezione di quest’ultimo, si tratta di testi messi a disposizione del lettore italiano fin dagli anni Sessanta: cfr. Viaggio al paese dei Tarahumara, cit. Una traduzione recente di Position de la chair (O.C. I**) si trova in A. Artaud, CsO: il corpo senz’organi, a cura di Marco Dotti, Milano, Mimesis, 2003, pp. 23-4.
[19] Grossman 2004, p. 65. Sulla “teoria della carne” in Artaud, cfr. pure, della stessa autrice, Artaud, “l’aliéné authentique”, cit., pp. 76 sgg.
[20] Umberto Artioli, A. Artaud e il Teatro della crudeltà, in Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione (1870-1950), a cura di U. A., Roma, Carocci, 2004, p. 158.
[21] Ivi, pp. 158-9.
[22] O.C. I**, p. 50. Altra trad. it. in A. Artaud, CsO: il corpo senz’organi, cit., p. 23.
[23] Ivi, p. 159.
[24] Sylvère Lotringer, Fous d’Artaud, Paris, Sens & Tonka, 2003, p. 17.
[25] O.C. VII, p. 218.
[26] Grossman 2004, p. 827.
[27] Sylvère Lotringer, Fous d’Artaud, cit., pp. 33 sgg.
[28] Ivi, pp. 18 sgg.
[29] O.C. XI, pp. 268-9. Per la traduzione di questa lettera, cfr. A. Artaud, CsO: il corpo senz’organi, cit., pp. 93-101.
[30] Sylvère Lotringer, Fous d’Artaud, cit., p. 29.
[31] O.C. III, pp. 290-2. Sottolinea l’importanza di questa lettera Thierry Galibert, nell’introduzione al volume collettivo A. Artaud écrivain du sud, Aix-en-Provence, Edisud, 2002, p. 11.
[32] Sulla questione, e per un’analisi complessiva del corpus artaudiano sui Tarahumara, cfr., di chi scrive, A Est di Bali: Artaud, i Tarahumara e il vero Oriente, in L’Oriente. Storia di una figura nelle arti occidentali (1700-2000), a cura di Paolo Amalfitano, Silvia Carandini e Loretta Innocenti, Roma, Bulzoni, 2006, vol. II: Il Novecento. Personalmente, invece, non ho dubbi sul fatto che Artaud sia andato davvero sulla Sierra Tarahumara e ne ho fornite le motivazioni in quella sede.
[33] Michel Camus, A. Artaud. Une autre langue du corps, Bordeaux, Opales/Comptoir d’Edition, 1996, pp. 31-2. Si veda anche una lettera a Jean Paulhan, la quale tuttavia, pur recando nell’intestazione “Chihuahua, 7 ottobre 1936”, sembra scritta già da Città del Messico (O.C. V, pp. 289-90).
[34] Grossman 2004, pp. 1751-2.
[35] Cfr. Grossman 2004, pp. 848-851, con fac-simile della prima pagina del manoscritto.
[36] Camille Dumoulié, A. Artaud…, cit.
[37] Grossman 2004, pp. 10-11.
[38] Cfr., in proposito, il già citato numero 11 di “Culture Teatrali”, intitolato, appunto, Artaud/microstorie.
[39] Un solo, piccolo esempio: Antonio Attisani, in un recente intervento, mostra di non conoscere questa proposta e arriva a scrivere: “La storiografia tende a sottovalutare, in proposito, sia il lavoro di Artaud su se stesso, sia l’impegno da lui profuso con alcune giovani donne che lo frequentavano in quegli anni” (Théâtre le lieu où l’on s’en donne à coeur joie, in AA.VV., Frammenti di un discorso sullo spettacolo. Per Roberto Tessari, Torino, Edizioni del DAMS di Torino, 2003, p. 162). Il che è verissimo ma altrettanto vero è che i due temi di cui Attisani lamenta la sottovalutazione sono esattamente quelli da me trattati ne La danza alla rovescia di Artaud (che egli sembra, per l’appunto, non conoscere). In particolare, il primo ne costituisce proprio uno degli oggetti centrali, vero e proprio leitmotiv che attraversa l’intero lavoro. Per un’importante eccezione, si veda tuttavia Franco Ruffini, I mostri dell’agire e del pensare. Un maestro crudele e la sua vocazione, “L’Indice dei libri del mese”, 12, dicembre 1999, p. 16.
[40] Franco Ruffini, I teatri di Artaud, cit., pp. 89 sgg.
[41] Cfr. Michel Foucault, Storia della follia nell’età classica (1961), Milano, Rizzoli, 1976 (I ed. 1963), e in particolare l’appendice La follia, l’assenza di opera, pp. 623-36.
[42] Vedi più avanti, § 8.
[43] Per le quali, cfr. ora Grossman 2004, pp. 849-72.
[44] Ved. sopra, in II.4., pp. 54 sgg.
[45] Cfr. (pure per quel che segue) Marco De Marinis, A Est di Bali: Artaud, i Tarahumara e il vero Oriente, cit. Anche il precedente § 5 si rifà a questo scritto.
[46] Cfr. Carlo Pasi, Artaud attore, Firenze, La Casa Usher, 1989 (II ed., Torino, Bollati Boringhieri, 2000); Monique Borie, A. Artaud. Il teatro e il ritorno alle origini, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1994 (1989); Elisabetta Brusa, Un viaggio alla sorgente del mistero. Artaud nel paese di Tarahumara, “Biblioteca Teatrale”, 11, 1989, pp. 25-49; Marcello Gallucci, Protasi e Apodosi, in A. Artaud, Messaggi rivoluzionari, a cura di M. G., Vibo Valentia, Monteleone, s.d. (ma 1994). Per un’ampia bibliografia internazionale sull’argomento, cfr. A. Artaud, CsO: il corpo senz’organi, cit.
[47] Florinda Cambria, Artaud in Messico. Note da un viaggio al di là delle colonne d’Ercole, in AA.VV., Terra e storia. Itinerari del pensiero contemporaneo, a cura di Carlo Sini, Milano, Cisalpino, 2000, pp. 251-64; Id., Corpi all’opera. Teatro e scrittura in A. Artaud, Milano, Jaca Book, 2001 (p. 70: “E’ innanzitutto dal confronto con l’esperienza cruciale di quel viaggio [cioè, appunto, del viaggio in Messico] che la vita e la riflessione di Artaud, attraverso e dopo l’internamento del ‘37-’46, dovranno ripartire”).
[48] Luisa Ercolanelli, Viaggi teatrali: Artaud e i Tarahumara, Università di Bologna, Corso di Laurea Dams, a.a. 2001/2002. Un ampio estratto è ora disponibile in Artaud/microstorie, cit., con il titolo Artaud e i Tarahumara: un viaggio tra finzione e realtà.
[49] Camille Dumoulié, A. Artaud, Paris, Seuil, 1996, pp. 83 sgg. (trad. it., A. Artaud, Genova, Costa & Nolan, 1998).
[50] Luisa Ercolanelli ha soggiornato sulla Sierra Tarahumara dal settembre al novembre 2002.
[51] Cfr. il prezioso volumetto curato da Carlo Pasi: Humpty Dumpty di Lewis Carroll nella traduzione di A. Artaud, Torino, Einaudi, 1993, che contiene, oltre all’originale inglese, anche una versione italiana di Guido Almansi e Giuliana Pozzo, un saggio del curatore e un’appendice documentaria. Sugli aspetti più specificamente linguistici della questione, si veda Loredana Pavone, Artaud traduttore a Rodez. “L’Arve et l’Aume”, Catania, Coop. Libraria, 2002.
[52] Lucia Amara, Artaud e Carroll. Thema con variazioni, in Artaud/microstorie, cit. (estratto dalla tesi di laurea con lo stesso titolo, Università di Bologna, Corso di Laurea Dams, a.a. 2002/2003).
[53] Cfr. Humpty Dumpty di Lewis Carroll nella traduzione di A. Artaud, cit., pp. 101, 103.
[54] Ivi, p. 105.
[55] Cfr. sopra, in particolare II.5.-6 e III..B.2.1.
[56] Cfr. Humpty Dumpty di Lewis Carroll nella traduzione di A. Artaud, cit., p. 93. Ho apportato una indispensabile modifica sintattica alla traduzione di Pasi.
[57] Ivi, p. 104.
[58] Cfr., in particolare, A. Artaud. Dessins et portraits, a cura di Paule Thévenin e Jacques Derrida, Paris, Gallimard, 1986.
[59] Cfr. tuttavia (in aggiunta ai riferimenti già fatti nel corso del volume): John C. Stout, A. Artaud’s Alternate Genealogy. Self-portraits and Family Romances, Waterloo (Ontario), W. Laurier University Press, 1996; Michel Camus, A. Artaud…, cit.; Stephen Barber, Artaud. The Screaming Body, London, Creation Books, 1999; AA. VV., 100 Years of Cruelty, a cura di Edward Scheer, Sydney, Power Publications and Artspace, 2001; e soprattutto le recenti edizioni di 50 dessins pour assassiner la magie: Paris, Gallimard, 2004, a cura di Evelyne Grossman; trad. it. Brescia, L’Obliquo, 2002, a cura di Carlo Pasi.
[60] Cfr. sopra, in particolare II.5.-7., III.B.2.1.
[61] Caterina Pecchioli, A. Artaud: segni e disegni, in Artaud/microstorie, cit. (estratto dalla tesi di laurea con lo stesso titolo, Università di Bologna, Corso di Laurea Dams, a.a. 2003/2004).
[62] Alcuni di questi commenti ora si possono leggere in Grossman 2004, pp. 1035-50.
[63] O.C. XI, p. 20 (corsivi miei). Cfr. sopra, pp. 76-7.
[64] A. Artaud, Nouveaux écrits de Rodez, Paris, Gallimard, 1976, p. 113 (corsivi miei).
[65] O.C. XXI, p. 266.
[66] O.C. XX, p. 340.
[67] O.C. XIV*, p. 57 (corsivi miei).
[68] O.C. XVIII, p. 73.
[69] 50 dessins…, cit., p. 28 (trad. it. cit., p. 20). Corsivi miei.
[70] Cfr. la lettera dell’agosto del ‘47, in Grossman 2004, p. 958.
[71] O.C. XVIII, p. 73 (corsivo mio); ora anche in Grossman 2004, p. 1037.
[72] Così definisce i disegni artaudiani la Grossman, in 50 dessins…, cit., p. 10.
[73] Grossman 2004, p. 1037.
[74] Caterina Pecchioli, A. Artaud: segni e disegni, cit., p. 92.
[75] Ivi, p. 93.
[76] Si veda la prefazione, con questo titolo, al libro di Catherine Buthors-Paillart, A. Artaud, l’enonciation ou l’épreuve de la cruauté, Genève, Droz, 1997, ripresa nel volume collettivo Modernités d’A. Artaud (A. Artaud 1), textes réunis et présentés par Olivier Penot-Lacassagne, Paris-Caen, La Revue des Lettres Modernes, 2000.
[77] Cfr. l’importante contributo di Céline Szymkowiak, Langage et schizophrénie: une approche linguistique des Cahiers de Rodez d’Antonin Artaud, suivi du corpus intégral des glossolalies, Dijon, Université de Bourgogne, 2002.
[78] Cfr. sopra, in III.B.2:
[79] In proposito, cfr. anche Giorgia Bongiorno, Introduzione a A. Artaud, Artaud le Mômo, Ci-Gît e altre poesie, cit.
[80] A. Artaud, Il teatro e il suo doppio. Con altri scritti teatrali e la tragedia “I Cenci”, a cura di Gian Renzo Morteo e Guido Neri, Torino, Einaudi, 1968, pp. 136-7.
[81] Ivi, pp. 169-171.
[82] Ivi, p. 195.
[83] Ivi, p. 204 (corsivi miei).
[84] Cfr. le due lettere del marzo-aprile ’43, già pubblicate in O.C. X, pp. 24-37, e ora riprese in Grossman 2004, pp. 882-8, ma soprattutto il testo (dal titolo glossolalico KABHAR ENIS-KATHAR ESTI) che Artaud invia a Jean Paulhan il 7 ottobre dello stesso anno, con queste righe di accompagnamento: “Dopo sei anni d’interruzione di lavoro, mi sono rimesso a scrivere su vostra istigazione. Ecco il testo che ho appena composto” (O.C. X, pp. 107-23; ripreso in Grossman 2004, pp. 899-907).
[85] Lettera a Henri Parisot del 6 ottobre ’45, in Al paese dei Tarahumara, cit., p. 170.
[86] Cfr. sopra, in II.4, n. 31.
[87] Ibid. Corsivo mio.
[88] Ivi, p. 171. Per una più ampia citazione da questa lettera, cfr. sopra, pp. 241-2.
[89] E’ stato Etienne Decroux a parlare della possibilità di un “mimo vocale” e a delineare l’ambito, per altro vastissimo, delle sue possibilità espressive (cfr., Marco De Marinis, Mimo e teatro nel Novecento, Firenze, La Casa Usher, 1993).
[90] Ved. sopra, in II.4.
[91] O.C. XXII, p. 28.
[92] Paule Thévenin, A. Artaud, ce Désespéré qui vous parle, Paris, Gallimard, 1993, p. 84. Ved. sopra, in III.B.2.4., pp. 243-4.
[93] Cfr., ad esempio, in O.C. XXV, p. 342, un testo quasi interamente glossolalico dettato alla Thévenin “in vista di un esercizio teatrale”.
[94] Cfr. sopra, p. 216.
[95] Cfr. sopra, pp. 217-20, dove si fa riferimento anche ad altre lettere (indirizzate alla stessa corrispondente ma non solo) utili al riguardo, e si riporta la testimonianza di Jacques Prevel (En compagnie d’A. Artaud…, cit., p. 16).
[96] Franco Ruffini, Stanislavskij e Artaud: sul filo della biografia, “Prove di Drammaturgia”, 5, 1997, p. 5.
[97] O.C. XXVI, p. 103.
[98] L’episodio è ricordato da Edda Melon nel suo intervento al convegno Follia e/a teatro, svoltosi a Chivasso nel febbraio 1998 (Colette Thomas e Antonin Artaud. Il teatro delle figlie del cuore a nascere, in Follia e/a teatro, Ed. Faber Teater, Vercelli, 1999, pp. 95-110). L’autrice riporta brani di una lettera inviatale dal regista Gérard Mordillat a proposito del suo incontro nel ’92 con Colette Thomas, “rinchiusa nella sua follia”, sulla Costa Azzurra, presso il fratello avvocato (p. 109). Nella stessa pagina, la Melon ricorda in nota che, dopo il suo intervento al convegno, fu Marcello Gallucci a farle notare “una cosa elementare e meravigliosa alla quale non avev[a] pensato”: “e cioè che la maniera di Colette di contare le parole nelle frasi, le lettere nelle parole, va fatta risalire meno ad un sintomo psicotico che ad una preoccupazione di attrice al lavoro. Nella scena del film di Mordillat che ho fatto vedere quel giorno [si riferisce a En compagnie d’Antonin Artaud, film di finzione con Sami Frey protagonista] le istruzioni martellanti di Artaud a Colette Thomas, per preparare la sua lettura al teatro Sarah Bernhardt, si svolgevano proprio così, sillaba per sillaba, nota per nota, come in una partitura musicale”.
[99] Cfr. sopra, in III.B.2.4.
[100] Jacques Prevel, En compagnie d’A. Artaud, cit., pp. 172, 180.
[101] Ivi, p. 176.
[102] Julia Kristeva, L’abietto: voce e grido, in AA.VV., Fonè. La voce e la traccia, a cura di Stefano Mecatti, Firenze, La Casa Usher, 1985, p. 238. Il brano in questione è riportato estesamente sopra, pp. 251-2.
[103] Cfr. O.C. XIII. Per una dettagliata ricostruzione della vicenda da parte di Paule Thévenin, si veda, ivi, pp. 323-339 (trad. it. parziale sopra, pp. 245-7).
[104] La Grossman si è soffermata da par suo sulla molteplicità di sensi di cui Artaud carica la parola émission, non soltanto “trasmissione radiofonica” ma anche, nello stesso tempo, “messa”, “una messa nera e atea, una messa che rovescia ogni idea di spettacolo gratuito o di rappresentazione” (Artaud, “l’aliéné authentique”, cit., p. 144).
[105] Ma in realtà Artaud dicitore si muove tra questi due poli, “esercita[ndo] sulla propria voce degli stupefacenti effetti di modulazione che la fanno passare dall’estremo grave all’estremo acuto, dal maschile al femminile, ritrovando così i principi di polarità della voce e del soffio definiti dieci anni prima nel suo Teatro di Séraphin” (Evelyne Grossman, Artaud “l’aliéné authentique”, cit., p. 147). Del resto, come abbiamo visto, si trattava degli stessi effetti che egli chiedeva di ricercare nella lettura delle poesie, secondo la testimonianza della Thévenin riportata in precedenza: “Dovevo imparare a gridare, a lasciar cadere il grido soltanto allo sfinimento, a passare dal superacuto al più grave, a prolungare una sillaba fino all’esaurimento del respiro”.
[106] O.C. XIII, pp. 126-7. Il testo è riportato sopra, pp. 253-4.
[107] O.C. XIII, pp. 146-7 (Grossman 2004, pp. 1676-7).
Ma che faccia aveva Shakespeare?
I ritratti (veri e presunti) in mostra alla National Portrait Gallery di Londra
di Oliviero Ponte di Pino
La memoria su William Shakespeare vive da sempre un paradosso: da un lato quella che è stata definita “Bardolatria”, il culto del “cigno di Stratford”, ha ispirato una vera e propria industria culturale e sottoculturale, che sforna in continuazione spettacoli, film, saggi, riviste, romanzi, gadget di ogni genere...D’altro canto i documenti in qualche modo effettivamente riconducibili a Shakespeare sono molto pochi, malgrado secoli di ossessive ricerche i tutti gli archivi, ci restano una mezza dozzina di firme, il testamento e qualche altro atto burocratico, qualche raro accenno - magari venato d’invidia - da parte di qualche scrittore suo contemporaneo, e pochissimo altro: un unico disegno , ripreso dallo schizzo di uno studente olandese, sull’interno di un teatro dell’epoca, lo Swan, un disegno con personaggi del Titus Andronicus, con i loro costumi.
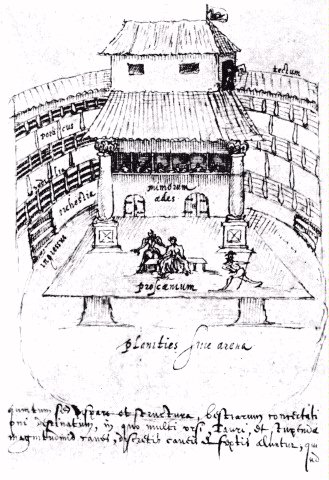
Lo Swan Theatre (1596-97 circa) nel disegno di Arendt van Buchell, ripreso da uno schizzo di Johannes de Witt.
Non sorprende che questo paradosso - nutrito per di più da un periodo della vita dello scrittore, gli “anni perduti”, dove le tracce documentarie scompaiono completamente - abbia generato un’enorme quantità di ipotesi più o meno strampalate: tra tutte, la fantasia che a scrivere i capolavori di Shakespeare non sia stato Shakespeare, ma un altro drammaturgo, magari Christopher Marlowe, un filosofo come Francis Bacon o Giordano Bruno, un nobiluomo come De Vere o Southampton, o addirittura la regina Elisabetta in persona...
Un grasso filone dell’industria shakespeariana riguarda le fattezze dello scrittore, a partire dai ritratto - veri o presunti - affiorati nel corso dei secoli, e che sono al centro di indagini storiche, estetiche, scientifiche, filologiche (e in definitiva fisiognomiche...). E questa indagini, a farsele riassumere, sono appassionanti come un thriller (perché i dettagli, come nella maggior parte delle indagini, rischiano di annoiare).
L’incisione di Martin Droeshout sull’in-folio del 1623 e il busto di Gheerart Janssen
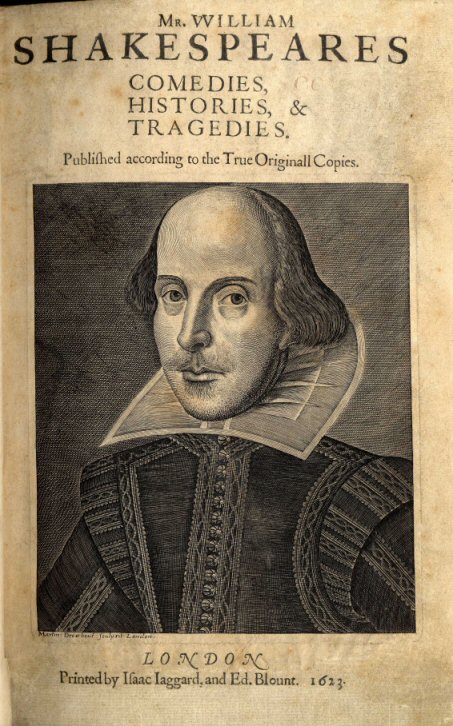
L'incisione di Martin Droeshout che compare nella prima edizione dell'in-folio del 1623.

Il busto di Garrat Johnson (Gheerart Janssen) per il monumento a Shakespeare nella Holy Trinity Church di Straford-upon-Avon (1623 circa).
Certo, abbiamo l’incisione che campeggia sul celeberrimo primo in-folio e la statua sul suo monumento nella natia Stratford: ma risalgono al 1623, alcuni anni dopo la sua morte. Oltretutto sono opera di artisti non eccelsi, e danno l’immagine di quello che Shakespeare era diventato alla fine della sua vita: un agiato gentiluomo di campagna, il figlio del guantaio che aveva fatto fortuna a Londra ma poi aveva abbandonato il turbolento modo del teatro per tornare nella cittadina che l'aveva visto crescere.
Insomma, questi ritratti non hanno né il lampo demoniaco né l’olimpica calma che ci si aspetterebbe da un genio universale. Insomma, è un po’ il personaggio immaginato dal drammaturgo Edward Bond, che nel suo Bingo (scritto negli anni Settanta e portato in scena la scorsa stagione in Italia da Lorenzo Loris) porta in scena Shakespeare come un ricco possidente e maggiorente, che prende le parti della sua classe sociale contro i poveri contadini che si vedono espropriare i terreni.
Per contrastare la compiaciuta bonomia di quelle effigi, un’incisione e un busto, si è scatenata nel corso dei secoli la ricerca di un ritratto shakesperiano un po’ meno banale, in grado di darci qualche indizio sull’interiorità di un grande creatore. Anche perché - a differenza di altri - Shakespeare non ha certo disseminato la propria opera di espliciti riferimenti autobiografici. E quelli - assai rari - che troviamo, risultano spesso ambigui, difficilmente decifrabili. Un ritratto - presumibilmente commissionato dallo stesso soggetto - può dunque fornire informazione assai preziose sull’immagine che Shakespeare aveva di sé, e su quella che voleva dare (per non parlare dell’eventuale valore economico di un’opera del genere). Purtroppo anche per i ritratti, come per diverse altre faccende shakesperiane, siamo nel regno delle ipotesi. Si sono avvicendati nel corso dei secoli diversi candidati, ma non possiamo avere alcuna certezza, se non negative.
A fare il punto sulla situazione è una piccola ma emozionante mostra alla National Gallery di Londra, Searching for Shakespeare, a cura di Tarnya Cooper (nel catalogo saggi di Marcia Pointon, James Shapiro e Stanley Wells). Si può vedere, raccolta per l’occasione, quasi tutta l’evidenza storica dell’esistenza di William Shakespeare e sul suo teatro: i documenti cui si accennava sopra, le prime stampe dei suoi testi (spesso opera di tipografi disinvolti), alcuni oggetti d’epoca (costumi, anelli di matrimonio e funebri, eccetera), ma soprattutto i ritratti veri o presunti.
In mostra ce ne sono sei, che val la pena di guardare da vicino.
Il ritratto Chandos
National Portrait Gallery, Londra

A parere della curatrice della mostra e del catalogo, Tarnya Cooper, resta l’unico possibile candidato. In effetti, è il numero 1 nel catalogo della National Portrait Gallery, che proprio con questa mostra celebre il suo cinquantesimo anniversario. Fu per l’appunto un dono del 3° Duca di Chandos che diede inizio alle collezioni del museo londinese (ed è peraltro indicativo che, proprio mentre il Commonwealth britannico era all’apice della potenza, il primo ritratto appeso alle sua pareti non sia stato quello di un sovrano o di un condottiero).
La tavola è stata presumibilmente dipinta nei primi anni del XVII secolo, e una antica tradizione la attribuisce a John Taylor, pittore e forse anche attore. L’età del soggetto corrisponde più o meno a quella di Shakespeare all’epoca. La prima testimonianza che lega il ritratto a Shakespeare, dell’antiquario George Vertue, che in un suo taccuino elenco i proprietari del quadro risalendo fino a Taylor, è tuttavia assai tarda: risale al 1719.
D’altro canto quel volto ha destato qualche perplessità. Per esempio nel 1864 J. Hain Farrell scriveva:
“E’ difficile immaginare che il nostro Shakespeare, così essenzialmente inglese, sia stato un uomo dalla carnagione scura, pingue, con un’espressione da straniero, una fisiognomica decisamente ebrea, capelli fini e ricci, con una bocca in qualche modo lubrica, occhi bordati di rosso, labbra licenziose, una espressione volgare e i lobi forati dall’orecchino.”
Ancora nel 1907 M.H. Spielmann, storico dell'arte e grande esperto di ritratti shakespeariani, rincarava la dose:
“E’ difficile credere che questo volto bruno, tipicamente italiano, possa rappresentare un esemplare della pura stirpe inglese degli Shakespeare delle Midlands.”.
Pietosamente nel catalogo la curatrice annota che all’epoca molti altri gentiluomini avevano capelli scuri, a giudicare dai ritratti, e che l’ingiallimento della tavola, oggi assai rovinata, poteva influire sul giudizio degli osservatori.
Il ritratto Grafton
The John Rylands University Library, The University of Manchester

Beh, soprattutto dopo il recente restauro i tratti sono certamente più fini, l’occhio - almeno quello - più chiaro. Come campeggia in alto, il ritratto è stato dipinto nel 1588 e il soggetto aveva all’epoca 24 anni (ma c’è una correzione, si è osservato: prima c’era scritto 23), esattamente l’età del Bardo in quell’anno.
Anche l’abito è più sontuoso di quello del ritratto Grafton: anzi, un abito del genere poteva essere indossato solo dai nobili, anche se qualcuno se lo faceva prestare proprio per mettersi in posa davanti a un pittore: sembra tuttavia improbabile che un giovane attore potesse permettersi una giacca così costosa.
Insomma, non si conoscono l’identità del pittore né quella del soggetto. Fu scoperto all’inizio del XX secolo, in una locanda di Winston-on-Tees: i proprietari raccontarono che era stato donato a un loro antenato da uno dei Duchi di Grafton, da cui prese il nome.
A suggerirci l’identificazione del soggetto è tuttavia solo la coincidenza delle date. Uno dei tifosi del ritratto Grafton, non a caso, fu agli inizi del Novecento il professor Spielmann.
Tuttavia questa immagine ha ancora oggi i suoi fans: dovrebbe infatti risalire ai misteriosi "anni perduti" (1585-1592), il periodo della biografia di Shakespeare per il quale non abbiamo alcun documento storico o testimonianza: e dunque, se il ritratto fosse autentico, potrebbe offrire numerosi indizi di grande interesse.
Il ritratto Sanders
Lloyd A. Sullivan, Ottawa

Non ha un aspetto particolarmente mediterraneo, l’uomo ritratto su questo pannello. E per di più sembra lanciare un sorriso enigmatico, sottolineato da uno sguardo acuto e ironico. Forse anche per questo al professor Spielmann non dispiaceva nemmeno il cosiddetto ritratto Sanders, dipinto presumibilmente intorno al 1603. Fu lui infatti a trascrivere un’etichetta - ormai praticamente illeggibile - che si trova sul retro, che diceva trattarsi di tal “Shakpere/Born April 23 = 1564/Died April 23 = 1616/Aged 52/This likeness taken 1603/Age at the time 39 ys”. La carta dell’etichetta dovrebbe risalire alla metà del XVII secolo, ma la scritta è probabilmente posteriore, anche perché il compleanno di Shakespeare cominciò a essere festeggiato nel giorno di san Giorgio, il protettore dell’Inghilterra, solo un secolo più tardi. Inoltre il soggetto sembra avere qualcosa meno dei quasi quarant’anni dichiarati.
Prende il nome da John Sanders, un pittore che dovrebbe aver avuto qualche rapporto con Shakespeare (anche se non ne abbiamo alcuna prova) e attraverso i suoi discendenti è arrivato fino all’attuale proprietario. Esiste traccia di un John Sanders, pittore, che però aveva più o meno vent’anni alla meta del XVII secolo, e dunque non può essere l’autore dell’opera.
Il ritratto Janssen
Folger Shakespeare Library, Washington

Anche in questo caso, come nel ritratto Grafton, un’iscrizione ha indotto qualcuno a credere che potrebbe trattarsi dello sfuggente Shakespeare: “AEte 46/1610”. Poi la curvatura dell’ampia fronte, ormai priva di capelli, sembrava corrispondere a quella dell’incisione che apre l’in-folio. In terzo luogo, l’abito non solo segue i dettami della moda nel 1610 circa, ma corrisponde anche all’idea del costume di un gentiluomo che si erano fatta gli studiosi dell’Otto e del Novecento.
Riemerso alla fine del Settecento, prende il nome da un pittore di origine olandese, Cornelis Janssen. Quando la Folger Library (il maggiori archivio shakesperiano del mondo) decise di acquistarlo, nel 1932, fu convinta dal parere di Joseph Q. Adams, all’epoca supervisore della ricerca della prestigiosa istituzione: “con il ritratto Chandos... e il ritratto Flower... questo è il più celebre ritratto di Shakespeare”.
Purtroppo nel 1964 David Piper si accorse di una strana coincidenza: esisteva un altro ritratto molto simile, senza date, che ritraeva un gentiluomo, probabilmente Sir Thomas Overbury. Unica differenza, il buon Overbury aveva molti più capelli. Ci si accorse a quel punto che l’ampia fronte erano stati dipinti sopra i capelli (e anche l’iscrizione era stata scritta sopra la ridipintura): a restauro ultimato, restano la bella frangetta originaria, ma anche l’iscrizione, a ricordare le fortune del quadro. Che in ogni caso non può essere stato dipinto dal buon Janssen, che nel 1610 aveva appena diciassette anni.
Il ritratto Soest
Shakespeare Birthplace Trust, Stratford-upon-Avon
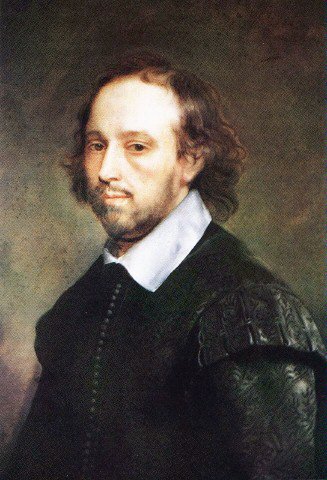
Anche Gerard (o forse Gilbert) Soest era un pittore di origine olandese, attivo a Londra a partire dal 1640. L’opera dovrebbe risalire al 1667, cioè dopo la chiusura dei teatri imposta da Cromwell a partire dal 1642 e la loro riapertura nel 1659 (e nell’occasione fu permesso anche alle donne di salire sulle scene). Insomma, si ricominciavano a mettere in scena i testi di Shakespeare (anche se in versioni adattate al gusto dell’epoca ) e si ricominciava a parlare di lui.
Molto probabilmente il buon Soest aveva di fronte il ritratto Chandos e un attore che, si diceva, somigliava a Shakespeare. Ne venne fuori un quarantenne certamente meno bohémien (per cominciare, gli tolse quell’orecchino, così alla moda mezzo secolo prima) e dall’aspetto meno mediterraneo, con una espressione consapevole e intensa (“introverso e di buone maniere, e di indole sensibile”, annota la Cooper): insomma, una personalità meglio delineata, e certo meno trasgressivamente impulsiva.
Questo è il capostipite di una ampia panoplia di ritratti che hanno cercato nel corso dei secoli di accordare l’aspetto di Shakespeare all’idea che via via si andava sedimentando, e che via via cambiava.
Il ritratto Flower
Royal Shakespeare Company, Stratford-upon-Avon

Riemerso intorno al 1840, prende il nome da uno dei suoi proprietari, John Flower.
E’ stato considerato a lungo l’immagine più credibile, quella da cui il diligente Droeshout aveva tratto la sua incisione. Ma neppure il fiducioso Spielmann era di questo parere: per lui in quadro era stato dipinto all’inizio del Seicento, ma la “legnosità” della composizione gli fecero pensare che fosse stata l’incisione ad ispirare il quadro e non viceversa.
Poi, nel 2005, il colpo di scena. L’esame ai raggi X ha rivelato che sotto il ritratto c’era una Madonna con Bambino e Giovanni Battista, un dipinto italiano risalente alla metà del Cinquecento. Anche Spielmann si era accorto della ridipintura, ma le tecniche dell’epoca non gli avevano permesso di andare oltre questa constatazione.
L’angolo in alto a sinistra è stato ripulito, e si può vedere un frammento del paesaggio che faceva da sfondo: anche in questo caso, è stata preservata la scritta “William Shakespeare, 1609”
Il falsario era senz’altro abile: utilizzò una tavola sufficientemente antica, riprese alcune tecniche pittoriche dei primi del Seicento, corresse alcuni degli “errori” di Droeshout (a cominciare dall’orecchio mal posizionato). Ma, come può capitare ai falsari più abili, fece anche qualche errore: utilizzò per esempio qualche pigmento un po’ troppo moderno, come un giallo cromo che i pittori iniziarono a utilizzare dopo il 1814, e probabilmente anche un blu ultramarino che cominciarono a fabbricare in Francia solo dopo il 1828.
Quella dei ritratti di Shakespeare è una storia divertente, tra capelli cancellati e orecchie spostate, fisiognomisti razzisti e astuti falsari. Ha ispirato articoli scientifici e libri; tra i più recenti, quello di Stephahie Nolan, Shakespeare’s Face, Knopf, Toronto, 2002).
E se restano sempre valide le parole dell’amico Ben Johnson nei versi che aprono l’in-folio (che dicono, più o meno: “Beh, l’incisione gli assomiglia abbastanza, ma l’importante sono le parole di Shakespeare, non il suo aspetto”: “Reader, looke / Not on his Picture, but his Booke”), non si può dimenticare che la storia dei ritratti di Shakespeare ha molto da dirci: non su Shakespeare, ovviamente, ma su di noi.
Se volete saperne di più, curiosate anche nella nostra poderosa ateatropedia, e in particolare date un'occhiata alla recensione della mostra Shakespeare nell'arte.
Speciale Torino 2006: chiude il circuito teatrale piemontese?
Con una intervista al commissario Angelo Pastore
di Franco D’Ippolito
Lo Speciale Torino 2006 - abbiamo iniziato a parlare della situazione cittadina in ateatro 97 - riserva qualche sorpresa: pare che stia per essere smantellato il Circuito Regionale Piemontese. Naturalmente una anticipazione di questo genere non potevamo certo tenercela per noi...
Sembra che l'assessore regionale alla cultura Gianni Oliva sia orientato a questa scelta,
salvo poi andare a costituire una nuova associazione con i Comuni. Francamente riesce difficile capire come sia possibile che un circuito territoriale storico rischi di fallire (o quasi) in meno di quattro anni. Possiamo solo augurarci che un servizio fondamentale come questo non venga compromesso.
Un po’ di storia. Nella stagione 2001-02 il circuito teatrale piemontese diviene un’istituzione autonoma dal Teatro Stabile di Torino (che aveva fino ad allora curato la distribuzione in regione attraverso l’Ufficio Territorio) e nel febbraio 2003 si costituisce in Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte (soci la Regione Piemonte e il Teatro Stabile di Torino). L’anno successivo si definisce il quadro direttivo, con le nomine di Alessandro Germani alla presidenza e di Giacomo Bottino (direttore artistico del Teatro Giacosa di Ivrea e consulente artistico del Contato del Canavese) come direttore.
Nello scorso dicembre, dopo appena due anni di attività, a seguito di irregolarità amministrative nella gestione, la Fondazione viene commissariata. La Regione nomina Commissario Angelo Pastore (già responsabile dell’ufficio programmazione dello stabile torinese e attualmente consulente organizzativo Centro Teatrale Bresciano). La scelta di un operatore teatrale al posto di un politico la dice lunga sui problemi del circuito e sulla urgenza di intervenire sulla struttura operativa e sulle modalità di gestione della distribuzione nel territorio. L’ultimo nato dei circuiti, ministerialmente parlando, conferma la necessità di ripensare ruolo e funzioni degli organismi di promozione e formazione del pubblico, sia nei confronti dei soci, sia nei modelli di distribuzione sul territorio che nel tipo di relazione e sostegno alla produzione, soprattutto regionale.
Ho incontrato Angelo Pastore nella sua Torino, città rinata e rivitalizzata dalla scommessa di farne una grande capitale culturale (non mi ero mai accorto del numero incredibile di librerie che ci sono a Torino, ed è una bellissima sensazione sapere che mentre dovunque restano soltanto i megastore del libro, nel capoluogo piemontese la libreria è ancora un luogo in cui in incontrare il libraio che può consigliarti e segnalarti le ultime uscite). Gli ho chiesto come si sentiva, lui organizzatore di teatro pubblico, catapultato in una situazione così difficile e come stava lavorando per raddrizzare la barra dell’organismo piemontese.
Siamo in una fase interlocutoria del processo di risanamento da cui dipenderà il futuro della stessa Fondazione. La Regione e tutti i Comuni coinvolti ci tengono molto a sostenere la distribuzione sul territorio perché, nonostante tutto e tutti, il lavoro di chi nei decenni scorsi ha creduto fortemente in questo (penso soprattutto a Giorgio Guazzotti, ma non solo) non è andato perso. Ci sono teatri che funzionano bene e soprattutto che hanno costruito e consolidato un loro pubblico.
Nella stagione in corso sono 29 i teatri programmati: 10 in provincia di Torino, 3 nella provincia di Alessandria, 4 in quella di Asti, 7 in quella di Cuneo, 2 in quella di Novara, 1 ciascuno in quelle di Biella, Verbania-Cusio-Ossola e Vercelli. La Fondazione non annovera fra i soci i Comuni, che sono per così dire “committenti” dei servizi di gestione e programmazione del circuito attraverso la stipula di convenzioni annuali.
Alcune delle cause dell’attuale crisi vanno ricercate nell’atto di nascita della Fondazione, che non ha coinvolto in prima persona i Comuni e si è risolto all’interno del rapporto fra Regione e Stabile di Torino. A mio avviso questo ha indebolito il circuito e ne ha ridotto le potenzialità quale strumento di gestione partecipata (e perciò controllata) da parte dei soggetti principali dell’attività, i Comuni appunto. Non vi è dubbio poi che il distacco dallo Stabile sia stato forse troppo netto e rapido, senza prevedere una fase intermedia, soprattutto dal punto di vista organizzativo, di “tutoraggio” del neonato organismo.
A tutto questo si deve aggiungere l’indeterminatezza nella definizione dei compiti e delle responsabilità del direttore, non dichiarate specificatamente dallo statuto della Fondazione, né dal regolamento di attuazione che, pure previsto, non è ancora stato adottato. Vale la pena di ricordare in proposito che la normativa per il riconoscimento dei circuiti teatrali regionali ai fini delle sovvenzioni statali stabilisce, fra i requisiti di ammissibilità, la presenza di un’autonoma e qualificata direzione artistico-organizzativa con esclusione di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica. La confusione fra ruoli politici di indirizzo e gestionali-organizzativi (un altro dei problemi che riguarda molti circuiti regionali, al punto che quello toscano e quello pugliese non hanno addirittura in organico un direttore artistico-organizzativo), ha portato poi la Fondazione ad operare sul filo della sovrapposizione fra funzioni distributive e paraproduttive. Chi era presente a un incontro sul teatro sociale a Castagnole Monferrato nel settembre 2004 ricorderà l’allora Presidente, Alessandro Germani, parlare esplicitamente di “sostegno alla produzione piemontese attraverso l’imposizione di scambi con altri teatri e con i circuiti”. L’attuale situazione di difficoltà è richiamata anche sulla stampa torinese con un intervenuto dell’assessore regionale alla cultura Gianni Oliva che, a proposito del compenso annuale del direttore del circuito (si parla di 160.000 euro lordi, ma Bottino sostiene che sono 118.000), ha sostenuto la necessità di fissare dei parametri massimi a cui i rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione delle istituzioni culturali piemontesi dovranno uniformare le proprie decisioni.
Quali sono i problemi più gravi che il Commissario ha dovuto affrontare?
Certamente le questioni economiche, poiché la Fondazione aveva i fondi bloccati nelle banche, gli incassi delle stagioni fermi nei teatri e vi erano molte, troppe compagnie che aspettavano da mesi di essere pagate. Il tutto a stagione in corso, cioè con altre compagnie che si accingevano a entrare in circuito e che bisognava pagare, a cui bisognare corrispondere almeno un congruo acconto sulle spettanze. Inoltre non erano mai stati inoltrati al Ministero i consuntivi dal 2003 con la conseguenza che non erano stati incassati né gli acconti, né tanto meno i saldi delle sovvenzioni ministeriali per tre annualità. Le dinamiche economiche del circuito erano abbastanza fuori controllo, non vi era corrispondenza fra la liquidità e gli impegni assunti. Ho dovuto intervenire drasticamente, con un taglio di circa il 30%, sul Progetto Olimpico “Le Montagne del Fare Anima”, che non aveva copertura in bilancio per svariate centinaia di migliaia di euro. E sono stato costretto a tagliare (mio malgrado perché da organizzatore di spettacoli mi rendo conto di quanto possa essere grave per una compagnia vedersi annullare delle recite nel corso della stagione) anche l’attività ordinaria per circa il 15% delle spese, non modificando però nessuna delle programmazioni in abbonamento, per non aggiungere al danno alle compagnie anche la beffa nei confronti del pubblico.
L’attuale pianta organica del circuito è composta da un direttore e 13 persone (di cui solo due a tempo indeterminato) suddivise in segreteria generale (2), ufficio programmazione (4), ufficio comunicazione (3), gestione tecnica (3) ed amministrazione (1).
Stiamo anche cercando con i sindacati di strutturare meglio l’organico della fondazione, per migliorare la gestione dell’ente ed i servizi ai soci ed alle compagnie.
Le responsabilità che ricadono oggi sul Commissario sono soprattutto quelle di individuare con la Regione le soluzioni per il rilancio dell’attività di distribuzione regionale, partendo dagli errori e dalle omissioni di questi ultimi due anni.
Abbiamocercato il coinvolgimento diretto dei Comuni, non escludendo neanche la creazione di nuovi soggetti istituzionali e allargando i settori d’intervento, non limitandosi al settore del teatro di prosa, per esempio.
La Regione sembra infatti orientata alla chiusura della Fondazione e alla costituzione in tempi brevi di una nuova associazione fra i Comuni (probabilmente con l’intervento dell’AGIS Piemonte), nell’intento di snellire i costi di struttura, ma anche di ragionare sui bacini d’utenza rappresentati da mini sistemi provinciali che coinvolgano altri soggetti di programmazione già operanti sul territorio.
Nel panorama torinese e piemontese che segnala una straordinaria vitalità delle attività culturali frutto di una precisa scelta politica da parte della Regione e degli Enti Locali territoriali, la vicenda della Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte è sicuramente un “punto di debolezza”. Nonostante questo continuo a credere fortemente nel ruolo dei circuiti, soprattutto in questa fase di riordino delle competenze in materia di spettacolo fra Stato e Regioni. Ma per farlo non è più rinviabile, anche alla luce delle vicende torinesi, una chiara e netta distinzione fra il livello politico di indirizzo nazionale e regionale e quello artistico-organizzativo dei circuiti, che deve contraddistinguersi per un alto profilo etico-manageriale.
Speciale Torino 2006: nasce la Fondazione Teatro Europeo
Un festival teatrale internazionale per il Piemonte
di Franco D’Ippolito
Un’altra grossa novità si profila nell’immediato orizzonte del sistema teatrale piemontese in grande fermento: la costituenda Fondazione Teatro Europeo, che nascerà, a opera della Regione e della Provincia di Alessandria, il prossimo giugno e la cui Presidenza (stando ai primi "si dice") sarà assunta, a testimonianza dell’importanza che gli si riconosce, direttamente dalla Presidente della Giunta Regionale Mercedes Bresso.
Il Teatro Europeo è un festival internazionale che muove i primi passi nella primavera del 2001 con l’intento di “aprire” la città di Torino al confronto con il resto d’Europa teatrale, fino ad allora appannaggio più che altro di un pubblico specializzato. La scommessa di fare del teatro internazionale una delle componenti normali dell’offerta torinese, affidata dalla prima edizione alla direzione di Beppe Navello, si realizza grazie alla volontà della Provincia di Torino e alla collaborazione dell’Università. Nei primi cinque anni il festival è passato dalla minuscola sala del Centre Culturel Français al Teatro Espace e al Carignano, per entrare l’anno scorso nell’edificio del Vecchio Tribunale e nella sala della Cavallerizza Reale. La Francia è sempre stato il paese più ospitato, grazie anche alla collaborazione con un artista come Jean Claude Penchenat, ma fin dal 2003 il programma ha coinvolto teatri e gruppi tedeschi, spagnoli, polacchi, svizzeri, cechi, inglesi, irlandesi, danesi, belgi e russi. Di particolare interesse le produzioni che hanno impegnato gli allievi del DAMS e delle scuole di danza torinesi.
I risultati delle precedenti edizioni (ed il clima che si respira a Torino fra i teatranti) faranno sì che il festival diventi un’istituzione stabile con finanziamenti adeguati e soprattutto certi (in ragione di alcune centinaia di migliaia di euro), con obiettivi più ampi ed ambiziosi. L’edizione 2006, la prima della nuova fondazione, non si svolgerà soltanto nelle strade e nei teatri (Gobetti, Astra, Espace e Cavallerizza) del capoluogo regionale ma interesserà anche Alessandria con 7 performances. Contribuiranno alla sua realizzazione, oltre i soci della fondazione, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Comune e la Provincia di Torino, il CRUT (Centro Regionale Universitario per il Teatro) ed alcune Fondazioni bancarie. Nella prima settimana di giugno sono previste ospitalità da 12 Paesi (per la prima volta ci saranno spettacoli provenienti dalla Turchia e dalla Grecia), fra cui possiamo anticipare uno spettacolo di Jean-Pierre Larroche “A’ Distances” della Compagnia francese Les Ateliers du Spectacle, la prima italiana di “La fin des terres” di Philippe Genty con la sua compagnia ed il ritorno dei parrucchieri-attori spagnoli Osadia con “Coiffures d’art”. Nell’autunno si prevedono due produzioni miste italo-francesi con uno spettacolo sul cinema muto, affidato a Beppe Navello, e la messinscena di un testo sull’immigrazione piemontese in Francia per la regia di Jean Claude Penchenat del Théâtre du Campagnol di Parigi.
Sarà interessante seguire il gran fermento torinese (frutto evidentemente anche dell’occasione olimpica e quasi un contraltare dello spazio dato al Progetto Domani di Ronconi) anche nella direzione dei festival estivi. La nuova Fondazione dovrà saper delineare bene la propria mission e per farlo, oltre a continuare nella scia dei primi cinque anni, bisogna che dialoghi ed instauri una relazione di “concorrenza solidale” con lo Stabile e il festival delle Colline Torinesi. Il rischio, infatti, di questa straordinaria vitalità della vita culturale piemontese, è quello che la politica sostenga e promuova lo sviluppo di organismi e di attività che si sovrappongano ad altrettante realtà. Se, invece, si favorirà l’integrazione delle attività, privilegiando le diversità e le specificità di ognuno, il risultato non potrà che essere quello dell’allargamento dell’offerta di cultura teatrale in Regione.
Speciale Torino 2006: Caro Nevio
Una risposta alla mail di Nevio Gambula
di Oliviero Ponte di Pino
Caro Nevio,
è davvero difficile rispondere a una lettera (vedi ateatro97) dove mescoli davvero di tutto, dal tuo disagio esistenzial-relazionale alle grandi questioni geopolitiche (a volte in maniera facilona e un po’ ricattatoria), dal povero Ascanio Celestini (tra parentesi, le cose più dure contro i narratori le ho sentite dire proprio da Ronconi...) alla perversione economicista del nostro tempo, dalla politica degli scambi (tra parentesi, il Progetto Domani non aveva tra i suoi obiettivi quello di far girare gli spettacoli) alla mercificazione dello sport. Dove ti offendi se ti danno della verginella e poi rivendichi con orgoglio la tua verginità.
E’ anche molto difficile rispondere a chi come te vuol vedere tutto bianco o tutto nero. Sulla situazione del Medio Oriente, per quanto mi riguarda, ritengo che una cultura politica in cui i genitori sono orgogliosi e felici perché i loro figli adolescenti si sono fatti imbottire di esplosivo e chiodi e poi si sono fatti saltare in aria in mezzo ai civili, mi ripugna (fermo restando che quei ragazzi e i loro genitori sono vittime anche loro, le prime vittime). Perciò, ragionando al tuo livello, io dovrei stare sempre e comunque tutto dalla parte degli israeliani.
Dopo di che sull’argomento io e te dovremmo smettere di discutere e fare a botte. Civilmente?
Insomma, discutere in bianco e nero e con un groppo di sollecitazioni così intricato, mi è impossibile. Però posso provare ad approfondire qualche punto.
Scrivi: “Ronconi non rientra nell’idea di teatro che mi sono fatto e quindi non posso amarlo”. Liberissimo, come sei libero di addormentarti ai suoi spettacoli e di decidere tu (possibilmente a priori, senza vedere gli spettacoli) qual è l’idea giusta di teatro, e che tutte le altre sono sbagliate. Per me - anche se seguo Danio Manfredini fin dagli esordi, amo moltissimo il suo lavoro e l’ho sempre sostenuto - molti degli allestimenti ronconiani sono stati una festa dell’intelligenza, della cultura e del cuore. Hanno formato la mia sensibilità di spettatore (e non solo). Ho cercato in varie occasioni di spiegare perché (vedi di recente su ateatro quel lungo mappazzo in 3 puntate che è Semplicemente complicato) e di dimostrare che Ronconi rientra a pieno titolo nella “tradizione del nuovo” e la innova (scusa il gioco di parole).
Se ti può interessare, se c’è un teatro anti-televisivo, non naturalista, tendenzialmente anti-narrativo e attento all’“evento”, è proprio quello di Ronconi: se bastasse questo a rientrare nel tuo canone teatrale, il Progetto Domani meriterebbe un posto d’onore...
(Una questione di metodo. Io non ho una linea politica da imporre. Non ho un’estetica da promuovere e altre estetiche da censurare. In teatro, e fuori dal teatro, ci sono tante cose che amo, e che imparo ad amare - cose che a volte mi sorprendono perché sanno andare oltre le mie misere categorie e addirittura le mettono in discusione. Insomma, cerco di restare intellettualmente libero.)
Su un punto sono perfettamente d’accordo che te: non basta avere contenuti di sinistra per essere di sinistra, come sapeva già Lukács. Nello Specchio del diavolo, non credo che il punto sia il messaggio europeista di Ruffolo, ma il modo in cui un pamphlet sulla finanza ha trovato la sua forma teatrale. Quello che mi interessa in questa fase del lavoro di Ronconi è un’altra cosa: utilizzare il teatro come strumento razionale di conoscenza, usare il lavoro teatrale sul testo e con gli attori come metodo di confronto con la realtà e con se stessi. Non so se questo porti necessariamente a contenuti di destra o di sinistra, ma mi sembra una bella sfida (e in qualche modo una forma di “resistenza teatrale”).
Non voglio fare il difensore d’ufficio di Ronconi, che non ne ha bisogno. Posso solo riproporre un mio breve testo scritto per “Hystrio” sulle ragioni della mia curiosità per il Progetto Domani:
Rispetto alle polemiche scatenate da precedenti "follie" ronconiane, dal Laboratorio di Prato agli Ultimi giorni dell'umanità, accusati di sprechi e inutilità, il Progetto Domani è stato accolto da elogi pressoché unanimi. E forse i primi a dispiacersene sono stati proprio organizzatori e regista, che magari speravano nelle ricadute pubblicitarie dello scandalo...
Invece questa "gran fondo teatrale" ha brillantemente superato l'esame, come le lodatissime Olimpiadi torinesi. Gli spettacoli, con decine di ore di rappresentazione su palcoscenici giganteschi, utilizzando centinaia tra attori, tecnici, organizzatori, sono andati regolarmente in scena (salvo il forfait di Massimo Popolizio, in un curioso parallelo con le rovinose cadute di Rocca e Kostner).
Man mano che debuttavano gli spettacoli è emersa la natura unitaria e organica del progetto: verificare sperimentalmente la possibilità del teatro di misurarsi oggi con i grandi temi del pensiero, della politica, della modernità, senza perdere il rapporto con la tradizione. Dunque una lettura "contropelo" della guerra di Troia (impossibile non collegare questo Troilo e Cressida al Bond, agli Ultimi giorni, ai Soldati di Lenz poco dopo in scena a Milano, in una riflessione di ampio respiro sulla guerra) per arrivare fino alle biotecnologie e all'economia della globalizzazione.
Non è solo e tanto un problema di contenuti, quanto di metodo. Si trattava di verificare laboratorialmente la scommessa dell'ultimo Ronconi, dal Pasticciaccio a Infinities: usare come strumento di conoscenza il teatro - il lavoro di palcoscenico, l'interpretazione di un testo (non necessariamente drammatico) attraverso il corpo e la voce degli attori, l'esplorazione dello spazio e del tempo, la creazione di luoghi, immagini e figure (più che personaggi) che danno fisicità alle metafore, l’incontro con il pubblico.
Aldilà dei singoli spettacoli (e quelli che ho visto mi sono piaciuti), l'esperimento mi ha incuriosito per questo. Quello di Ronconi è un teatro che non si accontenta di essere un museo (o una vetrina dell’Io), che non si chiude su se stesso e sulla tradizione, che non ha un messaggio da trasmettere, ma si propone come luogo di esperienza e di conoscenza.
La "naturalezza" con cui sono state accolte le invenzioni linguistiche e l'intreccio di registri dello Specchio del diavolo dimostrano che la sua scommessa l'ha vinta e che al teatro si possono annettere altri territori, lontani dalla drammaturgia tradizionale ma anche dal documentario televisivo o da una spettacolarità puramente visivo-gestuale dalla narrazione, dalla classica conferenza o dalla narrazione. Una creazione di senso, non banalmente illustrativa, dove la pratica scenica diventa uno strumento per interrogare la realtà e noi stessi: mi pare una bella e ambiziosa idea di teatro.
Con questo non voglio dire che questa sia l’unica idea di teatro oggi praticabile, o l’unica idea di teatro giusta e necessaria. E’ una strada, e mi sembra che abbia una sua dignità e un suo interesse. E spesso i risultati sono affascinanti e utili.
Per quanto riguarda la progettazione del Progetto Domani, si sarebbero potute imboccare altre strade. La scelta di affidarsi a Ronconi, vista la sua statura artistica e l’ampio respiro del progetto, non era del tutto insensata. Per quanto mi riguarda, avrebbero potuto essere fatte altre scelte: avevamo provato, con Mimma Gallina, a porre il problema, senza alcuna fortuna. La nostra lettera aperta è caduta in un silenzio pressoché assoluto. Evidentemente al teatro italiano (e non solo) andava bene così. Su questo - lo ammetto - c’è senz’altro da parte mia un elemento di irritazione e insofferenza: discutere oggi di questo punto mi sembra tardivo e inutile, per ottenere qualcosa bisognava uscire allo scoperto allora. Se non l’ha fatto nessuno, è perché in quel momento l’obiettivo della polemica non sarebbero stati Ronconi e i suoi spettacoli, ma i veri signori del teatro italiano e i suoi assetti di potere: ovviamente nessuno ha avuto il coraggio di metterli in discussione.
(Il tuo parallelo con le posizioni sulla guerra nella ex-Jugoslavia non mi sembra pertinente. Personalmente non penso che fare begli spettacoli per le Olimpiadi, e investire denaro in spettacoli teatrali sia un errore politico-culturale, anzi. Nel tuo esempio invece l’intervento italiano nei Balcani è stato e resta un errore politico; di più. Se prendere soldi pubblici per il proprio spettacolo significa perdere la verginità e compromettersi con il potere, anche l’ultimo spettacolo di Danio Manfredini è stato prodotto da un grosso teatro stabile e ospitato da teatri che vivono solo grazie alle sovvenzioni dello Stato italiano.)
Un’ultima annotazione. La decisione di affidare il Progetto Domani a Ronconi non è stata una scelta del mercato (e neppure di un mercato inefficiente e distorto come quello del teatro italiano: un tema sul quale ateatro ha speso pagine e pagine, e continuerà a farlo). Quella per le Olimpiadi torinesi è stata una scelta prettamente politica, al di fuori di ogni criterio di mercato. Era insomma un “progetto speciale” irripetibile, un unicum. La vicenda, più che il normale meccanismo della domanda e dell’offerta, ricorda piuttosto i rapporti “antichi” di un artista con il suo mecenate. Se questo dia spazi di agibilità politica più ampi del mercato - e del mercato attuale - può essere un interessante tema di discussione. Anche perché viviamo nell’era degli sponsor...
Il poeta fuori dalle caverne
Brevi scritti su Franco Scaldati
di Clara Gebbia
Le foto sono di Maurizio Ruggiano.
Abbiamo seguito per qualche giorno Franco Scaldati, definito da Franco Quadri “poeta delle caverne” per intervistarlo, fotografarlo, assistere alle riprese e alle prove di due spettacoli, riuscendo anche a fargli una breve intervista.
Qui di seguito, parte dei testi raccolti e le foto realizzate a Palermo.
IL MONDO E’ UN QUARTIERE
Piccola conversazione con Franco Scaldati prima delle riprese di Assassina

L'autrice del servizio durante l'intervista con Franco Scaldati.
Mi piace sempre come Franco Scaldati dice: “Il quartiere”.
Lo dice come se in quella parola ci fosse il centro del mondo, come se si riferisse al solo quartiere che esiste, e come se tutti sapessimo di cosa parla.
Il punto è che ha ragione.
Perché mi pare che Franco parli dell'Albergheria (quartiere del centro storico di Palermo dove lavora da più di un decennio, all’interno del Centro Sociale S. Saverio di Don Cosimo Scordato) alludendo al luogo geografico e dell’anima da cui ognuno di noi proviene, che ha marchiato a fuoco la nostra infanzia, la nostra appartenenza, e di cui noi palermitani portiamo indelebilmente il segno, soprattutto nel linguaggio.
Nonostante la direzione artistica del Festival di Gibellina, mi sembra che il cuore di Franco sia comunque il quartiere, che “abita” in senso teatrale senza mai farne un ghetto, anzi un modello di apertura alla diversità, dove c’è posto per vecchi, bambini e immigrati, che, come dichiara en passant con grande lucidità intellettuale, non sono presenze da dimenticare, piuttosto ci parlano di “futuro”, della nuova configurazione delle città.
Mi stupisce inoltre la sua tenacia, l’entusiasmo e la determinazione con cui, insieme ai suoi collaboratori, da anni insegue il suo sogno.
Parlami della tua esperienza presso il Centro Sociale di Don Cosimo Scordato all'Albergheria.
Quando hai cominciato?
Circa una dozzina di anni fa.
Il motivo per cui abbiamo cominciato a lavorare qui all'Albergheria è che facendo questo mestiere c’è un momento in cui ci si interroga sulle motivazioni. In seguito a queste riflessioni abbiamo pensato che sarebbe stato importante spostare la nostra attività in un quartiere popolare.
Questa scelta è ovviamente collegata al tipo di drammaturgia con cui lavoro e alla mia conoscenza dei quartieri. Io sono un uomo di quartiere e ad un certo punto quella di lavorare qui è stata una vera e propria esigenza, per stare più a contatto con quelle che sono le origini del nostro teatro, per attivare una dinamica che al gruppo è servita molto e che mi auguro sia servita anche all'Albergheria.
Da allora non abbiamo mai smesso, ho lavorato qui per parecchi anni e adesso, dopo tanto tempo ci siamo rispostati fuori.
Fuori dove?
Abbiamo ripreso a fare spettacoli in palcoscenico, perché se ne sentiva l'esigenza.
Abbiamo preso contatti con il Teatro Garibaldi di Matteo Bavera e abbiamo fatto lì alcuni spettacoli. Inoltre mi hanno offerto la direzione artistica del Festival di Gibellina e quindi siamo andati anche lì. E stiamo continuando su questa linea di apertura. Forse qui all'Albergheria dovremo interrompere per un po' l'attività perché i locali non sono a norma e quindi sono inagibili.
Speriamo che questa faccenda dell'agibilità dei locali si riesca a sistemare presto, ma in realtà ci vorrà un po’ di tempo.
La vostra sede di prova qual è esattamente?
Abbiamo delle stanzette al piano di sopra ma sono troppo piccole.
Per questo motivo la sede di prova è sempre stata all’esterno, il giardino.
L’estate palermitana fino a qualche anno fa almeno cominciava ad aprile e finiva a novembre, quindi nel cortile abbiamo fatto un lavoro molto intenso.

Parlavi delle origini della tua drammaturgia e sei ritornato al quartiere, ma fai tra le righe anche una riflessione sul fatto che il teatro qui assume un ruolo diverso. Perché?
Semplicemente perché si fa il teatro dove il teatro non c’è.
L’offerta teatrale è tutta rivolta alla borghesia, nei quartieri popolare del centro storico il teatro non arriva. E questo è grave se si tiene conto del fatto che Palermo ha il più grande centro storico d’Europa.
A cosa porta il fare teatro in contesti non borghesi?
C'è un sistema di riferimenti completamente diverso, che ha più a che fare con l'identità.
Fare teatro qui è un'esperienza molto più intensa, non c'è molto altro per trovare il modo di esprimere se stessi.
La gente si identifica con un modo di fare teatro, lo sente proprio, gli appartiene e così ciò contribuisce a sviluppare la propria identità culturale. I quartieri del centro storico sono emarginati culturalmente, li si mette da parte e per di più si cerca di chiudere gli occhi su queste grandi mancanze. Non sono zone in cui si la cultura passa e lascia il segno. Facendo teatro ci si riappropria della propria cultura.
D’altra parte è proprio nei quartieri popolari del centro storico che resistono i residuati della nostra cultura millenaria, anche nella lingua. Io trovo che lavorare qui abbia un significato innanzitutto fortemente poetico e conseguentemente politico.
Quindi c’è una corrispondenza biunivoca: al quartiere serve il teatro e al teatro serve il quartiere.
Per quanto mi riguarda assolutamente si.
Naturalmente parlando di quartieri del centro storico non si può non tenere conto dell'immigrazione degli ultimi 20 o 30 anni che ha modificato l'assetto della popolazione.
I quartieri del centro storico stanno accogliendo gran parte degli immigrati, e in qualche modo ci preparano ad una visione futura della società.
Quali reputi le tappe fondamentali del tuo lavoro?
Non ci sono tappe, anzi la cosa fondamentale è la continuità.
Ci sono spettacoli più riusciti e meno riusciti, ma essenziale è stato il rapporto nel tempo con il quartiere, che è un rapporto dinamico e non sempre sereno, ma comunque paritario e non colonialistico. Voglio dire che se ci sono i ragazzini che disturbano, ci arrabbiamo, perché bisogna far capire che la disciplina del teatro di cui il teatro necessita va rispettata. Non vogliamo insegnare niente a nessuno ma porre dei quesiti, far intravedere altre possibilità, un altro modo di rapportarsi alla vita completamente diverso da quello diffuso qui all'Albergheria, una visione che la poesia e il teatro possono offrire e che per di più è legata alle nostre origini linguistiche e culturali.
Chi frequenta il tuo laboratorio?
La prima cosa che vorrei che fosse sempre assolutamente chiara è che questo non è un ghetto.
I laboratori li hanno frequentati moltissimo i ragazzi del quartiere, ma li frequentano anche studenti del Dams...
E’ un luogo assolutamente aperto, dai ragazzini ai vecchi, tanto che il problema della selezione non si è mai posto.
Si lavora per fare teatro e applichiamo la disciplina che è propria del teatro, senza fare sconti: è teatro nel senso proprio del termine, non è animazione, né altro.
Questa è la nostra proposta e chi la accetta si sottopone alla disciplina che ne consegue. E’ chiaro che abbiamo dovuto fare i conti anche col fatto che chi frequenta il laboratorio è gente che lavora, che deve conciliare il teatro con la propria vita pratica... ci sono madri e padri con figli, spesso con problemi economici ed esigenze di orari. Ma negli anni tutto questo e’ stato esaltante.
Quali sono gli spettacoli a cui ti sei più affezionato?
In realtà potrei nominarli tutti. Ogni spettacolo ha la sua importanza, data dalla sua storia.
Da Bonaventura al laboratorio su Shakespeare, a Santa Rosalia che è una specie di omaggio che facciamo tutti gli anni alla Santa … Quest’anno è saltato ma lo riprenderemo l’anno prossimo. Partecipa in parte gente del quartiere, e in parte gente che viene da fuori. Insisto nel dire che la cosa importante è in primo luogo quella di evitare di chiudersi in un ghetto, ma anche di evitare la retorica del teatro come impegno sociale. Il teatro questo impegno c’è l’ha sempre, per definizione. Il nostro modo di fare teatro è quello di portarlo in luoghi diversi rispetto a quelli canonici, ma facciamo comunque teatro e non altro.
C’è un metodo per approcciarsi alle persone che arrivano al laboratorio che hanno esperienze diversissime tra di loro?
C’è stato un punto di partenza importante qui all'Albergheria per quanto riguarda l'incontro con le persone. Noi ci siamo inseriti quando il Centro Sociale di don Cosimo Scordato era presente e agiva già da 10 anni, quindi abbiamo trovato un terreno fertile.
E' stato grazie al Centro Sociale San Saverio che molte persone si sono avvicinate al teatro.
L'unico nostro metodo è quello dell’apertura, chi vuole avvicinarsi a questa esperienza semplicemente può venire qui, naturalmente accettando le regole del nostro lavoro.
Se c’è una metodologia nel lavoro, è sempre una non-metodologia. Si parte da un testo ma sempre, anche quando mi e’ capitato di rilavorare su testi del passato, si rielabora in base alle persone con cui si lavora. E' una cosa che faccio sempre, anche quando lavoro fuori dal quartiere, non c’è alcuna differenza perché lavorando si sviluppano delle relazioni, e proprio in funzione dei rapporti con gli individui si scrive il testo. Le ispirazioni dipendono fortemente dal contesto in cui lavori.
Per quanto riguarda le persone in particolare, c'è un nucleo forte che viene dalle origini, formato da 3 o 4 persone. A questo nucleo si è unita altra gente, che da anni lavora con noi. Naturalmente la situazione è in movimento, c’è molta gente che per motivi personali si allontana e poi torna, ma è fondamentale la capacità di accogliere e riaccogliere sia chi va via e poi ritorna, sia le persone nuove.
I progetti per il futuro quali sono?
Il progetto per il futuro, quello per cui abbiamo molto lavorato, è quello di un Teatro Stabile di Quartiere. Questo progetto poco alla volta sta andando avanti ed è probabile che diventi definitivo. Questa è la nostra meta, il punto d’arrivo, il sogno.
ASSASSINA - Le riprese
con Melino Imparato, Fabio Cangialosi, Diana D’Angelo, Egle Mazzamuto, Fabio Palma, Rosario Sammarco, Tobia Vaccaro. Regia Franco Scaldati
scenografia Dario Enea, Massimiliano Carollo
costumi Egle Mazzamuto
Dopo questa breve intervista, Franco Scaldati ci invita ad assistere alle riprese in video di Assassina, uno dei suoi primi testi, scritto nel 1985 e pubblicato nel volume Il teatro del sarto, Ubulibri, Milano 1990. Di questo testo esiste anche una trasposizione in video di Gian Mauro Costa e Diego Bonsangue prodotta nel 1987 da RAI 3 e premiata al Festival Riccione TTV.

Lo spettacolo a cui assistiamo, per di più in questa atmosfera così intima e irreale, (dato che si tratta delle riprese siamo gli unici spettatori) pur con il finale girato prima di cominciare, è stupendo.
Ci sentiamo un po' privilegiati.
La scena (di Dario Enea e Massimiliano Carollo) è una tipica casa povera del sud, in cui si nota il dignitoso quanto malriuscito tentativo di abbellirla con stampe di fiori incorniciate, giusto per coprire le crepe, o macchiare di colore le mura scrostate.

In scena, un uomo e una donna ad un tavolo (in realtà sono entrambi uomini) mangeranno per tutta la durata della pièce un piatto di pasta. Sullo sfondo, una donna con un parlare oracolare e misterioso.
Scopriremo in seguito che sono delle presenze-non presenze, invisibili agli occhi dei due protagonisti.
Lo spettacolo è a tratti esilarante, a tratti malinconico. I due protagonisti, una vecchina e un omino (anch’essi entrambi uomini nella realtà), elencano prima uno e poi l’altra, la ritualità dei gesti e delle azioni prima di andare a dormire. Parleranno dei loro umori corporei, delle loro speranze, della vita quotidiana, senza mai abbandonare una comicità sotterranea e senza nessun ammiccamento vittimista.
La coppia è una sorte di “Signori Martin” ioneschiani al contrario e sottoproletari. Se ne La cantatrice calva due sconosciuti a furia di domande scoprono di essere marito e moglie e di vivere nella stessa casa, i nostri due protagonisti scoprono progressivamente di vivere sì nella stessa casa, ma di non conoscersi affatto. Anzi, più scoprono le coincidenze, più dichiarano la loro estraneità al fatto di avere abitato per anni lo stesso appartamento senza essersi mai incontrati, tanto che inizialmente si danno reciprocamente dello spirdo (spirito, fantasma). Ma ben presto si accorgeranno di non essere affatto spirdi ma fatti di carne e ossa e tutti e due abitanti nell’appartamento al piano terra di via Mosca Volante 52, ex-bagno pubblico, di cui la vecchia si proclama ex-guardiana.

Avendo appurato le loro reciproche esistenze, cominciano la disamina degli oggetti per verificare chi dei due sia il reale abitante della casa.
Alluderanno entrambi agli altri due attori, quasi sempre immobili, come al ritratto dei genitori, ma rimane il dubbio che siano essi stessi da giovani, forse quando erano ancora capaci di riconoscersi.
La vecchia, interpretata da un eccezionale Melino Imparato ci fa a tratti intenerire quando, per esempio, nel definirsi “ragazza”, incappa nell’incredulità dell’omino (il bravissimo Fabio Cangiatosi) che dichiara, non solo di non crederla giovane, ma realmente stupito di non avere neanche capito che si trattasse di una donna: “Picchì, fimmina sii???!!” dice incredulo. La reazione di “lei” è quella di lasciarsi andare ad un pianto disperato.

Entrambi conoscono gli atri abitanti della casa (una mosca, un sorciteddu, e una gallina) e per di più li chiamano con gli stessi nomi: Lucina, Beniamino e Santina.
Assassina è un testo dalla lingua poetica, antica e a tratti cruda, che cattura con la sua straordinaria comicità, la poesia, col suo ritmo incalzante nei modi di dire, negli insulti improbabili (uno per tutti “mosca immiruta”, ossia gobba), nelle sottili sfumature di pronuncia date dagli attori (quando si parla, per esempio del “formaggio sguizzero”).
La verità sull’incomprensibile vicenda biografica dei due, come del resto la verità ultima su qualsiasi esistenza al mondo, non si saprà mai, anche perché nei pressi dell’armadio, (dove verificano la presenza di abiti sia maschili e femminili) l’omino e la vecchina verranno colti da un colpo apoplettico che li stroncherà.
Alla loro morte, chiude lo spettacolo il passaggio di due menestrelli, (Tobia Vaccaro alla chitarra e la bella voce di Egle Mazzamuto, che cura anche i costumi).

IL POZZO DEI PAZZI - Le prove

Qualche giorno dopo andiamo al Teatro Garibaldi ad assistere alle prove de Il pozzo dei pazzi.
Non siamo soli, c'è anche un gruppetto di ragazzi che frequenta il laboratorio, per lo più studenti universitari.
La scena è fatta di lamiere, plastica, persiane rotte, un improbabile letto a castello in tubi di ferro, una tinozza, una sedia, uno sgabello, una rete metallica. Il Teatro Garibaldi ovviamente è un contesto ideale per gli spettacoli di Scaldati, e anche lui sembra abitarlo con molta naturalezza.
La scena a cui si sta lavorando prevede prima un risveglio, poi una sorta di inseguimento, in cui sarà coinvolto anche un uomo dentro uno scatolone di cartone.


Franco dà le indicazioni dei movimenti, con molta precisione:
“Arrivàti ccà… Lu sai che iddu è ‘mbriacu e fingi di essere preoccupato” oppure “Chista cosa è cammurrusa…Un po’ di pazienza…” e ancora “Dario fa due passi indietro, Toni ti nni vai dentro questa gabbia, ad ammucciariti. Tu il cartone lo alzi e cammini un po’ alla cieca…Unn’è Fabio??” “Assicutalo e impreca! Ietta vuci! Entra dalla gabbia e nesci dal tuo nascondiglio, fallu correre n’anticchiedda e poi gira intorno alla scala”. “Ricci parole, inventa cose: figgh'i buttana, stronzo, t'ammazzu....”.
Quello che mi colpisce, a differenza di tanti altri registi che fanno spettacoli in siciliano, che spesso alle orecchie dei siciliani stessi sembrano un po' finti, è che Franco dia le indicazioni in una lingua che è un misto di siciliano e italiano.

Franco Scaldati non ha bisogno di fare cose alla maniera siciliana, il dialetto è la sua lingua, non è teatro finto popolare, fatto da borghesi per borghesi che vogliono illudersi di vedere teatro popolare. In una parola, è autentico. E a livello estetico, e anche emotivo, fa una gran differenza.
Gli attori, specie quelli più giovani tendono a rispondergli in italiano, ma dopo un po’ dall’inizio delle prove, anche loro rispondono in siciliano.
Ad un certo punto si lavora ad un inseguimento, in particolare al gioco della “muffa” a cui Franco fa esplicitamente riferimento, ma è come se gli attori non cogliessero.
Franco allora dice, un po’ malinconico: “Ma a muffa non ci giocavate voiatri?”
Gli attori rispondono di no.
Franco mima per un attimo il divertimento misto ad eccitazione, paura e istinto di sopravvivenza di quando ci si rincorre cercando di evitare di essere toccati da colui che ha la “muffa” e può quindi contagiarti liberandosene: è un bravissimo attore.
Ci sono lunghe pause in cui si mette a pensare, seduto nella sua sedia come come la statua di Le Penseur di Rodin.

Oppure sta immobile in mezzo alla scena, per animarsi improvvisamente, con la soluzione a portata di mano.


Di tanto in tanto si accalora, e anche molto, ma mai contro le persone, mi sembra.
“Se grido non v’impressionate”, specifica.
Ad un tratto, grida sul serio: “AAAAAAAART!!!!!!!”cioè “Alt”.
5 minuti di pausa: ma nessuno si muove, o va a fumare una sigaretta, o si mette a chiacchierare, modifica, insomma, l’atmosfera delle prove.
Franco si alza lentamente dalla sua sedia, tutti parlano a bassa voce, a due a due, un attore rimane immobile sulla scena.

Videoritratti ateatro: Jan Fabre
The Crying Body
di Orsola Sinisi
The Crying Body: il videoritratto ateatro di Jan Fabre (7140 KB, lo si vede con QuickTime, se non l'avete scaricatelo ra.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Galileo in Romania
Progetto Sidereus Nuncius-Cultura 2000
di Anna Maria Monteverdi
Sidereus Nuncius, uno dei testi più noti di Galileo, dà il titolo al progetto ideato da Paolo Pierazzini per il Cinema Teatro Lux di Pisa in collaborazione con Fabbrica Europa e finanziato dal programma europeo Cultura 2000. Si articola in numerose fasi, già cominciate con l’inizio del 2006, con forum internazionali, laboratori tecnoteatrali e musicali ed eventi-spettacolo ispirati al tema galileiano di Arte e Scienza (per dettagli rimandiamo al sito www.sidereusnuncius.net). Il progetto avrà una sua simbolica conclusione con Ipse dixit, evento che avrà luogo nella piazza dei Miracoli il 22 giugno, giorno dell’abiura di Galileo.
Partner europei: Spagna e Romania, quest’ultima come new entry nell’U.E. (dal 2007 sostituirà il Leu con l’euro). Dopo forum e incontri tra Spagna e Pisa, il 31 marzo e il 1° aprile era previsto nella cittadina di Resita, capoluogo di provincia a cento km da Timisoara, un forum di discussione su Arte Scienza (Arta Stintä) organizzato dalla Dacia Film, dall’Università di Bucarest-Dip. Arti Teatrali e Cinematografici e l’Università e dalla Municipalità di Resita.
La delegazione italiana era composta da Paolo Pierazzini (ideatore del progetto), dalla sottoscritta come rappresentante dell’Università di Pisa, dal videomaker Pierpaolo Magnani, dall'organizzatrice Laura Scarpellini e dall’Assessore alla Cultura del Comune di Pisa, Bianca Maria Storchi, da tempo impegnata a promuovere iniziative dedicate all’aggiornamento tecnologico delle strutture cittadine.
All’aeroporto di Timisoara siamo stati accolti da Razvan Gaspar, direttore della Dacia Film. Due ore di automobile tra monti, monasteri ortodossi e comunità rurali prima di arrivare a Resita, città industriale nel sud-est della Romania.

La prima visione è quella delle fabbriche e delle banche italiane che hanno impiantato qua la produzione e le filiali (per esempio la Gas). La città sembra a prima vista ignara e incurante di questo scambio culturale, resistente a ogni forma di turismo e di cooperazione. La conferenza era stata organizzata presso la Sala Multimediale dell’Università di Resita, un tempo polo tecnologico e siderurgico dell’intera Romania, dove si estraevano materie prime minerarie e si fabbricavano armi e vagoni ferroviari. L’arrivo dell’industria metalmeccanica a Resita è coinciso con la prima rivoluzione industriale; con il postcomunismo non c’è stata riconversione e ora la città appare un desolante cimitero di ferrivecchi, letteralmente ricoperto di ruggine, sia pur con un museo delle locomotive di cui la popolazione e la municipalità sono assai orgogliosi.

Ci informano che gli investitori stranieri sono sempre più numerosi: proprio a Resita c’è il progetto di un parco industriale da parte della locale Camera di Commercio.
La giornata di conferenze prevedeva incontri e proiezioni dalle dieci del mattino alle dieci di sera.
Il rettore ci ha illustrato le materie insegnate dentro l’università: oltre a quelle meccaniche e ingegneristiche collegate alla tradizione industriale della città, c’è anche una facoltà di religione (ortodossa). E’ evidente la volontà da parte dell’università di utilizzare questo momento di incontro con partner europei per mostrare le potenzialità progettuali e il livello educativo dell’ateneo in vista di possibili futuri progetti di cooperazione.
La sala multimediale era gremita di studenti e giornalisti, con studiosi provenienti dall’Università di Bucarest e personalità cittadine. Era con noi Marina, traduttrice ventenne al primo anno di università: parlava un ottimo italiano e ci ha spiegato che studiare all’università in Romania è molto duro e che occorre una disciplina ferrea. Come molti suoi coetanei, vorrebbe venire in Europa a specializzarsi e magari a vivere, a Londra o in Italia. Tutti i giovani incontrati ci dicono la stessa cosa: non vogliono rimanere in patria. Un esperto di multimedia ci ha detto di guadagnare 300 euro al mese. Pare sia una cifra sufficiente per vivere in Romania, ma decisamente insufficiente per viaggiare all’estero, per aggiornarsi e per avere la tecnologia più adatta. Chissà come reggeranno l’impatto con l’euro.
Nei nostri interventi abbiamo mostrato materiali documentari di artisti tecnologici, esempi di utilizzo di scienza e tecnologia nell’arte e nello specifico nel teatro.
Paolo Pierazzini ha illustrato gli obiettivi del progetto Sidereus Nuncius e dell’evento finale Ipse dixit. Padrone di casa era Razvan Gaspar, direttore della Dacia Film, ente riconosciuto dal Centro Nazionale di Cinematografia. Fondato nel 1990, produce documentari e cortometraggi sulla Romania, ricostruendo attraverso l’animazione 3D dimore romane e siti archeologici dell’antica Dacia.

Gli interventi riguardavano musica, architettura, arti visive in relazione a tecnologia e scienza; forme e spazi virtuali applicati al teatro e al cinema. Va segnalata la presentazione di cd interattivi da parte dei gruppi rumeni Multiart e Cignus, su monasteri ortodossi e su personalità dell’arte e della storia (da segnalare il lavoro su Julius Verne, in attesa di un distributore europeo...), molto ricchi di informazioni visive e con notevoli possibilità di navigazione interattiva 3D.

Molto interessante l’intervento dell’ingegner Florin Munteanu, docente del Politecnico di Bucarest e presidente del Center for Complex Studies, sulla teoria della complessità e sul sistema noemico.
E’ stato proiettato inoltre il documentario Michelangelo superstar, realizzato in parte in 3D dal professor Stefan Antonescu, direttore dell’Istituto di Scenografia dell’Accademia di Bucarest e realizzatore di sceneggiature cinematografiche per molti documentari e fiction (anche con regia italiana) girati in Romania (per la stessa ragione per cui ci è approdata la Gas...). E’ in trattative per lavorare alla location di un film italiano su Lucrezia Borgia.
La giovane e dinamica direttrice del Teatro di Resita, Malina Petre, ha illustrato la propria idea di tecnica a teatro, fortemente legata alla tradizione dell’avanguardia russa. Di recente Malina ha organizzato un convegno internazionale sulla regia, poi ci ha dovuto lasciare perché concorreva come attrice al Gala Star, un festival di teatro che si svolge a Bacovia.
Le giornate successive sono state dedicate a incontri con galleristi, artisti, direttori di musei locali. Come il museo mineralogico di una cittadina di montagna a un’ora da Resita, gestito da uno studioso che non ha mai voluto abbandonare la zona, che ha raccolto le pietre più caratteristiche della regione, ricca di minerali di ferro, e ha scoperto una pietra dalla originale forma a croce che porta il suo nome. Lasciamo come ricordo una foto di gruppo.

Anche la visita delle aree industriali abbandonate è interessante: acciaierie, fornaci, tutto rigorosamente abbandonato e ancora non riconvertito, spazi che si offrirebbero potenzialmente per un turismo originale oppure come location per eventi culturali di impatto. Ma la città non vuole puntare a un’economica turistica: il nostro suggerimento per progetti internazionali di utilizzo culturale di queste aree ha colto di sorpresa il giovanissimo vicesindaco, appartenente a un partito conservatore.
Al Teatro Petculescu di Resita era in scena Nabadaie Iubirii di Jírí Menzel, nella pura tradizione popolare della commedia dell’arte (con Arlecchino, Colombina e Zanni) secondo la tecnica rivisitata dai russi degli anni Venti. Vachtangov in Romania? Uno spettacolo allegro, colorato, movimentato, insomma divertente, che ha raccolto il consenso del pubblico locale che affollava la piccola sala cittadina.


Abbiamo chiesto quale drammaturgia sia stata sviluppata dopo la Rivoluzione del 1989, dopo la stagione della censura teatrale della dittatura di Ceausescu, che ha spinto molti artisti all’estero: basti pensare ad Andrei Serban (tornato poi in patria a seguito dell’appello del Ministro della Cultura). Il professor Stefanescu ci ha parlato di un drammaturgo rumeno assai noto all’estero, in Francia soprattutto, che era anche in programma nella stagione teatrale di Resita: Matei Visniec, il cui Richard al III-lea nu se mai face (con un sottotitolo inequivocabile: Scene dalla vita di Mejerchol’d) sulla censura e sul totalitarismo.

Il testo è stato tradotto in francese e rappresentato con successo al Festival di Graines des Mots in Francia a febbraio; altri testi di Visniec sono stati allestiti anche in Italia, al Piccolo di Milano e al Mittelfest. La regia era di Michael Vivier, le prove sono avvenute per cinque settimane con evidenti difficoltà legate alla lingua, proprio nel piccolo teatro di Resita che coproduceva lo spettacolo. Dal programma di sala trovo altri nomi del teatro contemporaneo rumeno: Tompa Gabor, Alexandru Tocilescu, Victor Ion Frunza, Dumitru Solomon. Per approfondire, c’è il Festival di Drammaturgia contemporanea di Brosov (12-19 novembre).
Per approfondimenti, esiste onlinegallery, un sito web molto ricco di informazioni a cui rimando: , un data base su artisti rumeni, registi, attori, compagnie teatrali e alcune immagini significative delle loro produzioni. Teatrul Act, Teatrul Odeon, Teatrul Mic sono alcune delle compagnia di ricerca più seguite.
Il partenariato prevede la presenza del gruppo rumeno della Dacia Film all’interno dell’evento finale di giugno Ipse Dixit. L’appuntamento con Razvan e soci è in pazza dei Miracoli a giugno.
Una partitura per Edipo: Voce sola, 7013 parole in 71 minuti
Al tavolino di un bar con Cristian Ceresoli e Antonio Pizzicato
di Franco D’Ippolito
Dal 27 aprile al 14 maggio al Salone del CRT in via Dini è in programmazione uno spettacolo che rappresenta uno dei momenti più significativi e soprattutto coerenti di una ricerca in territori nuovi del teatro, fra parola e canto, fra suono e senso. Voce sola di Cristian Ceresoli è una partitura letteraria di un’opera cantata dal vivo da Antonio Pizzicato per 7013 parole in 71 minuti.
Questa conversazione con Cristian ed Antonio è il frutto di un pomeriggio tiepido, a un tavolino all’aperto di un bar in una città del Sud.
Antonio Pizzicato e Cristian Ceresoli, cosa vi ha fatto incontrare?
C.C. Io e Antonio siamo due individui con radicali e sostanziali diversità, artistiche e personali….. spesso in disaccordo, usando parole che tra noi si contraddicono.
A.P. L’ossessione di Edipo è stata il titolo della mia vita….
C.C. Ma che c’entra?
A.P. Negli anni della Paolo Grassi, nel mio saggio finale del corso di regia, fino a quando nel gennaio 2004 ho proposto a Cristian di collaborare con me, perché avevo deciso di raccontare tutta intera quella storia. Mi ero innamorato da poco della sua scrittura grazie a certi racconti in forma di lettera che ancora custodisco e che temo lui non avrà mai il coraggio di pubblicare, nonostante i miei continui incitamenti a farlo.
C.C. Lui spesso travisa i fatti a suo piacimento, usando termini che io non sopporto….
C.C. L’incontro con Antonio avviene una trentina di giorni dopo la prima volta che nella vita mi sia capitato di scrivere. Mi capita ancora rarissimamente di scrivere, dove per “scrivere” intendo il momento in cui si arriva a catturare e fissare le parole su un foglio. Eppure scrivere, scrivo continuamente: cammino o sono sulla tazza del cesso, o sto per addormentarmi, e le idee, gli accadimenti, e talvolta perfino le sciocchezze nel mio corpo si trasformano in … pezzi letterari (??). Sono queste scritture il frutto di attenzione continua e inconsapevole. Non ragionata. Qualcosa sgorga, e sgorga sotto forma di matassa ingarbugliata che se resiste al rileggerla e rileggerla vuol dire che il contagio è in atto. Per quel che mi riguarda, non c’è premeditazione, non c’è progetto. Procedo piuttosto per rivelazione.
Anche per Voce sola?
C.C. Sì, credo proprio di sì. Non ricordo nemmeno più perché a un certo punto ci sedemmo, in una casa della periferia milanese, con nella stanza affianco un cane che sbavava puzzando i denti marci, due piani sopra a una bella fabbrichetta, con pezzi di Edipo tra le mani, e la voglia, o l’istinto, di metterci insieme.
A.P. All’epoca credo che nessuno dei due avesse la minima idea di che cosa avremmo potuto fare o addirittura se la nostra collaborazione avrebbe potuto dare qualche frutto.
C.C. Voce sola è come se fosse fatta di cento opere in una, perché come in un gioco sciolto, fin dall’inizio, e ancora oggi, e speriamo domani, abbiamo tentato numerose e diverse vie e sperimentazioni. Quasi tutto è nato per curiosità, per scommessa, e con pochissima cognizione iniziale degli elementi. Poi, però, quando qualcosa ci incantava, abbiamo insistito. Ed è stato necessario studiare, e studiare, e studiare, e studiare, studiare e tentare, ritentare, ritentare e studiare... L’inizio è stato spesso, come dire, un inizio da pizzaioli.
Con tutto il rispetto per i pizzaioli, che cosa possono avere mai a che fare con la ricerca di Voce sola?
C.C. Voglio prima di tutto chiarire che per me e Antonio la pizza è sacra, non “una” pizza, ma “la” pizza di Michele a Napoli: quando la mangi capisci che tutte le altre erano solo dei surrogati. Stavamo però parlando dell’inizio del lavoro che ci ha portati a Voce Sola. Alla fine di un’altra delle nostre riunioni….
A.P. Quante ne abbiamo fatte?
C.C. Quattrocento? Cinquecento? Comunque, dopo l’ennesima riunione, camminando per Milano incontrammo una bella creatura, giovane e con certi seni… una beneficenza di bellezza, insomma. Visto che la ragazza temporeggiava all’altro capo del marciapiede, decidemmo (senza farlo) di attraversare per proporci… in quella arrivò un bel ragazzo, alto, forte, sicuro di sé, e si prese la donzella tra le braccia facendocela scomparire. Io e Antonio ci guardammo, io indossavo la mia solita maglietta a maniche corte bianca, e ci sentimmo come dei pizzaioli, che mai e poi mai una così si sarebbe degnata… Da allora, e sempre, pure verso il nostro lavoro sulla creazione di Voce Sola, continuiamo a sentirci un po’ pizzaioli, sì, ma con il mito di Michele di Napoli. Se qualcosa va presentata ed offerta, che ne valga davvero la pena!
La ricerca, intesa come lavoro sistematico volto ad accrescere le cognizioni di cui si dispone e le capacità di utilizzarle, è ciò che più mi ha colpito nel vostro spettacolo.
A.P. Voce sola nasce per me come una sorpresa, in un momento in cui peraltro stavo cercando tutt’altra cosa. Ero rimasto solo; e per un regista teatrale non è certamente la condizione di lavoro migliore. Era come se mi trovassi alla fine della strada: prego, tornare indietro! E più di una volta, allora, mi sono chiesto: ma allora qual’è il mio talento? … se Dio vuole che io abbia un talento! Quando si crede di aver perso tutto, quando non c’è più binario davanti e non c’è certezza su cosa sia bene o male fare, resta come alimento soltanto ciò a cui con ardore ci si è dedicati. Ecco che così in quei giorni il mio alimento è stato il Canto e tutto ciò che avevo praticato in sette anni di seminari di lavoro con la voce.
…“io in scena” era prima di tutto lo scoglio da superare. Non avevo esperienza d’attore, se non vogliamo considerare tale i tre anni di liceo a Napoli e quelle volte che ho partecipato a spettacoli in cui comunque dovevo solo cantare e far cantare. Per questa ragione occorreva cercare un’altra qualità di presenza che tenesse conto di questo mio limite e che traesse forza da ciò che nel tempo avevo imparato: il Canto e il Racconto. Sono certo che non sarò mai in grado di raccontare come mia nonna. Per meglio dire: sono certo che non riuscirò mai a far provare al racconto le stesse scosse, le sospensioni e i sussulti che lei era capace di farmi provare. Ma è al tempo che si produce nell’immaginazione di chi ascolta che sono terribilmente legato. Ho iniziato a cantare che avevo quattro anni e da allora non ho più smesso.
E la musica, il canto ha fatto le veci della nonna?
A.P. Raccontare con i suoni; laddove i suoni sono quelli possibili al multiforme strumento della voce. Così nel 2002 ho deciso di fondere insieme, prima nel progetto didattico che portavo avanti poi in quello della regia, il lavoro sul canto e quello sulla narrazione, ampliando il campo di ricerca e “spaziare” dal racconto attraverso la vocalità del suono puro e della melodia all’interpretazione del significato e del suono del linguaggio. Cristian insisteva sul fatto che avrebbe voluto che io, in scena, avessi soprattutto cantato le sue parole.
C.C. E Antonio, non so perché, mi disse che sarebbe stato utile avere una scrittura metrica. Ma io non capivo a cosa sarebbe servito contenere tutto quello che mi veniva da scrivere dentro ad una struttura così matematica, precisa e limitata, come voleva lui, utilizzando metriche dispari… undici, sette….
A.P. Io non potevo inventarmi una cosa che non avevo mai fatto, cantare delle frasi come se nulla fosse…. Lui era convinto che avrei potuto solo grazie alla mia voce prendere le sue parole e inventarci una melodia.
C.C. Io pensavo che i miei pezzi fossero musicali, molto musicali, erano così pieni di assonanze, di rimandi, altro che la metrica che, peraltro, non conoscevo. A più di un anno da quelle prime riunioni, Voce sola si compone di numerosi settenari, rime alternate, alessandrini, martelliani, e terzine di endecasillabi incatenati, così come di alcune metriche nuove e originali create su misura delle nostre esigenze di canto o scrittura.
Come avete lavorato a raccordare parola e suono?
A.P. Come nella notazione musicale dove si specificano i toni, gli andamenti ritmici e, talvolta, sommariamente, gli andamenti espressivi, così nella scrittura sono indicati solo i fonemi e a grandi linee il ritmo complessivo della scrittura. Così tutto quello che c’è nel mezzo e lega un fonema all’altro (immagini, intenzioni, stati d’animo) deve essere scoperto, ricercato o persino inventato. Questo percorso, che è per me percorso di studio, evoluzione e approfondimento, si chiama il Tempo Sospeso, ai confini tra narrazione e canto, quella zona in cui le due discipline non si distinguono nettamente e ognuna sfuma i propri confini nell’altra. In questa sottile, e vasta tuttavia, striscia di terra, il suono è altamente narrativo e la parola strumento musicale: si tratta si provare a saggiarne le proprietà fonetiche come fossero uno spartito ritmico-melodico.
C.C. Dal punto di vista linguistico sono stati utilizzati il greco antico, il latino, il bergamasco, il francese, lo spagnolo e il napoletano, con le rime e con la tecnica musicale del contrappunto presa come modello per la scrittura del dramma. Abbiamo attinto alle suggestioni musicali arabe o partenopee, con le variazioni vocali polifoniche, etniche o gregoriane, con l’interpretazione di un intero coro da parte di una voce sola.
A.P. Dalla scrittura, che Cristian stava affinando in direzione della musica, si scatenavano i due universi del senso e del suono…
…che sono diventati l’universo del racconto della storia di Edipo.
A.P. Compito di chi la dice la parola, di chi la interpreta, di chi la canta è di non scivolare mai definitivamente nell’uno o nell’altro, ma di oscillare continuamente tra essi con un moto tanto più prevedibile quanto seducente. A mio avviso, oggi la strada percorribile – a cui abbiamo cercato di avvicinarci sempre più ogni volta che abbiamo fatto Voce sola davanti ad un pubblico – per rendere possibile quel desiderio innato di abbandono al piacere dell’immaginazione, è soltanto questa.
C.C. Ci abbiamo messo una dedizione maniacale e un rigore svizzero, o tedesco, come preferisci…. Abbiamo inteso tutto il lavoro con un forte senso di artigianalità, per cui nessun dettaglio veniva mai lasciato al caso. Mentre l’essenza dell’opera, quella sì, probabilmente, è assolutamente figlia del caso.
A.P. Nelle esperienze di laboratorio accade sempre che il coro impari a far coesistere narrazione e canto: il suono del racconto è in relazione con la musica del coro e gli ambienti sonori agiscono come elemento che schiude la comprensione del significato o dei significati del testo. Ma c’è sempre “un” corifeo che si incarica della narrazione ed intorno a lui “i” coreuti che sostengono il canto. Come potevo fare a non disperdere il tesoro contenuto in questa preziosa formula, ora che sarei stato da solo sulla scena? E come giungere a dei canti che non fossero solo un sottofondo o uno sfondo sul quale proiettare la parola? L’idea alla quale mi sono affidato fu quella di estrarre dalla parola stessa il canto che poi di nuovo alla parola si sarebbe dovuto naturalmente unire. All’inizio del lavoro con Cristian ti lascio immaginare in quale selva di strade avremmo potuto perderci in ogni momento.
Dal trovarsi “alla fine della strada” al rischio di perdersi fra centinaia di possibilità di strade.
A.P. Appunto. Ma al primo sentiero imboccato la fortuna ci fu benevola. La primitiva traccia di scrittura generò un canto, non sappiamo come successe, soltanto che fu come ritrovare in quella prima pagina (che a prima vista parrebbe soltanto una confusa lista di parole) la forza delle parole dette per la prima volta.
arriva
dispera
corre graffia
strappa impreca
un giorno un uomo
sua madre
assassino il momento
e di quando
la lama
il parto
colpisce trapassa
infilza gli occhi
del pazzo
del padre
il cuore
Avevamo forse trovato il cuore ancora pulsante del lavoro, il ritmo, che ci ha condotto alle ragioni della scrittura in metrica. E’ il ritmo contenuto in una sequenza di parole che dà origine al canto.
C.C. Nel nostro processo di ricerca “definire” è proprio uno dei termini più stonati. La sostanza, se vi è sostanza, è solo là, in quei settantuno minuti che si ascoltano dal vivo.
A.P. Il ritmo in musica crea dei principi e delle conclusioni, all’interno di cui sono possibili variazioni, le prime possibili appaiono sotto forma di melodia. Una volta riconosciuto il ritmo che sostiene la scrittura occorre cantarlo, suonarlo marcatamente quasi fosse una partitura per strumenti a percussione. E’ a quel punto che la melodia, evocata dai battiti ritmati delle consonanti, comincia a poco a poco ad apparire. La melodia scaturisce dal ritmo perché sono le sillabe stesse –l’incontro di quelle particolari vocali e consonanti- scandite ritmicamente a generare il primo embrione di un andamento ritmico-melodico. Un procedimento che da un suono monodico timbrato evolve fino a diventare di molte voci un canto.
Come andrà avanti la vostra ricerca?
C.C. Ora siamo alle prese con i primi confronti, o germi, dell’opera nuova che andremo a comporre. Di questa, per il momento, possiamo confidarti soltanto il titolo: Madrigale. In cui riciclare una piccola lirica che io e Antonio avevamo composto, scritto, musicato e cantato fin dall’inizio del processo creativo di Voce Sola e che, manco a dirlo, per colpa di Antonio, è stata poi eliminata. Il resto sono dubbi, intuizioni, desideri e confusioni gravide.
Le recensioni di ateatro: Niente più niente al mondo
Regia di Paolo Pierazzini
di Sara Ficocelli
Quando l’ossessione per ciò che non si ha prende il posto dell’amore, quando la frustrazione soffoca la voglia di vivere. Quando non ci si sente più persone ma solo poveri consumatori destinati ad arrangiarsi, accontentarsi e sognare sogni morti. Quando nella mente umana accade tutto questo, tutto può accadere. Anche di uccidere la propria figlia sferrandole una decina di coltellate. “Niente più niente al mondo” racconta, in meno di un’ora, l’universo di questa follia. Massimo Carlotto ha scritto come sempre un testo forte, pensato apposta per il teatro e portato in scena giovedì 9 febbraio al Cinemateatro Lux di Pisa.

Francesca Censi interpreta una madre senza più anima né cuore cercando di darle un volto, una dignità. La regia di Paolo Pierazzini ricrea un’atmosfera claustrofobica e scarna, gelida e straziante come ogni frase del monologo della protagonista. Una sedia, una donna, le sue parole. Dietro di lei, le immagini velocizzate e al rallentatore della bocca e delle mani, muti primi piani che parlano una lingua familiare, quella della solitudine. Carlotto, che ha vissuto il carcere, affonda volentieri le mani nelle miserie umane, lasciando da parte vergogna e stereotipi. I suoi libri noir raccontano storie di “criminalità sostenibile” e violenza inaccettabile, storie dell’Italia moderna, reperibili sui giornali ogni giorno, e per questo ancor più raccapriccianti. “Niente più niente al mondo” racconta quello che tanti hanno già letto sui quotidiani e commentato guardando la Tv, magari davanti ad un fumante piatto di pasta: l’improvviso guizzo di follia di una donna che, senza una ragione apparente, uccide la figlia di 20 anni. Ma le mani di Carlotto non sono quelle frettolose di un giornalista e scavano, scavano, fino a trovare barattoli di salsa comprati al discount e pile di riviste di pettegolezzi, bottiglie di Vermut e vestiti scontati. Di questo è fatto il piccolo mondo della protagonista, furiosa con se stessa, col marito, con la figlia, con la vita stessa. Furiosa e triste, stanca, drasticamente sola. La sua lucida follia le regala un’anima mostruosa ed un bel po’ di sangue freddo: uccidere la figlia è quasi come uccidere se stessa, risparmiando alla sua “bambina” lo squallore della quotidianità.
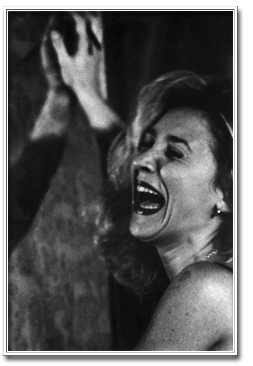
Non ci sono giustificazioni né prese di posizione, i testi di Carlotto sono troppo attenti alla vita per cadere in trappole del genere. Lo spettatore riceve però un messaggio diretto, che fa gelare il sangue: il confine tra ciò che abbiamo e ciò che siamo è una condanna terrificante, cui è molto difficile sottrarsi. Le luci di Lulzim Progri e le immagini di Ugo Benconcini regalano alla scena preziosi suggerimenti di lettura e la canzone di Gino Paoli, che dà il titolo allo spettacolo, riecheggia tra le labbra della protagonista come una ninna nanna di morte. Il cielo in una stanza è una ricchezza per pochi. Una ricchezza dell’anima che a volte manca, coperta dall’intonaco impietoso del soffitto di casa, bianco e cieco. Niente più niente al mondo potrà trasformarlo in paradiso.
Niente più niente al mondo
Regia di Paolo Pierazzini
Scritto da Massimo Carlotto
Pisa, CinemaTeatroLux, 9 febbraio
Speciale elezioni 2006: la posizione della Lega Nord Padania sullo spettacolo
Risposte ai quesiti di "Hystrio"-ateatro da parte dell'On. Davide Caparini e di Roberto de Anna
di Mimma Gallina in collaborazione con Anna Chiara Altieri
Quale è la vostra valutazione sulla politica per lo spettacolo di questi anni di governo? In sostanza condividete l'operato Urbani/Buttiglione o c'è qualche distinguo?
In questi anni ci sono stati alcuni timidi tentativi di rendere meno schierato il mondo dello spettacolo ma troppi anni di conformismo culturale, nato da una divisione schematica degli interessi del paese, che ha affidato alla sinistra il compito “divino” di monopolizzare la ”cultura” e allo stesso tempo di rendere scorretta qualunque altra opzione, ha reso e rende ancora problematico ogni vero progetto di liberalizzazione.
I nodi irrisolti sono: il rapporto tra finanziamento pubblico e la legittimità a fruirne dei soggetti attualmente finanziati; l’immobilismo culturale prodotto dal cosiddetto finanziamento ”storico”; la funzione dei teatri stabili che non sono più fucina di idee ma puro protezionismo per qualche presunto grande della regia che usa spudoratamente danaro pubblico per i propri interessi privati.
La difficile legittimazione dei cosiddetti “Stabili Privati”, nati quasi tutti come cooperative negli anni settanta con un livello artistico e progettuale spesso scandalosamente dilettantistico, che si è mantenuta a scapito di una seria creatività progettuale e di un ricambio vero e non drogato delle forze culturali alternative ed emergenti.
Tutte queste considerazioni nascono dalla verifica che lo spettacolo si muove in un ambito ipergarantito, che rende impossibile una vera pluralità di offerte artistiche.
Naturalmente una modifica radicale non può prescindere da una nuova strategia di sostegno che deve rendere legittimo ed appetibile il finanziamento privato.
La soluzione è semplice e consiste nel consentire al mondo del privato di entrare nel processo di realizzazione artistica con risorse mirate a condizione che chi le mette a disposizione ne abbia un vantaggio ad esempio fiscale.
Crediamo che lo stesso processo di regionalizzazione potrebbe, se ben governato, favorire un vero risveglio delle attività culturali facendo emergere le specificità delle diverse culture finalmente libere di esprimersi liberate da apparentamenti politici.
Un processo che noi speriamo diventi autenticamente irreversibile per tutto il mondo della cultura e dell’arte a cominciare dalla revisione radicale del ruolo delle Soprintendenze che oggi dettano con arroganza le regole di un protezionismo indifferente alle realtà ed alla storia di qualunque parte del Paese, un esempio di colonialismo culturale inaccettabile perché del tutto indifferente alla storia-tradizione dei diversi territori della repubblica.
Quale è la vostra posizione sui tagli recenti al FUS?
Quando la situazione è seriamente compromessa sul piano delle risorse generali non c’è e non deve esserci aspetto della vita pubblica che può essere privilegiato; è altrettanto vero che la logica distributiva del FUS va radicalmente cambiata, vanno identificate funzioni e soggetti nuovi, partendo dalla valorizzazione della creatività e della formazione artistica lasciando alle realtà consolidate la possibilità di andare a cercarsi legalmente contributi in altri ambiti come quello privato. Per intenderci nessuno deve più avere la prerogativa di “essere“ ricerca e sperimentazione per sempre.
Potete interpretare il braccio di ferro/ l'opposizione (politicamente trasversale secondo me) che ha caratterizzato in questi anni l'applicazione della riforma costituzionale (cioè perchè ci sono voluti cinque anni per arrivare al principio della "legislazione concorrente" e poi per non riuscire neppure ad attuarlo)?
In riferimento alla riforma del 2001 votata dal centrosinistra avevamo paventato il rischio, confermato dagli eventi, di una difficile - e in alcuni casi impossibile - applicazione del principio di legislazione concorrente. Questo principalmente per quattro motivi:
1) nel modello del centrosinistra le Regioni non sono assurte a pari dignità nei confronti dello Stato;
2) l’arbitro, cioè la Corte costituzionale, è rimasta immutata con l’esclusione della rappresentanza di tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana;
3) non è stata prevista una camera di compensazione, nella riforma del centrodestra il Senato delle Regioni, con facoltà di intervenire nelle materie concorrenti;
4) deficit culturale federalista ed autonomista nelle istituzioni. La riforma della costituzione in senso federale del 2006, che saremo chiamati a confermare nel prossimo referendum, è vista, da quelle forze politiche che fanno della concentrazione del potere e dell’attuale modello distributivo delle risorse, come una iattura da evitare il più possibile o da ridurre ai minimi termini.
In questo senso l’ostilità alla creazione di uno stato federale è comune anche trasversalmente alle forze politiche di entrambe gli schieramenti e quindi finora hanno avuto buon gioco le strategie dilatorie ne hanno reso il percorso difficilissimo.
Un errore perché il decentramento culturale e fiscale, quando fossero attuati, sarebbero paradossalmente l’unico collante possibile per un Paese che non riesce ad essere unitario praticamente in nulla, meno che mai se non ridisegna il modello della distribuzione delle risorse.
Ma se nel centro destra si tratta di mettere a confronto tesi diverse ma alla fine mediabili in una ottica di libertà e confronto, il centrosinistra rischia di perdere la funzione guida culturale su cui ha costruito il proprio potere mediatico.
Cosa pensate di ARCUS? E dell'ETI? La Lega Nord - che ricopre incarichi importanti per la gestione della cultura in Lombardia, in Veneto e per il passato in Friuli e in Piemonte (forse mi dimentico qualcosa) - intende chiedere spazi a livello di governo per il futuro? In caso di vittoria del centro destra ovviamente.
Arcus è, forse, un progetto dal futuro interessante, è troppo presto però per esprimere giudizi definitivi. Resta però inteso che nessun vero cambiamento può evitare di passare da una gestione dirigistica e centralizzata, anche se ben gestita, ad una territorialmente responsabile, nel quale si offrano possibilità di intervento a chiunque.
Il ruolo dell’ETI è assimilabile a quello dei Teatri Stabili, nessuno sente più la necessità di organismi dirigistici trasversali a tutto il territorio.
La Lega Nord Padania agirà con determinazione per realizzare anche sul piano dello spettacolo e della cultura più in generale quella rivoluzione culturale rappresentata del federalismo e dalla revisione del sistema di finanziamento alle attività di spettacolo, ridimensionando/eliminando le rendite di posizione.
Un'attrice "troppo": Adelaide Ristori
Che hanno detto al Convegno nazionale di Cividale del Friuli
di Angela Felice
Prismatiche, in chiaroscuro o perfino a contrasto le tante facce di Adelaide Ristori emerse dal Convegno nazionale del 25 marzo scorso che la Città di Cividale, confortata dal sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Udine, oltre che dal patrocinio dell’Eti e dell’Università friulana, ha voluto dedicare all’illustre attrice concittadina, che vi nacque -sostanzialmente per caso - nel 1822 e poi, ma ormai da gloria nazionale della scena e della patria unita, vi fece ritorno solo nel 1879, a un passo dal ritiro definitivo dalle scene. Una figura non molto indagata dagli studi, anzi pregiudizialmente in odore di “antipatia”, come ha ricordato in apertura il coordinatore dei lavori, Claudio Meldolesi del Dams di Bologna, per quel che di legittimismo e di conformismo che ne consacrarono la prestigiosa ascesa sociale e professionale.
Troppo marchesa, come divenne realmente, una volta sposa di Giuliano Capranica del Grillo. Troppo icona di “regine” fastose, protagoniste da grandeur in un repertorio facilmente esportabile da gran tour internazionali, come quella Lady Macbeth versione british di cui Marisa Sestito dell’Ateneo udinese ha descritto l’assoluto protagonismo, alla faccia della filologia testuale. Troppo cattolica, come almeno appariva agli occhi nordici del critico danese Herman Bang (rievocato da Franco Perrelli del Dams di Torino), che pure ne subì il magnetismo d’attrice, ma non fu esente dal cogliere anche la curva costante di espiazione catartica e consolatoria cui le eroine viziose della Ristori - adultere, matricide, incestuose o assassine - erano piegate. Troppo capocomica, attenta alla managerialità imprenditoriale e a ogni dettaglio, scene e costumi in primis (descritti da Maria Ida Biggi dell’Università di Venezia), e naturalmente alle ragioni del botteghino.Troppo amica delle teste coronate di mezzo mondo, non ultima la regina Margherita, di cui la Ristori, da pensionata di lusso, fu dama di corte, lei che in passato (lo ha ricordato Teresa Viziano) era stata in familiarità con Cavour, Garibaldi e gli esuli parigini della Repubblica Romana.
Un’attrice fastosa e una gran dama dei quartieri alti, insomma, ben lontana da altre colleghe diversamente “simpatiche”, perché anarchiche e congeniali a più moderne sperimentazioni ribelli: la Duse, ad esempio, o Giacinta Pezzana, indicata da Laura Mariani dell’Università di Cassino a modello di una naturalezza scenica di anticonformismo, alimentato, nel suo caso, dalla lezione “politica “di Gustavo Modena, dalla fede mazziniana e, sotto sotto, da un preannuncio di umori femministi.
Eppure, la chiave della carriera della Ristori e del suo trionfo sta proprio in quel suo necessario de-bordare, con inflessibile strategia di equilibrismo tra guitteria di partenza e normalizzazione d’arrivo, un piede di qua e uno di là – ha spiegato Paolo Puppa, in una perlustrazione della sociologia del mestiere - tra miseria iniziale d’attrice, equivocata per secoli in cortigiana dai dubbiosi costumi, e splendore finale di legittimazione e di risarcimento. Così nella Ristori – ha concluso Meldolesi - si può individuare una figura centrale di fondazione del teatro italiano, perfino di quello stabile, sullo sfondo di quel “secolo dei secoli” che è l’Ottocento, spazio temporale di incontro-scontro tra vecchio e nuovo. La Ristori, alla fin fine, fu questo e quello: nobilitò sul piano “accademico” il lavoro dell’attore e la scena del personaggio, ma con il limite di volersene impadronire e vampirizzarlo. Diversa invece sarebbe stata la prospettiva degli interpreti del futuro, per i quali si tratterà semmai di battagliare con il personaggio, mobilitandovi, almeno da Stanislavskij, anche il vissuto preconscio e il potenziale di una più incrinata sensibilità
La Ristori fu invece “una statua che parla”. L’immagine, lanciata da Meldolesi a Leit-motiv del Convegno, vale dunque a stringere in emblema di sintesi la dinamica di una vitale contraddittorietà d’attrice: tra ingessatura monumentale da un lato e, dall’altro, innesto di una passionalità che riesce a sgelare e vivificare il “prontuario” della partitura convenzionale di posture e gesti di scena. E, ancora, è una visione efficace a fissare una strategia attoriale vincente, borderline tra passato e futuro, entro il laboratorio di tutta una civiltà teatrale, sui cui aspetti fondativi, e non solo retoricamente artificiosi, resta ancora molto da esplorare. Vi ha gettato intanto una luce il Convegno cividalese, i cui risultati saranno coronati a breve anche dalla pubblicazione degli Atti.
In mostra la danza da Duncan a Bausch
A Milano dal 17 al 22 luglio
di Ufficio Stampa
Una mostra renderà omaggio a Isadora Duncan e Pina Bausch, icone della Modern Dance e della Danza Contemporanea.
Presso la Galleria del Credito Valtellinese/ Refettorio delle Stelline,
Corso Magenta 59 - Milano
in esposizione documenti, fotografie, opere d’arte che illustrano come le due danzatrici, con diversi percorsi artistici, abbiano liberato il corpo e la danza nel ventesimo secolo.
“La più alta intelligenza nel corpo più libero: sta arrivando la danzatrice del futuro”
I. Duncan
“Con la danza potevo esprimere tutte quelle emozioni che non sapevo dire a parole”
P. Bausch
Dal 17 maggio al 22 luglio presso la Galleria del Credito Valtellinese, una mostra dal titolo “ISADORA DUNCAN, PINA BAUSCH. DANZA DELL’ANIMA, LIBERAZIONE DEL CORPO” si propone di raccontare in forma divulgativa e rigorosa, con il supporto di documenti visivi rari e di forte impatto emotivo, il ricco lascito di esperienze, idee, insegnamenti che Isadora Duncan (San Francisco 1877- Nizza 1927) e Pina Bausch (Solingen 1940) hanno seminato durante la loro carriera, sottolineandone le diverse fonti ispiratrici e la tensione utopica che fa di loro un simbolo e un modello per le giovani generazioni.
La mostra è promossa dalla Provincia Milano - Settore beni culturali, arti visive e musei, organizzata dall’Associazione Culturale Dioniso, curata da Pier Giorgio Carizzoni, con la collaborazione del Centre Culturel Français di Milano, del Goethe- Institut Mailand, del Centro Culturale Svizzero di Milano - ISR, con il patrocinio del Forum Austriaco di Cultura di Milano e AICEM.
Opere provenienti da: Bibliothèque Nationale de France, Tanzarchiv di Colonia, Musée Rodin di Parigi, Musée d’Art moderne et contemporaine di Strasburgo, Musée Bourdelle di Parigi, Museo Provinciale S. Castromediano di Lecce, Museo Teatrale alla Scala, Biblioteca del Conservatorio Giuseppe Verdi, Kunsthaus di Zurigo, Civico Archivio Fotografico del Castello Sforzesco, Museo Esenin di Mosca.
L’esposizione rievoca il percorso ideale attraverso il quale le due grandi innovatrici, ciascuna con le proprie modalità espressive, elaborano e sedimentano un processo di enorme portata che ha scardinato i pilastri della tradizione del balletto classico e ha dischiuso nuovi, fecondi orizzonti, al teatro, al costume, al superamento del dualismo anima-corpo.
Danza come specchio dell’anima, poesia del gesto, trasparenza delle emozioni: Isadora Duncan e Pina Bausch hanno ispirato e guidato una audace rivoluzione nella libera espressività e nella creazione di un nuovo linguaggio del corpo.

Isadora Duncan al Teatro di Dioniso di Atene nel 1903 (foto di Raymond Duncan).
Agli albori del XX secolo la solitaria pioniera californiana Isadora, ha coraggiosamente aperto in Europa la strada alla danza libera sfidando ogni convenzione e propugnando una “umanità danzante” dedita alla armonica coltivazione della bellezza e della semplicità.
Nell’ultimo scorcio del Novecento Pina e il suo prodigioso Wuppertal Tanztheater, hanno saputo visualizzare sul palcoscenico il “linguaggio della vita”, ovvero rappresentare magistralmente l’essenza di sentimenti e stati d’animo che scandiscono la nostra esistenza quotidiana.
Il percorso espositivo si apre su una sezione comune dedicata ai pionieri della Modern Dance, teorici e coreografi come François Delsarte, Emile-Jacques Dalcroze, Rudolph Von Laban e l’esperienza di Monte Verità.
La seconda sezione è dedicata ad Isadora Duncan e comprende un ricco patrimonio fotografico e documentario teso ad illustrare le tappe fondamentali della sua variegata biografia: Grecia, Parigi, Russia, Germania.
Di particolare rilevanza, gli splendidi disegni ed acquerelli di Auguste Rodin, Grandjuan, André Dunoyer de Segonzac, Jean Lafitte, José Clara e Valentine Gross Hugo ispirati alla danza e ai movimenti di un corpo finalmente libero.

Frühlingsopfer di Pina Bausch (foto di Ulli Weiss).
La terza sezione è dedicata al teatro danza di Pina Bausch visto attraverso l’occhio privilegiato di due grandi fotografi, Ulli Weiss e Francesco Carbone, che ne hanno seguito con costanza l’evoluzione coreografica ed estetica sin dagli esordi degli anni Settanta.

Julie Anne Stanzak in Nelken di Pina Bausch (foto di Ulli Weiss).
Durata: dal 17 maggio al 22 luglio
Biglietti: intero 6 euro, ridotto 5 euro
riduzioni per studenti e giovani fino a 18 anni, anziani (ultra 60enni)
Orari : dalle 10.30 alle 19.30 da lunedi a sabato (chiuso domenica e festivi)
ufficio informazioni: +3902.7200.4100 - Mail : assdioniso@tiscali.it
ISADORA DUNCAN
Personalità carismatica e ribelle ad ogni convenzione, ha incarnato la meravigliosa utopia di una umanità danzante svincolata dai condizionamenti sociali e fedele ai ritmi pulsanti della natura:
Al fine di distinguersi dalle ballerine classiche e caratterizzarsi come un’artista che interpreta la musica, ebbe a dire di sé: “Che errore chiamarmi danzatrice…Io sono un polo magnetico che concentra e traduce le emozioni della musica”.
Isadora divenne una radiosa protagonista della riscoperta del corpo: le principali correnti culturali europee e nordamericane del primo quindicennio del Novecento ricevettero un forte influsso da lei e da tutto il movimento che celebrava il corpo “espressivo”, in antitesi alle costrizioni e convenzioni del secolo precedente
Grazie ai successi ottenuti nei principali teatri di Francia - Germania - Inghilterra - Russia e attraverso i suoi scritti e discorsi, Isadora Duncan restituì alla danza il rango di arte al pari delle altre, anzi la elevò a fonte ispiratrice per pittori, scultori, musicisti, i quali, ritraendola e componendo in suo onore, ne divennero a loro volta promotori e diffusori, stimolando intellettuali e pubblico ad accostarvisi e incrementando sensibilmente la fama della “danzatrice scalza” californiana.
Cosmopolita per vocazione, ammiratrice del filosofo Nietzsche, del poeta Whitman, dei compositori Bach, Schubert, Skrijabin, Wagner, attinse suggestioni e spunti fecondi dai legami amichevoli con Auguste Rodin, Eleonora Duse, Konstantin Stanislavskij, Ernst Haeckel e da incontri con numerosi artisti e intellettuali del suo tempo quali Cocteau, Laban, Bourdelle, D’Annunzio, Cosima Wagner, ecc.
Ebbe una relazione appassionata con il regista-scenografo britannico Gordon Craig, si legò a Paris Singer, il “re” delle macchine da cucire. Diede alla luce tre figli e li perse tutti, i primi due annegati nella Senna, il terzo a poche ore dalla nascita. Si sposò col poeta russo Esenin.
Accumulando e sperperando enormi somme di denaro, fondò varie scuole di danza in Europa, da cui emersero le allieve chiamate “Isadorables”.
La sua morte è stata romanzesca quanto la sua tempestosa esistenza: finì strangolata dalla lunga sciarpa impigliatasi tra i raggi dell’auto Bugatti mentre attraversava la Promenade des Anglais a Nizza.
PINA BAUSCH
Pina Bausch, donna e artista della danza, ha contribuito a cambiare il volto del teatro della seconda metà del Novecento, raccogliendone l’eredità, rielaborandola creativamente e in modo genialmente peculiare. Ha composto opere che ci guardano e ci riflettono, noi uomini e donne di questo tempo, tanto teneramente quanto impietosamente, e le ha elaborate in una forma così palesemente audace ma necessaria e organica al suo contenuto, da toccarci a fondo con quel provocante e forse catartico disagio interiore che solo i grandi riti teatrali sanno indurre.
Tanztheater, ossia teatro di danza, è stata fin dall’inizio la denominazione, semplicemente descrittiva, della compagnia della Bausch a Wuppertal. Solo più tardi questo termine avrebbe assunto, in patria e fuori, il carattere di una vera e propria definizione di stile, di un genere a sé stante di enorme influenza su artisti di ogni paese. Nata a Solingen nel 1940, ha completato nel 1958 gli studi di danza alla Folkwang Hochschule di Essen diretta da Kurt Jooss, maestro e coreografo illustre della danza espressionista tedesca tra le due guerre. Con una borsa di studio del governo tedesco si è poi trasferita negli Stati Uniti, dove si è perfezionata alla prestigiosa Juillard School ed ha fatto parte delle migliori compagnie di danza contemporanea. Tornata in Germania nel 1962, è entrata far parte come solista dell’appena fondato Folkwang Ballett di Essen e nel 1973 è stata chiamata a dirigere la compagnia del Wuppertaler Tanztheater, cui rimane legata fino ad oggi e che è diventata uno dei principali centri della sperimentazione teatrale mondiale. Fin dalle sue prime composizioni coreografiche a Wuppertal, Pina Bausch disattende le aspettative tradizionaliste del pubblico e di parte della critica, con la propensione ad inserire elementi di “non-danza”, di inconsueto realismo teatrale nelle sue coreografie. Ma è a partire da Cafè Müller, del 1978, che Pina Bausch rivela in pieno i motivi che costituiranno il fondamento dei suoi capolavori teatrali successivi, come Kontakthof (1978) – 1980 (1980) – Walzer (1982) e Nelken (1982), coi quali fa del suo Tanztheater un modello di estetica teatrale contemporanea e un esempio inimitabile, pur se costantemente imitato, di lavoro creativo d’ensemble. Negli ultimi tempi, la Bausch si dedica in particolare alla creazione di spettacoli ispirati a diverse città del mondo, tra le quali Roma (Viktor, 1986 e O Dido, 1999) e Palermo (Palermo, Palermo 1989). Un teatro dell’esperienza e della memoria biografica, da cui traspaiono i processi reali, tanto da fare, come è stato detto “della vita una chiave di lettura del teatro e non viceversa”. (Da “Laurea Honoris causa a Pina Bausch” Università degli studi di Bologna – Novembre 1999 – a cura di E. Casini-Ropa)
1989: i crolli
Un concorso di drammaturgia
Il bando
di Compagnia Teatrale ATIR
A - La Compagnia Teatrale ATIR – Associazione teatrale indipendente per la ricerca - di Milano, indice un concorso di drammaturgia che si propone di selezionare il migliore o i migliori testi teatrali o la migliore rielaborazione drammaturgica sul tema in oggetto al punto B.
B - OGGETTO DELLO SCRITTO: “1989: I crolli”. Vedi allegato.
C - Le persone interessate a partecipare al bando dovranno inviare un Curriculum Vitae all’Associazione ATIR entro il 20 maggio 2006, inserendo i propri dati anagrafici e i recapiti, e un primo scritto di 3 cartelle inerenti gli argomenti esposti nell’allegato. La prima selezione avverrà tramite Curriculum e verifica delle tre cartelle di cui sopra. Le persone scelte verranno contattate direttamente dall’ATIR entro i primi giorni di Giugno 2006. Sono ammesse anche le opere di autori di nazionalità non italiana purchè siano corredati da una traduzione in italiano.
D - Il Concorso prevede tre tranches di lavoro:
1 - Presentazione e discussione del tema e del progetto a cura della regista Serena Sinigaglia e degli attori della compagnia, rivolto alle persone già selezionate. L’incontro avverrà presso la sede dell’ATIR a Milano, in via Vittadini n. 13 il 9 – 10 - 11 giugno 2006, dalle 10.00 alle 18.00.
2 - Per accedere alla seconda selezione, verrà richiesto ai candidati di inviare un primo elaborato sul tema di almeno 10 cartelle dattiloscritte, entro il 2 luglio 2006. Le persone i cui testi saranno considerati più idonei al progetto verranno convocate al secondo incontro-confronto di lavoro con la regista e la compagnia, che si terrà a Milano dal 7 al 9 luglio 2006 in luogo da definirsi.
3 - Terza tranche: entro e tassativamente non oltre il 27 agosto gli autori dovranno consegnare il testo finito. Tale testo dovrà avere la durata max di 100 minuti e min di 60 minuti.
E - Tutti i testi inviati durante le fasi del concorso dovranno pervenire in triplice copia, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: A.T.I.R. Viale B. d’Este, 12 – 20122 Milano - c.a. Serena Sinigaglia.
F - ENTRO la fine di settembre la regista Serena Sinigaglia, assieme alla Compagnia teatrale ATIR, sceglierà il testo/i VINCITORE/I. La regista e la Compagnia si riservano di non premiare nessun testo presentato, qualora nessuno scritto fosse adeguato alla messa in scena. I TESTI non scelti non verranno riconsegnati agli autori.
G - Il Testo/i Vincitore/i, verrà rappresentato e messo in scena dalla regista Serena Sinigaglia e dalla Compagnia teatrale ATIR. Inoltre al Vincitore/i, verrà dato un premio di 500 euro lordi complessivi, più una percentuale per i Diritti d’autore del testo per ogni replica rappresentata.
H - Il Vincitore dovrà cedere i diritti di rappresentazione del Testo alla Compagnia ATIR per almeno 4 anni.
I - Lo spettacolo messo in scena diventerà la nuova produzione della Compagnia teatrale ATIR per l’anno 2007 e avrà nella prima parte della stagione una lunga permanenza a Milano ai Teatridithalia.
L - La regista si riserva di poter variare a suo piacimento il testo prescelto, discostandosi, se la messa in scena lo richiede, dall’originale.
M - Il bando di concorso verrà pubblicizzato attraverso canali interni alle Scuole di Teatro e attraverso organi di stampa competenti.
Per informazioni: A.T.I.R. via Vittadini, 13 – 20136 Milano – tel. 02 58325578 – atirteatro@fastwebnet.it - www.atirteatro.it
CONCORSO DI DRAMMATURGIA “1989: I CROLLI”
ALLEGATO
‘89 è il terzo spettacolo (l’ultimo capitolo) di una trilogia a cui ho dato il nome (rubandolo al grande Gurdjeff) di Incontri con epoche straordinarie: ’43, ’68, ‘89. ‘43 e ‘68 sono già diventati due spettacoli, uno creato e poi fatto circuitare dal ’97 ad oggi, l’altro dal 2003 fino ad oggi. Ora comincio ad affrontare ‘89. Conoscere il passato è il solo modo per poter sperare di riconoscere il presente. Viviamo circondati, asfissiati direi, dall’informazione eppure, mai come ora, siamo ignoranti, paralizzati, incapaci di intervenire nel reale per cambiarlo e migliorarlo. E questo accade per il semplice fatto che i dati a getto continuo che riceviamo non creano sapere, non portano alla conoscenza che sola vive della relazione tra le cose e della capacità critica che il soggetto deve imparare ad usare. I fatti, i dati, dunque non sono il sapere. Il sapere arriva attraverso l’arte di ascoltare, guardare, chiedere, collegare… questo è conoscere. Orfana di “politica”, cerco attraverso questa trilogia di accrescere la mia “consapevolezza politica”. Un uomo senza politica è come un uomo senza amore: un uomo a cui manca una parte fondamentale di esperienza e vita per potersi sentire minimamente soddisfatto.
La trilogia dunque nasce dal desiderio urgentissimo di conoscere e imparare a riconoscere la realtà in cui viviamo e insieme nasce per amore e bisogno di ricostruirsi una coscienza “politica” seria, forte, importante.
Sull’89, oltre al sacrosanto bisogno di saperne di più e di sapere più veramente quanto è accaduto, mi sento mossa anche da un preciso sentimento: la sensazione che quel muro che cadeva era anche lo sgretolarsi degli ideali per cui lottare e vivere, la sensazione che stavamo ereditando un mondo senza cuore, senza centro, senza utopia. Una sorta di funerale a Don Chisciotte! Mio Dio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eccovi le mie riflessioni e domande e questioni da approfondire insieme e su cui vorrei si incentrassero i vostri scritti:
La Romania a mio avviso offre uno spunto di riflessione molto importante sull’intero crollo dei regimi comunisti e sul velo di ipocrisia e menzogna che circonda quegli eventi. Timisoara è l’esempio lampante di come il crollo dei regimi non sia stato affatto come ce l’hanno raccontato ovvero la fine dell’impero del male. Quale fine? E quale impero? C’è stata davvero la fine di una cosa o piuttosto la mostruosa metamorfosi dello stesso sistema?
- Perché i regimi comunisti sono crollati? Tutti festeggiavano, almeno così sembrava. Tutti festeggiavano: la fine dell’oppressione, la fine della povertà, la fine delle privazioni… Evviva la libertà!!! Ma davvero? E anche in questo caso: quale libertà? E’ stata davvero la volontà popolare a produrre il crollo?
- Che cosa sono stati gli anni ’80 nel panorama della guerra fredda e più in generale di tutto il dopo guerra? Mi interessano gli anni ’80 perché sono gli anni dove sono cresciuta, gli anni del mio apprendimento spirituale. Sono nata nel 1973. L’unico evento forte a livello internazionale e contemporaneamente più vicino a cui ho assistito è proprio il crollo.
- Cosa ricordate di quei giorni del crollo del muro? Dei giorni prima e dei giorni dopo il 10 Novembre. Cosa stavate facendo? Dove? Siete per caso andati anche voi a comprare pezzi del muro?
- Che cosa ha significato il crollo del muro di Berlino per te?
- Si può vivere senza ideologie? Le religioni oggi sostituiscono le ideologie di ieri? Gli ideali di un mondo più giusto e più egualitario attraverso quali parole, quali codici, quali segnali possono non solo esistere ma anche concretizzarsi oggi?
Serena Sinigaglia
Tadeusz Kantor in mostra a Torino 25 anni dopo Wielopole Wielopole
Dal 4 al 14 maggio
di Ufficio Stampa
TADEUSZ KANTOR - WIELOPOLE –WIELOPOLE 25 anni dopo
UNA RASSEGNA A TORINO
L’Associazione Zutart e la Comunità polacca di Torino in collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro d’Europa, le Biblioteca Civiche Torinesi e il DAMS, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Torino organizzano dal 4 al 12 maggio una rassegna di mostre incontri proiezioni legati alla figura del drammaturgo polacco Tadeusz Kantor, a partire dall’anniversario del debutto dello spettacolo Wielopole-Wielopole (23 giugno 1980).
Infatti, in occasione della posa della targa a Firenze nel novembre 2005 dedicata a Tadeusz Kantor, in memoria dei 25 anni della prima di Wielopole-Wielopole, e a ricordo dell’impegno del Comune di Firenze e del Teatro Regionale Toscano che ospitarono la produzione dello spettacolo, sono stati ritrovati e riorganizzati importanti documenti: scritti, testimonianze, fotografie.
La prima manifestazione si è svolta a Firenze (Teatro della Pergola) nel mese di novembre, la seconda si è appena conclusa a Roma (Casa dei Teatri), la terza ora a Torino (Teatro Gobetti - DAMS), la quarta e ultima a Milano (CRT-Teatro dell’Arte).
A Torino l’intera rassegna sarà presentata nella Sala delle colonne del Teatro Gobetti il 4 maggio alle ore 18.00 con l’inaugurazione della mostra fotografica- documentaria e la presentazione delle tre pubblicazioni dedicate a Tadeusz Kantor.
Il DAMS, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Torino collabora all’organizzazione delle tre giornate di studio e ospita la sezione video.
Le tre giornate di studio sono il momento centrale della manifestazione, volte a completare, attraverso documenti in Italia pressoché sconosciuti, la figura del drammaturgo, pittore, scenografo.
I relatori ospiti sono: Jozef Chrobak, Jaromir Jedlinski, Luisa Passega.
Le Biblioteche civiche torinesi offrono l'opportunità di un approfondimento sulla documentazione video dei tre più noti spettacoli programmando per tre venerdì (19-26 maggio e 9 giugno) un ciclo di proiezioni introdotte e commentate da Silvia Parlagreco presso il Punto prestito Gabriele D’Annunzio.
I libri pubblicati per questa occasione sono:
Wielopole Skrzynskie di Tadeusz Kantor, a cura di Jozef Chrobak, che ricostruisce le vicende storiche della cittadina e della famiglia del drammaturgo, i cui appartenenti diventarono i protagonisti dello spettacolo realizzato negli anni ottanta.
Kantor – Wielopole-Wielopole- Dossier, a cura di J. Chrobak, S.Parlagreco, V.Valoriani, N.Zarzecka
che ricostruisce l’intera vicenda dello spettacolo attraverso il Diario delle prove redatto da Luisa Passega, le fotografie di Antonio Sferlazzo, contributi critici e testimonianze.
Il volume sarà presentato a Torino alla Fiera del Libro presso lo stand della Città - venerdì 5 novembre alle ore 21.00.
Il volume precedentemente pubblicato sull’argomento, e oggi ripresentato, è: Kantor a Firenze, a cura di V. Valoriani.
Programma 4 – 12 maggio 2006
Teatro Gobetti – sala delle Colonne
Inaugurazione giovedì 4 maggio h.18.00
mostra
a cura di Jozef Chrobak
Le prove di Wielopole-Wielopole nelle fotografie di Antonio Sferlazzo
archivio ETI - Biblioteca Spadoni
Wielopole Skrzynskie di Tadeusz Kantor
documentazione sulla cittadina di origine di T. Kantor
video in mostra:
Die Famiglie aus Wielopole registrazione durante le prove a Firenze per la regia di Michael Kluth, Westdeutscher Rundfunk, 1980, 45'
Wielopole-Wielopole registrazione della prima assoluta fiorentina per la regia di J. e D. Bablet, TRT e CNRS, 1980, 60°
presentazione dei libri
con la partecipazione dei curatori
Kantor /Wielopole-Wielopole/Dossier
a cura di J. Chrobak, S. Parlagreco, V. Valoriani, N. Zarzecka - ed. Gremese
Wielopole Skrzynskie di Tadeusz Kantor
a cura di Jozef Chrobak - ed. Cricoteka
Kantor a Firenze
a cura di Valerio Valoriani – ed. Titivillus
DAMS – Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino
proiezioni - Laboratorio Multimediale “Guido Quazza” (LM) e Sala Lauree (SL) h. 10.30
lunedì 8 (SL) La classe morta
A. Wajda, TVP, 1976, 75°
martedì 9 (SL) Wielopole-Wielopole
A .Sapija, Krakow 2000, 1984, 60°
mercoledì 10 (LM) Crepino gli artisti
A.Zajaczkowski, OTV, 1986 , 77°
giovedì 11 (SL) Qui non ci torno più
A.Sapija, TVO, 1990, 81°
venerdì 12 (LM) Oggi è il mio compleanno
A. Zajaczkowski, OTV, 1991, 77°
Le giornate di studio
Sala Lauree h. 14-17.00
Lunedì 8
Jozef Chrobak Kantor e la Grupa Krakowska
traduce Margherita Bacigalupo
Jozef Crobak che è il direttore delle storiche Cantine Krzysztofory, luogo teatrale del Cricot 2 e anche il conservatore dei documenti della Grupa Krakowska, il gruppo dell’avanguardia di Cracovia a cui Kantor si legò a partire dagli anni quaranta. È storico d’arte, membro AICA; ha organizzato numerose mostre sull’opera di Kantor, ma anche su altri artisti polacchi del Novecento.
Terrà una lezione sul periodo di formazione di Kantor a partire dalla sua biografia, agli anni dell’Accademia, il teatro clandestino, fino alla formazione del Cricot2.
Martedì 9
Luisa Passega Leggere Kantor con Kantor
Luisa Passega, è l’autrice del diario ora pubblicato. Kantor la autorizzò, all’epoca, a seguire e trascrivere le prove di Wielopole-Wielopole. Oltre alla laurea in lettere, si è diplomata alla Scuola di Teatro Ater/Ert di Bologna. Ha vinto la borsa di studio CEE/Gaumont per attori professionisti (1982) ed ha studiato con Dominic De Fazio, Moderator all’Actors Studio, in Italia e negli Stati Uniti, collaborando poi lungamente con lui nell’organizzazione di seminari di acting, analisi del testo e lettura filmica. Oggi insegna al Liceo Artistico di Brescia.
Terrà una lezione sul metodo teatrale in riferimento a Wielopole-Wielopole, attraverso l’analisi delle interviste, riflessioni del drammaturgo, considerazioni proprie di ‘testimone’ e degli scritti teorici.
Venerdì 12
Jaromir Jedlinski Kantor e la galleria Foksal
traduce Luca Bernardini
Jaromir Jedlinski, storico d’arte. A Torino è conosciuto per avere curato nel 1993, in qualità di direttore del Museo d’Arte di Lodź, la mostra su Joseph Beuys al Circolo degli Artisti. Quale collaboratore della galleria Foksal di Varsavia, terrà una lezione sugli anni in cui Kantor divenne uno dei principali artisti della galleria. È uno dei periodi più interessanti dell’arte di Kantor: i cricotage, gli happening, l’arte utopica, i rapporti con l’avanguardia internazionale.
La lezione sarà corredata da materiale filmico in Italia per lo più inedito.
Nell’ambito delle collaborazioni con le Biblioteche Civiche Torinesi
Fiera del libro presso lo stand della Città
venerdì 5 maggio ore 21.00
presentazione del libro
Kantor /Wielopole-Wielopole/Dossier
a cura di J. Chrobak, S. Parlagreco, V. Valoriani, N. Zarzecka ed. Gremese
saranno presenti i curatori con l’autrice del diario Luisa Passega e il fotografo Antonio Sferlazzo
segue proiezione video
Wielopole-Wielopole D. e J. Bablet, TRT e CNRS, 1980, 60°
registrazione prima assoluta a Firenze 23 giugno 1980
.
Proseguimenti
Le Biblioteche civiche torinesi offrono l'opportunità di un approfondimento sulla documentazione video dei tre più noti spettacoli programmando un ciclo di proiezioni introdotte e commentate da Silvia Parlagreco
presso il Punto prestito Gabriele D’Annunzio
h. 18.00
venerdì 19 maggio
La classe morta A. Wajda, TVP, 1976, 75°
venerdì 26 maggio
Wielopole-Wielopole D. e J. Bablet, TRT e CNRS,1980, 60°
venerdì 9 giugno
Crepino gli artisti A. Zajaczkowski, OTV, 1986, 77°
Premio Hystrio 2006 per giovani attori
Il bando
di Hystrio
VIII edizione del Premio Hystrio alla Vocazione
concorso nazionale per giovani attori maggio/giugno 2006
Il Premio alla Vocazione per giovani attori organizzato dalla rivista di cultura teatrale e spettacolo Hystrio è considerato il più importante premio dedicato ai nuovi talenti che calcheranno i palcoscenici italiani nel prossimo futuro. Un incentivo a continuare il processo di formazione dato dalle due borse di studio offerte, ma anche una straordinaria occasione di visibilità offerta ai giovani che intendono affrontare con passione vera il lavoro d’attore; questa in sintesi l’ambizione sempre più concreta del Premio Hystrio e dei suoi organizzatori.
L’ottava edizione del Premio Hystrio alla Vocazione per giovani attori, si svolgerà a Milano dal 15 al 17 giugno 2006 ospite del Teatro Litta. Il Premio consiste in due borse di studio da euro 1.550 ciascuna (una per la sezione maschile e una per quella femminile) ed è destinato a giovani attori entro i 30 anni (l’ultimo anno di nascita valido per le iscrizioni è il 1976), che affronteranno un'audizione di fronte a una giuria altamente qualificata di addetti ai lavori composta da direttori di Stabili, pubblici e privati, registi e critici teatrali.
Anche quest’anno il concorso avverrà in due fasi: una pre-selezione riservata a giovani aspiranti attori autodidatti o comunque sprovvisti di diploma di una scuola istituzionale di recitazione; e una selezione finale per chi frequenta o si è diplomato presso scuole istituzionali, scuole dei teatri stabili pubblici, scuole civiche, Accademie di Roma e Accademia dei Filodrammatici di Milano (si può consultare l’elenco completo delle scuole sul sito www.hystrio.it) o chi ha versato per tre anni consecutivi i contributi ENPALS, cui si aggiungeranno i prescelti della pre-selezione.
Per iscriversi (entro il 15 maggio per la pre-selezione; entro il 5 giugno per la selezione finale) è necessario inviare alla direzione di Hystrio (via Olona 17, 20123 Milano, tel. 02.400.73.256, fax 02.45.40.94.83, hystrio@fastwebnet.it : curriculum, una foto, la fotocopia di un documento d'identità, titolo e autore dei due brani e di una poesia o canzone scelti per l'audizione. La quota d'iscrizione è di euro 15 da versarsi all’atto dell’iscrizione nei seguenti modi:
- bonifico su conto corrente bancario (n. 625006976022-COMIT BANCA INTESA via De Amicis 26, Milano – ABI 03069 – CAB 09458 CIN J)
- versamento su conto corrente postale (n. 40692204 intestato a Hystrio-Associazione per la diffusione della cultura teatrale, via Vulturno 44, Milano (la cedola di avvenuto versamento dovrà essere inviata via fax a n. 0245409483)
- versamento tramite carta di credito iscrivendosi online sul sito www.hystrio.it.
-
Per informazioni: Hystrio-trimestrale di teatro e spettacolo, tel. 02.400.73.256, fax 02.45.40.94.83, hystrio@fastwebnet.it, www.hystrio.it
Sul sito www.hystrio.it si trovano tutte le informazioni necessarie ai candidati: i nomi delle scuole di teatro che permettono, se frequentate, di accedere direttamente alle selezioni finali; i testi per la scelta dei brani da preparare per le audizioni; l’aggiornamento in tempo reale dei selezionati provenienti dalla pre-selezione; nomi e curricula dei vincitori delle passate edizioni.
Per informazioni al pubblico:
Hystrio, trimestrale di teatro e spettacolo, via Olona, 17 - 20123 Milano
tel. 02.400.73.256, fax 02.45.40.94.83
hystrio@fastwebnet.it, www.hystrio.it
Un laboratorio con il Bread & Pupett
(e se non sapete che cos'è, curiosate nella ateatropedia)
di Pergine Spettacolo Aperto
Bread & Puppet Company (USA)
"Circus of the Americas"
LABORATORIO
e spettacolo-parata
diretto da Peter Schumann
con 10 elementi del Bread & Puppet
un progetto di
Pergine Spettacolo Aperto
in collaborazione con piùFestival di Brescia
Laboratorio: Pergine Valsugana, 5 14 giugno 2006
Spettacolo-parata: 15 giugno a Pergine Valsugana -16 giugno a Brescia
Una vera e propria festa: una parata dedicata alla storia e al presente d¹America, con la compagnia Bread & Puppet diretta da Peter Schumann. Pupazzi, musica, danza, secondo lo stile inconfondibile, raffinato e popolare, che ha fatto di Schumann e del gruppo statunitense un mito del teatro contemporaneo internazionale.
Nato nei primi anni sessanta, il Bread & Puppet Theater diventa famoso per le sue azioni di strada, parate, spettacoli politici ed antimilitaristi, pupazzi spesso giganteschi, maschere e pantomima: forme semplici, talora derivate dalle correnti dell'avanguardia artistica storica e contemporanea, di grande originalità sul piano estetico e di grande impatto comunicativo. Con gli anni, la compagnia -che ha sede nel Vermont - ha mantenuto intatta la sua freschezza, la capacità di aggregare e di "graffiare", sempre dalla parte dei deboli. Il "laboratorio", con la partecipazione di professionisti e non, è il suo metodo abituale di lavoro.
Il laboratorio
• E' incentrato sulla costruzione e l'animazione di grandi pupazzi e su azioni spettacolari (teatrali, mimiche e coreografiche) con musiche.
• Il tema è la storia e il presente delle Americhe (a cui Pergine Spettacolo Aperto dedica il programma del Festival 2006/2007), il tutto secondo lo stile del gruppo americano, con la guida di Peter Schumann e con dieci componenti del Bread & Puppet .
• Parteciperanno al laboratorio giovani professionisti (attori/ costruttori/ animatori/musicisti/danzatoriŠ), bambini, la banda di Pergine, "comparse"
• Il principale requisito richiesto da Peter Schumann è: aver voglia di partecipare a un grande gioco collettivo e di divertirsi!
• La partecipazione è volontaria.
• Nessuna spesa verrà rimborsata.
• Ai partecipanti verrà chiesta una quota di adesione per la copertura delle spese assicurative di 10 Euro.
Pergine Spettacolo Aperto su richiesta metterà a disposizione dei candidati alloggi in appartamento o albergo a prezzi particolarmente agevolati.
Pergine Spettacolo Aperto, Piùfestival di Brescia e Bread & Puppet selezionano partecipanti delle seguenti tipologie:
a) giovani (o meno giovani: non ci sono limiti di età) professionisti (o con esperienze nei campi dello spettacolo indicati):
• interessati alla costruzione e animazione di pupazzi e possibilmente con qualche esperienza pratica o attitudine in materia
• con esperienze nel campo della recitazione, danza e movimento
• costituirà elemento preferenziale: la pratica di uno strumento musicale e la conoscenza di
•
tecniche circensi o del teatro di strada (es. giocoleria, trampoli, etc.)
La selezione verrà effettuata sulla base dei curriculum dei candidati dagli incaricati dei festival, anche in collegamento con Bread & Puppet Theater.
La selezione è nazionale con una quota riservata a candidati residenti nelle zone di Trento e Brescia.
Il laboratorio si svolgerà dal 5 al 17 giugno:
-dal 5 al 15 giugno a Pergine Valsugana a tempo pieno, secondo ordine del giorno (si richiede la disponibilità mattino, pomeriggio e sera)
-sono previste dimostrazioni finali/parate a Pergine Valsugana giovedì 15 giugno e a Brescia venerdì 16 giugno (con possibile slittamento al 17 in caso di maltempo).
La domanda di partecipazione al laboratorio (secondo il modello allegato e scaricabile dal sito www.perginepsa.it oppure http://www.piufestival.it ), con un curriculum che precisi in particolare le esperienze e attitudini in rapporto alle pratiche sopra indicate, e una foto a figura intera, dovrà pervenire entro venerdì 12 maggio a:
Pergine Spettacolo Aperto ¬ Via Guglielmi 19 ¬ 38057 Pergine Valsugana (TN) o via fax al numero 0461 533995 (e a seguire per posta)
Per i residenti di Brescia e Provincia: piùFestival, Ufficio Manifestazioni ¬ Via Musei 55 ¬ 25121 Brescia o via fax al numero 030.46547 (e a seguire per posta)
Entro il 20 maggio verrà comunicata la lista degli elementi ammessi al laboratorio.
b) volontari di qualunque età
interessati a partecipare e divertirsi, residenti a Pergine Valsugana o in zona, disponibili il tardo pomeriggio/sera dal 5 al 15 giugno secondo ordine del giorno, disposti a partecipare alla parata finale a Pergine giovedì 15 giugno, e a Brescia venerdì 16 giugno (con eventuale slittamento al 17 giugno in caso di maltempo). Gli interessati dovranno compilare di persona una scheda presso gli uffici di Pergine Spettacolo Aperto (Via Guglielmi 19, Pergine Valsugana) negli orari e giorni indicati:
Venerdì 5 maggio dalle 17.00 alle 19.00. Sabato 6 maggio dalle 9.00 alle 12.00
Per maggiori informazioni:
PERGINE SPETTACOLO APERTO tel. 0461-530179 ufficioproduzione@perginepsa.it
PIUFESTIVAL tel. 030- 2808066 ufficio.manifestazioni@comune.brescia.it
Riccione TTV: il programma definitivo
La scena e lo schermo a Bologna dal 3 al 14 maggio
di Riccione TTV
Riccione TTV Festival - La scena e lo schermo, che si articola in diverse sezioni, è un viaggio nella relazione tra arti dello spettacolo, video e film, con una attenzione peculiare ad alcuni repertori di storie (Mozart, Ibsen, Andersen-Sarah Moon), che tornano nel corso del tempo, in una ricchissima scena della memoria.
In occasione del duecentocinquantesimo anniversario dalla nascita di Mozart, l’edizione 2006 del TTV dedica un ampio spazio al celebre compositore proponendo vari percorsi a lui dedicati; il progetto, dal titolo MozArt! è ideato e curato dallo scrittore e studioso Luca Scarlini, e realizzato in collaborazione con il prestigioso Festival Mozart 2006 di Vienna e il Centro Culturale Austriaco di Milano.
Oltre alle proiezioni di film e video, tra nuove produzioni e rarità, segnaliamo l'installazione per video e macchine del suono Habemus Papam? di Fanny & Alexander e Zapruder Filmakersgroup. L'installazione inaugura giovedì 4 maggio alle ore 17.00 e in replica alle ore 18/19/20 dal 4 al 6 maggio, presso la Galleria Neon.
Un importante spazio il TTV lo dedica ad un altro anniversario di grande risonanza: quello della morte di Henrik Ibsen, autore che torna sempre più di attualità nelle ultime stagioni con le sue spietate analisi del vivere nella dimensione sociale.
La sezione, che alterna momenti teatrali a momenti cinematografici, ha come sottotitolo Luci del Nord ed è realizzata in collaborazione con l’Ambasciata di Norvegia e fa parte del progetto IBSEN IN ITALIA.
Il percorso teatrale vede in scena il Teatrino Clandestino con Hedda Gabler, performance per un'attrice, pianoforte e nastro magnetico, inaugurazione sabato 6 maggio alle ore 21 (repliche 7/8/9/10 maggio dalle 16 alle 20 - 11/12/13 maggio dalle 16 alle 19) presso la Chiesa di San Mattia. Sempre alla di San Mattia il Teatrino Clandestino propone inoltre la performance Si prega di non discutere di casa di bambola 11/12/13 maggio alle ore 21.
Sul lavoro teatrale del regista tedesco Thomas Ostermeier, in anteprima nazionale il video Hedda Gabler di Hannes Rossacher. Ostermeier torna a Ibsen dopo il successo di Nora, con una versione rigorosissima di Hedda Gabler, incentrata su una protagonista dall’aria quasi infantile, una splendida Katharina Schüttler che provoca continuamente, esprimendo un eros quasi astratto.
Segnaliamo inoltre anche una presenza speciale, quella della grande artista-fotografa Sarah Moon che venerdì 5 maggio alle ore 19.00 presso la Galleria Ta Matete (via S.Stefano, 17) presenta la sua magnifica versione di due fiabe di Andersen: La piccola fiammiferaia (Circuss) e Il soldatino di stagno (L’effraie), lavori recentemente presentati alla Maison de Danemark a Parigi e in seguito in vari musei d’arte contemporanea nel mondo.
L'artista, nota in Italia anche per una premiatissima campagna pubblicitaria per Cacharel, incontra il pubblico del festival sabato 6 maggio alle ore 10.30 presso la Biblioteca Sala Borsa Ragazzi per raccontare il suo lavoro.
Sabato 6 maggio alle ore 19.00 presso la Sala Gino Cervi si svolgerà la premiazione dei finalisti di Concorso Italia 2006,competizione che attribuisce il Premio Riccione TTV a lavori di videoteatro e videodanza di autori teatrali, produttori e videomaker italiani.
Riccione TTV dedica inoltre una personale al regista francese Pierre Coulibeuf, che ha realizzato sino ad oggi una ventina di produzioni video-cinematografiche all’interno di un progetto interdisciplinare, che mette in contatto arti visive, cinema, fotografia, performance, letteratura e pittura in un gioco di relazioni variabili. Il lavoro di Coulibeuf che, dal 1987 ad oggi, ha portato alla realizzazione di opere cinematografiche basate sugli universi artistici di Pierre Klossowski, Michelangelo Pistoletto, Marina Abramovic, Michel Butor, Jean-Marc Bustamante, Jan Fabre, Meg Stuart, sono stati presentati in numerosi festival internazionali e recentemente alla Biennale d’Arte Contemporanea di Porto Alegre in Brasile, i suoi film fanno parte di diverse collezioni pubbliche, dal Centre Pompidou a Parigi, alla GAM di Torino.
Uno speciale omaggio Riccione TTV lo dedica a John Smith, il cui lavoro, frutto di un’artigianalità meticolosa, è ispirato al materiale grezzo della quotidianità, rielabora e trasforma la realtà attraverso l’esplorazione e l’esposizione giocosa del potere del linguaggio filmico.
RICCIONE TTV FESTIVAL, fondato da Franco Quadri nel 1985 e diretto da Fabio Bruschi, si svolge in collaborazione con Cineteca del Comune di Bologna, Assessorato alla Cultura del Comune di Bologna, Galleria Ta Matete, Cassero - Gay and Lesbian Center, LUo - Libera Università Omosessuale, Bologna Festival, Biblioteca Sala Borsa Ragazzi, Fieri di Leggere, Bologna per Mozart, Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, Galleria Neon, Biblioteca Renzo Renzi, Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale di Roma, Maison Francaise de Bologne, Alliance Francaise de Bologne, con il contributo della Reale Ambasciata di Norvegia a Roma, del Centro Culturale Austriaco a Milano, dell’Ambasciata di Francia a Roma e il patrocinio del Comune di Bologna e dell’Ambasciata di Danimarca a Roma.
Per informazioni:
Premio Riccione per il Teatro Tel. 051 / 204726 - 0541 694425 - (lun. - ven. 8.30 – 14) www.riccioneteatro.it
proiezioni
Progetto MozArt!
3 maggio ore 20.00
Cinema Lumière 2/Officinema (ingresso 6 euro)
Pupi Avati presenta
Noi tre (Ita/1984/90’)
regia di Pupi Avati
introduce Piero Mioli
Opera Video
4 maggio ore 21.00
Sala Gino Cervi (ingresso libero)
Flashmob-The Opera (UK/2004/60’)
regia di Phil Chilvers
(film musicale in versione origianle)
Progetto MozArt!
4 maggio ore 22.00
Sala Gino Cervi (ingresso libero)
Why Salieri, signora Bartoli (Fra/2004/44’)
regia di Yves Angelo, musiche di Antonio Salieri con Cecilia Bartoli e Gerard Depardieu
(versione originale con sottotitoli in inglese)
Progetto MozArt!
4 maggio ore 22.30
Cinema Lumière 1 (ingresso 6 euro)
Wolf (Ger/2005/130’)
regia di Alain Platel (versione originale con sottotitoli in italiano)
Progetto MozArt!
5 maggio ore 20.00
Cinema Lumière 2/Officinema (ingresso 6 euro)
Luca Scarlini presenta
M is for Man, Music and Mozart (UK/1992/30’)
regia di Peter Greenaway (film musicale in versione originale)
a seguire
Don Giovanni (Ita/1980/70’)
regia di Carmelo Bene
copia restaurata dal Csc - Cineteca Nazionale
Studie 11(USA/1932/5’)
regia di Oskar Fischinger (versione originale)
Luci del Nord: Ibsen tra film e video
7 maggio ore 20.45
Cinema Lumière 1 (ingresso 6 euro)
Terje Vigen (Sve/1917/65’)
regia di Victor Sjostrom’
(versione originale con sottotitoli in italiano)
commento musicale di Daniela Cattivelli
introduce Stefano Boni, vicedirettore del Museo Nazionale del Cinema di Torino
la proiezione si svolge all’interno della rassegna La natura non indifferente. Il cinema svedese di Victor Sjostrom promossa dal Centro La Soffitta del Dipartimento di Musica e Spettacolo - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in collaborazione con Cinematek - Svenska Filminstitutet e con Museo Nazionale del Cinema
Videodanza
8 maggio ore 18.00
Sala Gino Cervi (ingresso libero)
Taut (UK/2001/3’)
regia e coreografia di Charlotte Darbyshire
The cost of living (UK/2004/35’)
regia di Lloyd Newson, DV8
Outside in (UK/1994/14’)
regia di Margaret Williams, coreografia di Victoria Marks
Videodanza
8 maggio ore 19.00
Sala Gino Cervi (ingresso libero)
Damen und Herren (Ger/2002/67’) dedicato a Pina Bausch
regia di Lilo Mangelsdorff (versione originale con sottotitoli in inglese)
Progetto MozArt!
8 maggio ore 20.15
Cinema Lumière 1 (ingresso 6 euro)
La carriera di un libertino: il fantasma di Mozart tra cinema e video (Ita/2006/60’)
montaggio appositamente realizzato da Luca Scarlini e Lino Greco
introduce Luca Scarlini
a seguire
Mozart: looking for traces (Aus/2005/52’)
regia di Ute Gebhardt (versione originale con sottotitoli in italiano)
Luci del Nord: Ibsen tra film e video
8 maggio ore 22.30
Sala Gino Cervi (ingresso gratuito)
il regista Paul Willis presenta
Hedda Gabler (USA/2004/88’)
regia di Paul Willis
(versione originale con sottotitoli in italiano)
anteprima europea
introduce Gerardo Guccini
Videodanza
9 maggio ore 16.15
Sala Gino Cervi (ingresso libero)
A day at the office (Can/2005/24’)
regia di Robert DeLeskie
estratti da The Score (Can/2005/25’)
regia di Kim Collier, coreografia di Crystal Pite
9 maggio ore 17.15
Blush (Bel/2005/52’)
regia di Wim Vandekeybus,
coreografia di Wim Vandekeybus e Ultima Vez
Ma mere l’Oye (Bel/2004/28’)
regia di Thierry de Mey, musiche di Maurice Ravel
con Anne Teresa Keersmaeker
Au quart de tour (Bel/2004/7’)
regia di Antonin de Bemels
Progetto MozArt!
9 maggio ore 21.00
Cinema Lumière 1 (ingresso 6 euro)
Il produttore Sergeiff Ivanof presenta
The diary of San Petersburg: Mozart Requiem
(Rus/2004/70’)
regia di Alexander Sokurov
(film musicale in versione originale)
introduce Giordano Montecchi
Evento speciale Kathakali
10 maggio ore 17.30
Sala Gino Cervi (ingresso libero)
Kalamandalam Ramankutty Nair (Ind/2005/73’)
regia di Adoor Gopalakrishnan (vers. originale con sottotitoli in inglese)
introduce Giovanni Azzaroni
Opera Video
10 maggio ore 19.00
Sala Gino Cervi (ingresso libero)
The Nightingale (Fra/2004/50’)
Regia di Christian Chaudet, musiche di Igor Stravinsky (film musicale in versione originale)
Luci del Nord: Ibsen tra film e video
10 maggio ore 20.30
Cinema Lumière 1 (ingresso 6 euro)
Stutzen der Gesellschaft (Ger/1935/85’)
regia di Douglas Sirk (versione originale con sottotitoli in italiano)
introduce Franco La Polla
10 maggio ore 22.30
Cinema Lumière 1 (ingresso 6 euro)
Nora Helmer (Ger/1974/101’)
regia di Reiner Werner Fassbinder, con Margit Carstensen
(versione originale con sottotitoli in italiano)
introduce Franco La Polla
Opera Video
11 maggio ore 18.30
Il Cassero
Britten’s Children (UK/2003/89’)
regia di John Bridcut (versione originale con sottotitoli in italiano)
Progetto MozArt!
11 maggio ore 20.30
Cinema Lumière 1 (ingresso 6 euro)
All the prodigies (Rep.Cz/2005/57’)
regia di Rudolf Chudoba (versione originale con sottotitoli in italiano)
introduce Luca Scarlini
a seguire
estratti da In search of Mozart (UK e altri/2005/30’)
regia di Phil Grabsky (versione originale con sottotitoli in italiano)
in collaborazione con Bologna Festival
Opera Video
11 maggio ore 22.30
Sala Gino Cervi (ingresso libero)
Glenn Gould Hereafter (Fra/2005/106’)
regia di Bruno Monsaingeon (versione originale con sottotitoli in italiano)
introduce Mario Gamba
Videoteatro
12 maggio ore 18.00
Sala Gino Cervi (ingresso libero)
Harold Pinter - Art, truth & politics: the Nobel lecture 2005
(UK/2005/46’)
di illuminations TV
con David Hare e Harold Pinter
(versione originale con sottotitoli in italiano)
Luci del Nord: Ibsen tra film e video
12 maggio ore 20.30
Sala Gino Cervi (ingresso libero)
Hedda Gabler (Ger/2006/120’)
regia di Hannes Rossacher, dall’omonimo spettacolo
di Thomas Ostermeier
(versione originale con sottotitoli in italiano)
anteprima italiana, introduce Massimo Marino
Viedodanza
Stationary Dances
recent British dance films selected by Miranda Pennel
13 maggio ore 18.00
Sala Gino Cervi (ingresso libero)
Miranda Pennel presenta
Gold (UK/2004/10’)
regia di Rachel Davies
coreografia di Hanna Gillgren
You made me love you (UK/2005/4’)
regia di Miranda Pennel
Stationary Music (Uk/2005/15’)
regia di Jayne Parker
The incomplete Biography (UK/2004/4’)
regia e coreografia di Rajyashree Ramamurthi
Tralala (UK/2004/3’)
regia di Magali Charrier
Nascent (UK /2005/9’)
regia di Gina Czarneck
coreografia di Garry Stewart
Double edge dalla serie Capture 4 (UK/2005/4’)
regia di Sue Smith, coreografia di Sue Smith, Kuldip Singh-Barmi e David Toole (CandoCo, DV8)
Fisticuffs (UK/2004/11’)
regia di Miranda Pennel
Personale di John Smith - Real Fiction
13 maggio ore 19.15
Sala Gino Cervi (ingresso libero)
experimental films by John Smith. John Smith presenta
The Girl Chewing Gum (UK/1976/12’)
Worst Case Scenario (UK/2003/18’)
Hotel Diaries: Frozen War (UK/2001/11’), Museum Piece (UK/2004/12’), Throwing Stones (UK/2004/11’)
MozArt! un gioco da ragazzi, cartoni animati e riscritture
14 maggio ore 15.30
Cinema Lumière 1 (ingresso 6 euro)
Il flauto magico (Aus/1978/45’)
regia e sceneggiatura Emanuele Luzzati e Giulio Gianini
Le nozze di Figaro (da opera Imaginaire) (UK/1997/3’45’’)
regia di Pascal Roulin, cantata da Susanne Danco
Bryn Terfel animated arias (UK/2005/3’)
regia Tom Edgar
Papageno (Ger/1935/11’)
regia di Lotte Reininger
introduce Tiziana Roversi
in collaborazione con
la rassegna Schermi e Lavagne,
Biblioteca Sala Borsa Ragazzi,
Fieri di leggere
installazioni e performance
Progetto MozArt!
4 maggio ore 17.00 inaugurazione
repliche ore 18.00/19.00/20.00
5/6 maggio ore 18.00/19.00/20.00
Galleria Neon
Fanny & Alexander e Zapruder Filmmakersgroup
Habemus Papam? (15’)
(dal progetto Heliogabalus)
installazione per video e macchine del suono
posti limitati prenotazione obbligatoria
Homo varius sol it arius
Mostra fotografica itinerante di reperti e icone imperiali
(218 d.c. - 2006 d.c.) di Enrico Fedrigoli
In collaborazione con il Cassero - LUO
Luci del Nord: Ibsen tra film e video
Sabato 6 maggio ore 21
Chiesa di San Mattia
Teatrino Clandestino
Hedda Gabler
Performance per un’attrice, pianoforte e nastro magnetico
Posti limitati, prenotazione obbligatoria
7/8/9/10 maggio dalle 16 alle 20 – 11/12/13 maggio
dalle 16 alle 19
Hedda Gabler
Performance per un’attrice, pianoforte su nastro magnetico
11/12/13 maggio ore 21
Si prega di non discutere di Casa di bambola
Live, durata 20’; posti limitati, prenotazione obbligatoria.
arti visive
Sarah Moon: incontro a Andersen
Personale di Sarah Moon
Inaugurazione venerdì 5 maggio ore 19
I film saranno proiettati in loop fino al 12 maggio.
Orari: martedì-sabato, 10.30-19.30 continuato
Galleria TA MATETE
Proiezione dei film Circuss e L’Effraie
incantevole traduzione cinematografica di due fiabe di Hans Christian Andersen: La piccola fiammiferaia (Circuss) e Il soldatino di stagno (L’effraie). (versione originale con sottotitoli in inglese)
Sarà presente l’artista. Introducono Carola Scanavino e Luca Scarlini.
Biblioteca Sala Borsa Ragazzi
Sabato 6 maggio ore 10.30
Sarah Moon incontra il pubblico di Sala Borsa Ragazzi.
Introduce Luca Scarlini
in collaborazione con Fieri di leggere
Personale di Pierre Coulibeuf
In collaborazione con Xing - Silvia Fanti
12 maggio ore 22.30
Cinema Lumière 1 (ingresso 6 euro)
Pierre Coulibeuf presenta
Klossowsky peintre esorciste (Fra/1987-1988/25’)
Les guerriers de la Beaute (Fra/2002/71’)
regia di Pierre Coulibeuf
(versione originale con sottotitoli in inglese)
Introducono Silvia Fanti e Sandra Barrere
Maison Française de Bologne, Délégation française
13 maggio ore 22.30 (ingresso 6 euro)
Cinema Lumière 1
Pierre Coulibeuf presenta
Balkan Baroque (Fra/1999/63’)
Somewhere in between (Fra/2004/70’)
regia di Pierre Coulibeuf
(versione originale con sottotitoli in inglese)
Introduce Silvia Fanti
incontri
9 maggio ore 19.00
Il Cassero - Gay and Lesbian Center
LUO - Libera Università Omosessuale
Il Barocco: un genere
con immagini video da opere barocche dedicate
al tema dell’incertezza di genere.
Conferenza-spettacolo di Luca Scarlini.
Partecipano Laura Coci e Roberta Colombi
Preview
20-21 e 27-28 aprile, ore 19
Video preview con aperitivo
in collaborazione con
La Scuderia, Zo’ Caffè, Sesto Senso, Stile Libero
Videoblitz
5-6 e 12-13 maggio, dalle ore 19
Percorsi video in città
a cura di EFFETTICA
in collaborazione con La Scuderia, La Linea,
ArtigianArte, Zanarini, Legambiente Emilia Romagna,
Galleria TA MATETE
Video-focus: France
4 maggio ore 19.00
in collaborazione con Danielle Londei - Alliance Francaise
Proiezioni di videodanza francese
Concorso Italia
3 Maggio ore 18.00
Sala Gino Cervi (ingresso libero)
Qualcuno arriverà
regia di Pietro Lassandro (2006/19'40'')
Seize
regia di Gianluca Bonomo (2005/10')
Na specie de cadavere lunghissimo
regia di Giuseppe Bertolucci (2005/70')
Body Electric # 1
regia di Davide Pepe (2005/4'04'')
Panorama_Roma
regia di Zimmer Frei (2004/24')
Il tempo che resta
regia di Snejanka Mihaylova (2005/37'05'')
Mighty Mighty UBU
regia di Giovanni Belvisi e Alessandro Renda (2006/30')
4 Maggio ore 17.30
Sala Gino Cervi (ingresso libero)
Pasodoble // doble
regia di Kinkaleri (2005/47')
Senza Paura
regia di Ascanio Celestini (2004/40')
Appunti per un esserci
regia di Monica Petracci (2006/4')
Ultima scena
regia di Cristiano Carloni e Stefano Franceschetti (2005/30')
Morning Smile
regia di David Zamagni e Nadia Ranocchi (2005/30')
Sotto quel che abbiamo costruito - Immagini dal Teatro del Pratello
di Silvia Storelli (Ita/2004/30')
5 Maggio ore 16.30
Sala Gino Cervi (ingresso libero)
Madre e assassina
di Pietro Babina (2006/76')
Pinocchio Nero, regia di Angelo Loy, dall'omonimo spettacolo di Marco Baliani (2005/80')
6 Maggio ore 19.00
Sala Gino Cervi (ingresso libero)
Premiazione
a seguire buffet
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento dello Spettacolo
Regione Emilia - Romagna - Assessorato alla Cultura
Provincia di Rimini - Assessorato alla Cultura
Riccione TTV Festival - La scena e lo schermo è prodotto
da Riccione Teatro
Comune di Riccione
Provincia di Rimini
in collaborazione con Cineteca del Comune di Bologna, Assessorato alla Cultura del Comune di Bologna, Galleria TA MATETE, Cassero - Gay and Lesbian Center, LUO - Libera Università Omosessuale, Bologna Festival, Biblioteca Sala Borsa Ragazzi, Fieri di leggere, Bologna per Mozart, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna, Galleria Neon, Biblioteca Renzo Renzi, Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale di Roma, Maison Française de Bologne, Délégation française, Alliance Française di Bologna
con il contributo della Reale Ambasciata di Norvegia a Roma, del Forum Austriaco di Cultura a Milano, dell’ Ambasciata di Francia a Roma e il patrocinio del Comune di Bologna, dell’Ambasciata di Danimarca a Roma
Ufficio Stampa Pepita Promoters snc
Informazioni
Riccione TTV Festival - La scena e lo schermo
tel. 051 204726 Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
ttv@riccioneteatro.it ttv@comune.bologna.it
Prenotazioni
a partire dal 18 aprile: da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 13
tel: 051 204726
ttv@comune.bologna.it ttv@riccioneteatro.it
Luoghi
Cinema Lumière
Via Azzo Gardino, 65 - Bologna
Tel. 051 523812 www.cinetecadibologna.it
Sala Gino Cervi
Via Riva di Reno, 72 - Bologna
Centralino Cineteca: 051 2194820
Galleria TA MATETE
Piazza Santo Stefano, 17/a Bologna
tel. 051 6488920 www.tamatete.it
Biblioteca Sala Borsa Ragazzi
Piazza Nettuno, Bologna
tel. 051 204444 www.bibliotecasalaborsa.it
Il Cassero, Gay Lesbian Center
LUO, Libera Università Omosessuale
Via Don Minzoni 18 - Bologna
tel. 051 6494416 www.cassero.it
Galleria Neon
via Zanardi 2/5 a Bologna
tel. 051 5877068
Chiesa di San Mattia
Via Sant’Isaia 14a - Bologna
tel. 051 203040
Biblioteca ‘Renzo Renzi’
Via Azzo Gardino, 65 - Bologna
tel: 051 2195307
In aggiunta ai programmi in proiezione sul grande schermo sarà a disposizione del pubblico un’ampia scelte di opere video provenienti dall’archivio di Riccione TTV Festival visionabili presso la Biblioteca Renzo Renzi, Via Azzo Gardino, 65 tel. 051 2195307,
dalle 10.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì
Cesare Lievi riconfermato direttore del Centro Teatrale Bresciano
Alla guida delo stabile da dieci anni
di Redazione ateatro
Il consiglio d’amministrazione del Centro Teatrale Bresciano ha riconfermato Cesare Lievi alla direzione artistica del teatro. Sono ormai dieci anni che Lievi dirige lo stabile bresciano: la riconferma non è stata facile, stando ai “si dice”, ma il regista è riuscito a raccogliere una maggioranza trasversale che gli ha garantito la riconferma.
Tra i direttori degli stabili, Lievi è tra i più stabili. Ma difficilmente riuscirà a raggiungere il recordman Marco Bernardi, dal 1980 alla guida dello Stabile di Bolzano.
Il non-lavoro del teatro
A Livorno, a cura di Concetta D'Angeli
di La Casa del Teatro
promosso dal Comune di Livorno
con il patrocinio del CMT di Pisa e dei DAMS di Bologna e Torino
presso il Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno
(via G.M.Terreni, 5. Telefono: 0586/404021)
Giornata d’apertura a cura di Concetta D’Angeli:
mercoledì 3 maggio, ore 17.00:
Concetta D’Angeli, Conversazione con Sandro Lombardi
Dalla ricerca iconografica alla pratica attoriale
Discussione attorno al libro Gli anni felici. Realtà e memoria
nel lavoro dell’attore (Milano, Garzanti, 2004)
Laboratorio a cura del DAMS di Bologna:
da giovedì 18 a sabato 20 maggio, ore 16.00-20.00:
Marco De Marinis, Il non-lavoro dell’attore nel ‘900 tra
professionismo e nuovo dilettantismo
da martedì 23 a giovedì 25 maggio, ore 16.00-20.00:
Marco Martinelli, La canzone degli F.P. e degli I.M.
giovedì 25 maggio, ore 21.30:
dimostrazione-spettacolo da
La canzone degli F.P. e degli I.M. di Elsa Morante
Laboratorio a cura del DAMS di Torino:
da lunedì 5 a mercoledì 7 giugno, ore 15.00-20.00:
Roberto Tessari, Il lavoro dei ciarlatani
affiancato da
Enrico Bonavera, Il mestiere del ciarlatano:
l’uso della dialettica
mercoledì 7 giugno, ore 21.30:
Enrico Bonavera in I racconti di Arlecchino
Seminario a cura di
Associazione X-Lab Digital Project:
venerdì 6 ottobre, ore 17.00:
Anna Maria Monteverdi, Il lavoro multimediale a teatro
affiancata da
Andrea Balzola, Mauro Lupone, Pierpaolo Magnani
Laboratorio a cura del CMT di Pisa:
da lunedì 9 a mercoledì 11 ottobre, ore 16.00-19.00:
Concetta D’Angeli, Riscritture teatrali: i modi e le forme
da giovedì 12 a sabato 14 ottobre, ore 16.00-19.00:
Armando Punzo, Da Brecht ai Pescecani, ovvero
riscrivere il teatro
sabato 14 ottobre, ore 21.30:
dimostrazione-spettacolo di Armando Punzo

