L'editoriale di ateatro 60
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and1
Una questione critica
Il dibattito sulla "critica impura"
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and2
Il critico impuro*
dallo "Straniero", ottobre 2003
di Fabio Acca, Carla Romana Antolini, Andrea Lissoni, Andrea Nanni, Barnaba Ponchielli, Rodolfo Sacchettini, Cristina Ventrucci
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and3
Lettera aperta ai "critici impuri"
Sul documento apparso su "Lo Straniero", ottobre 2003
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro58.asp#58and40
Caro Oliviero
La risposta alla lettera aperta allo "Straniero" sul critico impuro
di Fabio Acca, Carla Romana Antolini, Andrea Lissoni, Andrea Nanni, Barnaba Ponchielli, Rodolfo Sacchettini, Cristina Ventrucci
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and5
Ri-connessioni
Prosegue il dibattito sulla critica
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and6
Due foto tessera e alcune parole di troppo
sul Teatro della Valdoca
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and10
Le recensioni di "ateatro": Tragedia Endogonidia R.#07
Il ciclo della Socìetas Raffaello Sanzio fa tappa a Roma
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and20
Un teatro a cavallo del '68
Margherita Becchetti, Il teatro del conflitto. La compagnia del Collettivo nella stagione dei movimenti. 1968-1976, Edizioni Odradek, 2003
di Carla Pagliero
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and30
Marco Paolini (ri)monologa in tv
Il pezzo su Bhopal a Report su Raitre
di Fernando Marchiori
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and40
FAQ-frequenze anti quiete a Sarzana
A cura di "Cut up" dal 20 al 30 novembre 2003 ore 17,30 e 21
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and80
La prima monografia sulla Valdoca
Teatro Valdoca a cura di Emanuela Dallagiovanna, Rubettino Editore, Soveria Mannelli (CZ), 2003
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and81
Un epitaffio per la Raffaello Sanzio?
Socíetas Raffaello Sanzio-Romeo Castellucci, Epitaph, Ubulibri, Milano, 2003
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and82
Le novità di novembre su dramma.it
Con il testo vincitore del premio "Vicini sconosciuti"
di www.dramma.it
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and83
Raiot, censurato dalla Rai, rivive in teatro
Domenica 23 a Roma e in tutta Italia una serata da non perdere
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and88
Che cos'è il Dramaturg e perché in Italia non esiste?
"Walkie Talkie" ne discute a Milano
di Teatro Aperto
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and90
Un concorso di idee per Alfieri
Il comunicato e il bando
di Commissione Artistica di AstiTeatro 26
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and91
Nuovo teatro e nuovi autori: se ne discute a Riccione
Il 13 dicembre l'incontro "Per un teatro d’autore. Progetto e nuove prospettive per il Premio Riccione"
di Riccione Teatro - Fabio Bruschi
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and92
Che succede alla Biennale?
Appunti a margine
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and93
I vincitori dei Premi Ubu 2003
La premiazione lunedì 1 dicembre al Piccolo Teatro di Milano
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and94
Una collana di libri dedicati alle fotografie di Tommaso Le Pera
Si parte con il volume dedicato agli spettacoli pirandelliani
di Redazione ateatro
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and95
La critica & Cesena
L'editoriale di ateatro 60
di Redazione ateatro
ateatro 60 è un numero scritto-scritto – & del resto si parla molto di critica teatrale.
Tutto è cominciato con il documento di un gruppo di giovani critici e operatori (Fabio Acca, Carla Romana Antolini, Andrea Lissoni, Andrea Nanni, Barnaba Ponchielli, Rodolfo Sacchettini, Cristina Ventrucci), da cui è nato un piccolo dibattito via e-mail (il tutto lanciato & ripreso sulla rivista "Lo Straniero"). Le questioni sul tappeto sono numerose e (ci pare) interessanti: gli interventi pubblicati in questo ateatro sono soprattutto un invito alla discussione e al confronto. Perché come sempre le domande sono più importanti delle risposte.
Poi un po’ per caso e un po’ perché niente accade per caso, questo numero è dedicato anche a una delle capitali mondiali del teatro, la Cesena della Socìetas Raffaello Sanzio e del Teatro della Valdoca. Intanto perché sono usciti due libri che ne ripercorrono l’intero percorso artistico: soprattutto testi per la Valdoca, soprattutto immagini per la Socìetas. Prima di correre in libreria a comprarvi i volumi, però, leggetevi i due testi di Oliviero Ponte di Pino che compaiono in questo ateatro: il saggio sul percorso della Valdoca, pubblicato nel volume dedicato al gruppo (dove c’è molta altra roba, sicuramente più interessante), e la testimonianza (è più chic di recensione, vero?) sulla discussa tappa romana del megaprogetto della Tragedia Endogonidia.
Ma non è tutto: Fernando Marchiori ha ri-visto live il monologo di Marco Paolini su Bhopal che avevamo visto in televisione qualche settimana fa a Report e riflette sul rapporto tra teatro e tv; Carla Cagliero recensisce il saggio che Margherita Becchetti ha dedicato alla Compagnia del Collettivo a cavallo del ‘68.
Ancora, tante news e molti post nei forum – con un occhio di riguardo a quello che succede alla Biennale e a Genova (capitale europea della cultura 2004) e sul fronte della censura... Andate, leggete e dite la vostra.
Una questione critica
Il dibattito sulla "critica impura"
di Redazione ateatro
Nel numero di ottobre 2003 la rivista «Lo Straniero» ha pubblicato un testo di alcuni giovani studiosi e operatori teatrali (Fabio Acca, Carla Romana Antolini, Andrea Lissoni, Andrea Nanni, Barnaba Ponchielli, Rodolfo Sacchettini, Cristina Ventrucci), frutto di una discussione tenuta a Prato nell'ambito della rassegna «Contemporanea 03». Da questo intervento è nato un piccolo dibattito via mail, ripreso nelle sue prime tre parti dalla rivista diretta da Goffredo Fofi.
Le questioni sul tappeto sono già numerose, e ne potrebbero entrare in gioco altre. Per esempio, l’«impurità» del critico, a chi ha qualche anno di più, rimanda piuttosto allo «sporcarsi le mani» del critico militante che non si limita a dire e scrivere la sua, ma partecipa attivamente alla promozione e diffusione del teatro in cui si riconosce e che ama e sostiene. L’organizzazione di rassegne e festival, la partecipazione a giurie e concorsi, ma anche le consulenze a commissioni per l’assegnazione dei finanziamenti, la stesura di testi per programmi di sala sono tutte attività (più o meno remunerate) che rientrano in questo ambito e che possono anche generare conflitti di interesse, diciamo.
Un altro tema appena sfiorato è quello delle forme e dei luoghi della critica: ma già lo sconfinamento in un ambito organizzativo (se non addirittura la scelta di diventare «compagni di strada» di una compagnia o di un teatro, lavorando , anche a libro paga presso l’ufficio stampa o alla promozione del pubblico) offre una risposta implicita (anche se parziale) alla domanda.
Qui di seguito i link a questi tre interventi e alla ulteriore replica di Oliviero Ponte di Pino e qualche ulteriore suggestione. Ma ovviamente il dibattito è aperto anche ad altre voci.
Il critico impuro
dallo "Straniero", ottobre 2003
di Fabio Acca, Carla Romana Antolini, Andrea Lissoni, Andrea Nanni, Barnaba Ponchielli, Rodolfo Sacchettini, Cristina Ventrucci
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and3
Lettera aperta ai "critici impuri"
Sul documento apparso su "Lo Straniero", ottobre 2003
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro58.asp#58and40
Caro Oliviero
La risposta alla lettera aperta allo "Straniero" sul critico impuro
di Fabio Acca, Carla Romana Antolini, Andrea Lissoni, Andrea Nanni, Barnaba Ponchielli, Rodolfo Sacchettini, Cristina Ventrucci
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and5
Ri-connessioni
Prosegue il dibattito sulla critica
di Oliviero Ponte di Pino
http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro60.asp#60and6
Se volete ancora un po’ di documentazione, ecco qualche spunto:
> i punti 14. e 15. di Ivrea 87. Realtà e utopie. Intorno al "nuovo teatro" di Gianfranco Capitta, Gianni Manzella e Oliviero Ponte di Pino
> Il senso della critica (con interventi di Arbasino, Aulenti, Barba, Barberio Corsetti, Barilli, Bene, Bergonzoni, Branciaroli, Calvesi, Chiesa, Cirio, Costanzo, De Berardinis, Degli Esposti, Dorfles, Einaudi, Fabbri (in il Patalogo 18, Ubulibri, Milano, 1995, p 115).
> La crisi della critica (in il Patalogo 17, Ubulibri, Milano, 1994, p 92).
> Critica autocritica & metacritica (in il Patalogo 7, Ubulibri, Milano, 1984, p. 182).
> Franco Quadri, L’Autoritratto del critico da nomade (in il Patalogo 3, Ubulibri, Milano, 1984, p. 148).
Il critico impuro*
dallo "Straniero", ottobre 2003
di Fabio Acca, Carla Romana Antolini, Andrea Lissoni, Andrea Nanni, Barnaba Ponchielli, Rodolfo Sacchettini, Cristina Ventrucci
Questo testo è stato pubblicato su "Lo straniero", ottobre 2003.
Approcci impuri
Esiste ancora il mestiere del critico? La società sembra considerarlo superfluo e improduttivo, a volte fastidioso, ininfluente se non a livello di piccoli e miserabili potentati. D’altro canto, gran parte dei critici si limita a piangere sul poco spazio dedicato (dai giornali e dagli altri media) al teatro, accusando la latitanza del pubblico in una sterile e vittimistica difesa del proprio orticello, annaspando tra contributi informativi e censori, minati dal falso efficientismo della comunicazione, aggrappati a criteri di giudizio logori e sclerotizzati. Eppure, come gli artisti riescono a conquistare spazi e a costruire altri percorsi, così il compito del critico sembra quello di far valere la propria inutilità, rinnovandosi e nutrendosi di teatro ma anche di altre discipline (anche in questo caso gli artisti offrono spesso un valido esempio). La frequente difficoltà a trovare un buon articolo o un buon saggio piuttosto che uno spettacolo significativo è il segno evidente di una vitalità che si manifesta sulla scena e che pare irrigidirsi sul versante critico. Nel migliore dei casi la critica si mostra derivativa rispetto al lavoro degli artisti, non trovando le forze per ricostituirsi in autonomia e per restituire nuovo significato a un linguaggio spesso usurato e inefficace. Eppure oggi più che mai appare impossibile dividere "arte" e "parte": lo sguardo dichiaratamente partigiano e parziale si conferma il più onesto e pro-vocatorio, l’unico in grado di assumere una precisa posizione etica nei confronti del presente, posizione imprescindibile per leggere il reale attraverso il teatro e viceversa, per distinguere il valore testimoniale di un’opera nel dilagare dei flussi modaioli. Oggi più che mai appaiono necessarie mobilità di sguardo, coscienziosa pratica dell’azzardo e umiltà nel confrontarsi con le innovazioni avvenute sul piano del linguaggio. In un orizzonte teorico segnato da una fragilità costitutiva, il compito del critico sembra quello di muoversi in direzione di un'impurità di approccio che permetta di indagare la realtà attraverso sguardi molteplici. Un approccio impuro si nutrirà dunque di teorie diverse, anche contraddittorie, secondo un respiro che non cerchi ancoraggi e sia disponibile a coniugare in maniera inedita stimoli provenienti da diverse discipline. In bilico su una soglia in continuo spostamento, il critico impuro si muove senza bussola, navigando a vista, tracciando orbite irregolari e paradossali. In questo procedere per approssimazioni, libero dall'ansia sterile della definizione, o per meglio dire dell’etichetta, il critico appare l’opposto dello specialista, non settario e settoriale, ma disposto a farsi spostare e a rimettere a fuoco la propria percezione.
L’esercizio della critica
Forse il compito è soprattutto quello di proporre visioni. Aprire possibili (umanamente imperfetti) percorsi di letture e di sguardi a partire dalla scena e verso il mondo. In questo l’esercizio della critica è avvicinabile a quello dei programmatori più intraprendenti e consapevoli. Cercare di segnare dei tracciati di senso che s’innescano da una singola opera o – più difficile ma ancora più affascinante – da una sequenza, rafforza, sostiene e problematizza il lavoro di autori e programmatori: genera, crea e dà forma a un ambiente. Naturalmente non si tratta di un esercizio di marketing da condurre secondo una logica ormai esaurita di ricerca di ricorrenze, contiguità e similitudini fra oggetti (opere) più o meno contemporanei. Il punto è proporre visioni forti, sì di eventuali corrispondenze o relazioni fra oggetti, ma fondate anche sulle discrasie, le distanze, le opposizioni, con sullo sfondo lo scenario sia della creazione (e del suo stato) sia del reale. L’obiettivo è quello dell’apertura su un mondo e sulle sue ragioni d’essere e, contemporaneamente, sulle potenziali ragioni d’essere rispetto al presente, al reale. Un tracciato basato sull’onestà intellettuale e la sincerità, capace di fornire al pubblico le motivazioni per seguire o prendere in considerazione uno spettacolo dal vivo. Non sempre, anche per l’evidente molteplicità di forme della creazione, l’empatia fra autore e pubblico è dato certo o scontato. Lo scarto, la distanza, la differenza, il vuoto e il disagio nell’ambito della sfera della ricezione, sono in ogni modo anche segnali di una continuità e di una relazione con una tradizione della ricerca. La scena è fatta di segni. Si tratta di elementi da inquadrare, evidenziare, tradurre, nel senso etimologico del termine, e interpretare. I segni, quei segni esistono. Accertata l’autenticità del processo che li genera – ed evidenziato che siamo, con grande probabilità, fuori da una dialettica della modernità scandita da innovazione e suo consolidamento in tradizione – resta da affrontare quei segni e ricombinarli, distanziandosi anche dalle fonti e dalle ombre della poetica degli autori. La loro ricomposizione in una traccia non necessariamente inedita ma percepibile come una visione, come frutto di uno sguardo, è la migliore premessa per una relazione con lo spettacolo e le arti della scena che sia autentica e soprattutto aperta. Come pubblico prenderemo forse le distanze, ma riconosceremo uno sguardo, un taglio dell’orizzonte possibile e, senz’altro, pur nel rispetto della differenza individuale, una corrispondenza con un "ambiente". Un ambiente che sarà multiplanare, fondato su asincronie, atopie, incongruità e corrispondenze. Di qui, per chi cerca un ambiente e per chi lavora a generarlo, la potenzialità e l’arricchimento del confronto extradisciplinare, per quanto disciplinato. Relativizzare, dichiarare il proprio cambiamento d’opinione o l’errore, la rivalutazione alla luce di…, è l’unica attitudine possibile per rigenerare il proprio sguardo e mettere costantemente in gioco la propria attendibilità. Del resto, lavorare tenendo conto della sensatezza del proporre visioni, ha il vantaggio di esporsi, mettendo in gioco la propria lettura della scena ma anche e soprattutto quella del contemporaneo. Di qui, un passaggio evidente. Il lavoro critico si dichiara direttamente politico.
La politica delle forme
Se l’artista può essere considerato la coscienza della sua epoca e del suo tempo, colui che prima di altri intuisce le trasformazioni, allora il valore politico dell’esercizio critico non può non confrontarsi con la responsabilità dell’essere testimone dei fermenti in atto, individuabili nelle forme del teatro. L’espressione artistica, intesa come creatrice di immaginario, libera da debiti con la cronaca o con il contingente, risulta una fertile chiave di lettura del mondo contemporaneo. Il carattere prismatico e polimorfo dell’organismo spettacolo ha un imprescindibile valore politico quando riesce a realizzare nel suo complesso la negazione di identità particolari, stabili e solide, identificandosi piuttosto nella loro mutevolezza. Nel mostrarsi, le forme contengono il rapporto di complicità tra diversi linguaggi, il percorso di chi le ha pensate e realizzate, il dialogo con ciò che è già avvenuto sulla scena fino a quel momento, ma anche le modalità produttive che le caratterizzano e lo spostamento che propongono nell’interrogarsi sull’esistenza individuale e collettiva. C’è un forte aspetto politico negli organismi che rimettono in discussione le regole del gioco e il rapporto con la platea, dove l’estetica non è un’entità separata rispetto ai conflitti e alle contraddizioni della realtà. La politica, liberata dal rischio di ridursi a comunicazione o informazione, diviene atto che si misura con contraddizioni e domande senza risposta, rendendo la scena termometro della trasformazione contemporanea. D’altro canto l’onestà intellettuale a cui il critico è chiamato richiede una presa di posizione politica in rapporto alla tradizione, intesa non come mera usanza ma come viva trasmissione di cultura. In quanto osservatore privilegiato, il critico teatrale ha il compito di rivolgersi ai suoi interlocutori non per consegnare loro un senso compiuto e consolatorio, ma per sollevare questioni e rilevare fratture.Il valore dell’esercizio critico appare allora strettamente legato alla sostanza di una scrittura capace di ospitare diverse tensioni, in bilico tra la necessità di forgiare nuovi strumenti e di rivitalizzare, quando è possibile, quelli usurati.
Sul linguaggio
Intendendo il critico come figura dello sguardo e dello scavo anziché del giudizio, figura parziale e partecipe anziché distante e illusoriamente obiettiva; considerando il lavoro di osservazione e scrittura una possibilità a sua volta creatrice di mondi, di ambienti e cortocircuiti, l’importanza di una particolare attenzione al linguaggio risulta consequenziale. Scelto il teatro d’arte come unico ambito scenico che si voglia nominare teatro – scelta che restringe assai l’area di riferimento e che pensa più a una comunità di addetti e appassionati, o comunque a un’area riflessiva e impegnata, piuttosto che a un lettore indistinto o di mercato (non essendo oggi il teatro luogo dell’attenzione collettiva) – ci si allontana dall’idea di una funzione didattica e demagogica della critica, per concentrarsi sulla potenzialità maggiore di un linguaggio personale, strettamente legato sul piano lessicale agli argomenti e alla natura di ciò che va a illustrare, e produttore a sua volta di immagini e immaginari. Il riferimento a una comunità teatrale ristretta non giustifica in alcun modo, secondo questa visione della critica, atteggiamenti di difesa, spirali allusive, costruzioni di potere; considerando fondamentale lo sviluppo di un dibattito, si auspicano assunzioni di responsabilità, affermazioni leggibili e ampiamente argomentate, disponibilità all’ascolto. Così come i criteri di sguardo, anche i criteri di scrittura, di indagine, di esposizione, esprimono il valore politico dell’esercizio critico, valore assolutamente intrinseco alle modalità di espressione. Non interessa l’esibizione colta fine a se stessa, né la forzata produzione di neologismi. Lungi dalla smania del nuovo, il critico che si pone ogni volta di fronte a un vuoto, ogni volta si interroga sulla propria parola, mescolando intelletto e sensi, etimologia e sonorità, desiderio di trasparenza e adesione al materiale artistico di cui sta trattando. Si proporrà così come massimamente onesto ed espressivo il linguaggio che maggiormente esprima una personalità, che esplori paesaggi individuali e che rifacendosi insieme all’esperienza personale, all’oggi e all’oggetto del parlare, da particolare si faccia universale. È un linguaggio che contempla, che fa della scena il proprio orizzonte, che respira all’unisono con le domande poste dal teatro. Il critico impuro, non ristretto alla recensione (troppo spesso spacciata per ultimo e unico baluardo da opporre alla deriva), confuso tra arte e mondo reale, disinteressato al mercato ma difensore di uno spazio della ricerca e dell’intraprendenza, impegnato nel fare, contrario alla ghettizzazione ma consapevole di una solitudine dell’arte e dello sguardo, interessato al farsi arte di certe vite, procede a un inseguimento del teatro piuttosto che all’atto violento e sterile di portare il teatro al proprio punto fermo; invece che interpretare, si lascia destabilizzare; invece che compilare pagelle, crea il proprio racconto; spostato sposta.
Un esempio: il rapporto tra sguardo critico ed esperienza teatrale
Se la critica cerca di cogliere i segnali della società teatrale vivente per poi ridistribuirli (anche) come valore personale, autonomo e indipendente, allora il teatro è un’amicizia complessa, che parla se viene interrogata in modo non convenzionale e sa sorprenderti se gli poni le giuste domande. Si potrebbe dire che il teatro è un alveare che custodisce il tesoro della propria capacità autorigenerativa in un labirinto di possibilità di discorso. Tutto sta nella disponibilità del critico a perdersi. Prendiamo la questione della dialettica tra "spettacolo" e "percorso verso lo spettacolo", o in altre parole tra "prodotto" e "processo". Nell’articolazione del rapporto tra sguardo critico ed esperienza teatrale, la dialettica tra "processo" e "prodotto" ha cominciato ad attraversare una crisi probabilmente destinata a tradursi in una prassi irreversibile, manomessa dalle istanze creative e produttive di alcune realtà teatrali. Il processo di emancipazione del nuovo teatro, e conseguentemente della nuova critica, ha indicato prima nello spettacolo come "scrittura scenica" e poi nel "processo creativo" i termini per una dialettica dello sguardo che tenesse conto di una concezione non gastronomica del lavoro teatrale, che indagasse l’esperienza nel teatro come un meccanismo mobile e complesso. Se rinominiamo in maniera un po’ barthesiana questi due termini rispetto alla dinamica percettiva che essi mettono in atto ("l’aperto" al posto dello spettacolo, come condizione di confronto con l’esterno; "il chiuso" al posto del processo creativo, come condizione di lavoro autoriflettente e analitica), ci accorgiamo che entrambi nascondono un obiettivo comune, quello di aderire – salvo casi rarissimi – a una produttività ultima e determinante che ha ancora nello spettacolo la sua condizione ideale, dove per spettacolo si intende la formalizzazione di un evento teatrale come stazione mirata di un processo creativo, l’atto conclusivo di un percorso. Questo fare così determinato subisce da diversi anni delle vere e proprie aggressioni, motivate da una parte da un valore puramente espressivo di fuoriuscita dal codice, dall’altra da una necessità produttiva che riorganizza il teatro in forme di esperienza sempre più ibride, che ne aprono il senso e i segni. Riconvertendo a proprio vantaggio la tradizione del nuovo, la società del teatro produce soluzioni performative e categorie del linguaggio che decentrano il discorso dai modelli dominanti dello "spettacolo" e del "processo". Piuttosto tendono a rinserrare simultaneamente questi termini, passando dallo spettacolo al "formato" e dal processo al "conduttore teatrale". Il formato implica sempre una relazione con uno spettatore in un dato spazio e in un dato tempo, mantenendo dunque l’elemento relazionale come fatto costitutivo dell’esperienza teatrale. Ciò che non lo rende sovrapponibile allo spettacolo è la morfologia dell’evento, sia perché si nutre di codici e immaginari sempre più spesso non direttamente legati al teatro, sia perché crea un tipo di relazione non sempre pienamente riconducibile al teatro, spesso usando come interfaccia dispositivi appartenenti ad altre tradizioni artistiche. Inoltre, se lo spettacolo nel codice produttivo del teatro è la stazione di sintesi di un processo creativo, spesso ultimo e definitivo, la produzione teatrale oggi sviluppa sempre più spesso forme produttive che sono l’emanazione di una corrente teatrale continua, un "sempre aperto" che rende visibili le diverse fasi di un processo creativo. E il formato, pur proposto come opera chiusa, conserva un valore intermedio di "studio", che l’artista valuta, analizza e col quale confronta risposte di pubblico e variazioni pertinenti rispetto a uno spettacolo conclusivo.
Una critica impura dovrà dunque adottare uno sguardo prismatico, non solo nell’accezione, ormai acquisita, di una diffusa transdisciplinarietà, quanto di una forma critica lamellare, intuitiva e analitica allo stesso tempo, in grado di individuare il valore teatrale anche se non coincide con un’identità dichiarata di genere e si riconosce piuttosto nell’estrema mobilità dell’esperienza teatrale. Con una parola già diventata teorema, si potrebbe definire il carattere di questa impurità nella capacità di rendere il proprio sguardo tanto nomade quanto lo richiede l’oggetto teatrale, fino a disperderlo senza nessun complesso di colpa nella frantumazione delle esperienze particolari degli artisti. Questo non significa affatto abdicare al teatro, piuttosto dichiararne la vivacità e individuarne la vitalità, la capacità di dialogare senza compromessi con altre forme artistiche senza perdere la propria incandescenza e identità.
Certe parole fuori moda (postilla)
Il ricorrere in questo scritto di alcune parole – umiltà, onestà intellettuale, sincerità, autenticità, responsabilità…, parole che facilmente potrebbero essere tacciate di vaghezza e di ambiguità, stigmatizzate come indicatori di una fragilità speculativa inabile a definire dettagli tutt’altro che trascurabili – è in realtà un atto di ottimismo, dato che nel sottrarsi all’enfasi compilatoria del legislatore, auspica la possibilità di un’intesa basata su un tutt’altro che generico gentlemen’s agreement, fondamento di comportamenti da declinare di volta in volta rispetto alla specificità e alla concretezza delle situazioni, in modo da garantire in ogni caso la maggior chiarezza e la maggior efficacia possibili.
*Questo scritto raccoglie le riflessioni emerse nel corso di un gruppo di lavoro sulla critica tenuto a Prato dal 10 al 12 giugno 2003 nell’ambito del festival Contemporanea03-Lo spettacolo e le arti delle nuove generazioni, realizzato dal Teatro Metastasio Stabile della Toscana.
Lettera aperta ai "critici impuri"
Sul documento apparso su "Lo Straniero", ottobre 2003
di Oliviero Ponte di Pino
Per leggere in testo clicca qui.
Caro Oliviero
La risposta alla lettera aperta allo "Straniero" sul critico impuro
di Fabio Acca, Carla Romana Antolini, Andrea Lissoni, Andrea Nanni, Barnaba Ponchielli, Rodolfo Sacchettini, Cristina Ventrucci
Le tue osservazioni giungono piacevolmente inattese in tempi di diffusa sordità, lacerata quasi esclusivamente dalle grida dei litigi o dai sussurri delle confidenze. Suscitare il desiderio di rilanciare il discorso è già un buon risultato per uno scritto che, lungi dall’avere ambizioni di completezza, non aspirava a essere – come tu scrivi – un "documento programmatico" e tanto meno un manifesto (come "Lo Straniero" ha scritto in copertina), quanto il resoconto di tre appassionate giornate di riflessione sulla critica. Tuttavia, il desiderio di far corrispondere al nostro incontro una riflessione comune su temi importanti e la necessità di sintesi determinate dall’obiettivo, hanno sicuramente contribuito a fare del nostro scritto un documento ambizioso, forse a posteriori un manifesto "latente": innanzitutto perché cerca di rompere la consuetudine all’isolamento in cui siamo cresciuti, ma anche perché tenta di delineare una prospettiva di pensiero che sfugga all’altra consuetudine dominante, quella del mugugno perennemente in bilico tra logica rivendicativa e resa al lamento. In questo senso, la discontinuità con cui si può declinare la nostra "impurità" ha un carattere di trasversalità, biografica e strategica a un tempo, dove per "strategia" non si intende la consueta (e demagogica) prassi del "fare gruppo", quanto piuttosto la consapevolezza che le condizioni dello sguardo sullo stato dell’arte teatrale vadano continuamente spostate, depistate, "aggredite". Il gruppo di Prato riuniva, per scelta del coordinatore Andrea Nanni, persone con un’età compresa tra i venti e i quarant’anni, non certo per delineare il profilo di una, anzi più generazioni "senza maestri", ma proprio per sperimentare l’esito di una condizione di riflessione diversa, ideata e realizzata in autonomia, senza cedere alla malinconia di cui tratta Carla Benedetti nel suo libro sul "tradimento dei critici". Se vogliamo è l’inizio (e l’indizio) di una condizione "micrologica", volta a sondare di volta in volta in maniera puntiforme, rispetto al presente e ai valori da esso espressi, modalità e oggetti del nostro – e altrui – abitare il teatro. Partendo da questo punto di vista, non possiamo condividere la tua "accusa" di aver rimosso dalla nostra riflessione l’orizzonte della Storia, quasi fossimo in debito di un relativismo attraverso il quale pesare ed esprimere un giudizio sugli oggetti culturali. Il nostro tentativo di rivitalizzare la pratica dell’esercizio critico non assume la prospettiva storicistica come chiave interpretativa privilegiata, né ha come scopo definire (che troppo spesso significa etichettare) movimenti e tendenze. La storia del teatro non è altro che una tecnica del pensiero, alle volte consolatoria, con la quale allineiamo le esperienze del passato con quelle del presente; e come tale, in quanto pura tecnica, spesso rischia di prendere il sopravvento sulle necessità dell’immediato, spostandole nel paradiso dei codici. Prendendo in prestito alcune parole da maestri occulti a noi cari, ci piacerebbe allo stesso tempo "dire di sì" alla Storia, per una questione di consapevolezza, ma contemporaneamente "dire di no", in modo che non si tramuti insensibilmente in una lente deformante. Il nostro è un sostare nel "frat-tempo", in quell’intervallo che è puro abbandonarsi "alle cose" del teatro.
Riguardo alla genericità con cui si parlerebbe della tradizione, più che procedere per aut aut (Giorgio Albertazzi o Giorgio Barberio Corsetti?) si tratta, a nostro avviso, di ricostruire un reticolo in cui molti degli artisti che tu citi – e naturalmente altri se ne potrebbero aggiungere o togliere – convivono, contribuendo alla formazione di un panorama complesso e variegato, in cui non si ricerca un’estetica da sposare a scapito delle altre, quanto un’energia trasversale e intermittente, capace di mantenere instabili e spiazzanti (ah, il fiore di Zeami!) i linguaggi messi in campo, illuminando percorsi assai diversi – Carmelo Bene e Luca Ronconi, tanto per riprendere ancora un tuo esempio – ma di pari importanza per la comprensione dell’attuale paesaggio teatrale. Nonostante possa apparire deludente a chi pensa, con logica assassina e modernista, che il "nuovo", l’invenzione, la ricerca siano monopolio esclusivo del dato anagrafico, il critico impuro rifiuta la gabbia generazionale come esclusivo sistema di discorso sull’oggi teatrale; così come è pronto a riconoscere i segni della tradizione in formati e artisti da essa apparentemente distanti. Non esiste un principio di organicità di genere o categoria teatrale che ne delineano facilmente il volto: di sicuro la tradizione è da intendersi come un repertorio di innovazioni e non come il semplice perpetuarsi di abitudini. Meldolesi docet nei suoi Fondamenti del teatro italiano quando contrappone tradizione e tradizionalismo, rilevando l’assenza di tradizione con cui l’intera cultura teatrale italiana dovrebbe fare i conti, assenza che non si può non avvertire – fortunatamente – come "problema aperto e irrisolto", in quanto richiede a ciascuno di costruirsi un proprio itinerario. Problema rispetto al quale tentiamo di sollevare nuove domande in un disordine generatore di stimoli e associazioni, in cui tradizione è trasmissione ma anche tradimento, interruzione, rottura.
Dici che trascuriamo l’aspetto politico e l’economia dello spettacolo. Oltre a essere temi che affrontiamo nel nostro scritto, individuandone echi e risonanze direttamente nell’aspetto formale così come nelle strutture produttive, troviamo che fondamentalmente questa sia una domanda di retroguardia. Non perché oggi le motivazioni politiche e le strutture economiche non agiscano più nella configurazione di un panorama culturale come quello della ricerca teatrale, quanto piuttosto perché si pone come domanda urgente nel momento in cui esiste una contrapposizione tra sistemi forti, cioè tra tradizioni culturali in grado di agire in modo decisivo sull’immaginario e il sistema simbolico collettivo. E questo è possibile appunto solo tra sistemi culturali ampiamente condivisi, come oggi la televisione o internet, o sarebbe ancora importante nel caso si parlasse di teatro di ricerca tra anni sessanta e settanta, quando aveva in Italia una forte capacità mitopoietica, anche e soprattutto in senso politico. È impressionante, ma oggi un videogioco è sicuramente un sistema più forte di quello teatrale!
Allora, in maniera forse paradossale, la tua domanda è il sintomo di una sfocatura storica, o di un’illusione, che permane nel vizio di credere che il sistema teatro sia intoccabile, necessario, e che al suo interno si giochi sempre e comunque una parte decisiva dei destini dei processi culturali. Il nostro, invece, è proprio il frutto di uno sguardo storico, se vogliamo disincantato, che ci porta ad affermare che il teatro d’arte, da tempo uscito dal circuito del grande mercato delle idee ha – purtroppo – perso quella valenza che ne faceva fino a trent’anni fa un sistema da contrapporre al teatro ufficiale. Oggi la realtà ne fa un mercato di nicchia, una piccolissima bottega che sopravvive – anche e proprio in virtù di questa sua condizione di marginalità economica – come territorio di iniziazione all’arte. Ne va salvaguardata con cura la vita e l’originalità, dedicandogli attenzione e creando paesaggi di riferimento in cui saldare le esperienze artistiche con quelle umane. Nel momento in cui il teatro non avesse più nulla da dire e non manifestasse più alcuna energia, ebbene, siamo pronti a occuparci d’altro (come del resto in parte già facciamo).
Quanto alle parole con cui ci è piaciuto giocare, mascherandoci da bravi ragazzi – "umiltà, sincerità, onestà intellettuale, autenticità, responsabilità" – non indicano certo delle qualità o delle medaglie di cui fregiarsi, e tanto meno metri di giudizio. Ci attrae la loro ambiguità, ne conosciamo la superficie liscia e la ruvidità nascosta, siamo consci dello svuotamento che hanno subìto, come tutte le altre del resto, ma non ci ha spaventato correre il rischio di essere fraintesi (lo si è comunque, spesso), e sono loro il nostro coltello. Abbiamo voluto ripescarle nel mondo dell’ingenuità (certo sì anche dell’ipocrisia, ma siamo impuri, a ognuno la propria coscienza), non per abbellirci ma per riportarle a una durezza (che senza dubbio fa rima con purezza) originaria, a una natura squallida, priva di conforto, e sono per noi un’altra forma di abbandono, l’abbandono del campionato del potere, della sfilata del più bello, del Natale in famiglia. Se umile è il basso, lo sporco, sincerità sta per solitudine, onestà ti porta dritto in galera (in senso metaforico ma non ne è escluso anche uno realistico), autenticità non giudica, ma crea lasciandosi giudicare dagli altri, e quanto a responsabilità, in effetti la più noiosa tra queste, fai tu. Sia chiaro però che non vanno certo a parlare di un "teatro che si ama" bensì di quello che talvolta in principio si odia ma che comunque non si esclude, perché sappiamo con Hillman che "non è bene sminuire ciò che non si comprende", e perché questo eventuale "tribunale della coscienza critica" è proprio all’opera su noi stessi, come tu hai precisato. Magari senza confondere il piano della purezza metodologica con quello della purezza morale. La debolezza di un quadro di riferimento e la fatica a trovare punti di appoggio, che ci rimproveri, sono infatti caratteri endemici dei nostri tempi: il ricorso ad approcci differenti e irregolari (anche a rischio di essere contraddittori e indisciplinati) è parte di uno sforzo costante a non ricadere in teorie tanto confortanti (in quanto univoche) quanto incapaci di leggere il mondo in cui viviamo. L'impurità dunque – intesa come contrario dello specialismo – consiste nella capacità di distaccarsi dalle opere e dai processi in aperta dialettica con il presente. E il teatro risulta uno dei possibili itinerari per suscitare domande e proporre visioni, una delle innumerevoli strade percorribili per attraversare gli interrogativi che costellano il nostro reale. Idem per la soggettività: nessuno di noi la considera una qualità; è piuttosto una condizione fisiologica che preclude la possibilità di "un osservatore neutrale, distaccato, oggettivo", un bagaglio da dichiarare per impostare una relazione chiara con i propri interlocutori. Quella che viene esaltata è invece la capacità di creare visioni forti, di stabilire connessioni (secondo il vecchio motto forsteriano only connect) che definiscano ambienti, di sviluppare l’esercizio critico secondo modalità che vadano aldilà della recensione "pura" (dai forum telematici a te cari fino a forme da inventare e già inventate in alcuni luoghi ai margini del mercato; tema questo che davvero, come tu proponi, vale sempre la pena esplorare). Si tratta di tessere un filo tra un evento di natura teatrale e il reale, tentare una via di attraversamento del contingente, individuare dei percorsi che siano frutto di uno sguardo, che affondino in un orizzonte di senso critico, culturale, contemporaneo. Non stiamo parlando di una ricetta pronta all’uso, ma di un possibile che si confronta con una galassia di gusto che negli ultimi anni si è generata e rigenerata coagulandosi intorno a precisi e svariati oggetti culturali. Si tratta di costruire contesto, fare riecheggiare significati e percorsi diversi non tanto per "catturare" quanto per incuriosire e suscitare un confronto con i propri interlocutori. Perché questo diventi possibile è però necessario uscire dai luoghi canonici e assumersi dei rischi offrendo visioni che riflettano posizioni, non solo prendendo posizioni che riflettano visioni. A volte la durezza della presa di posizione nasconde e offusca la visione alle spalle; l’io, la soggettività, qui stanno. Nella semplicità del non nascondersi dietro a una presa di posizione forte e soggettiva, ma nell’affermare la debolezza profondamente contemporanea del proprio sguardo.
Eccoci così alla tua domanda su quali possano essere "le forme e i luoghi dove si potrebbe (o dovrebbe) praticare l’esercizio critico", domanda in cui avvertiamo ancora una volta una forma di invadente determinismo, nel senso che l’impurità di cui parliamo si misura anche nella rivendicazione di una concreta modalità che non abbia in conto l’assegnazione di luoghi e forme specifiche del fare critica, o di una specificità dei luoghi di discussione. Fabrizio Cruciani ci ha insegnato che il teatro è una pluralità di luoghi possibili, una galassia che si disegna in unità solo perché chi la guarda è in grado, attraverso un esercizio di politica culturale, di riconoscere nei suoi segni brillanti una matrice comune. E questa unisona continuità/discontinuità produce anche cultura teatrale. Noi vorremmo fare nostro questo "anche", declinandolo sempre secondo un’economia dello spreco, contro un’economia funzionalista del capitalismo delle idee. Una dichiarazione di impurità della critica come ulteriore livello di rivendicazione politico-culturale.
Fabio Acca, Carla Romana Antolini, Andrea Lissoni,
Andrea Nanni, Barnaba Ponchielli, Rodolfo Sacchettini, Cristina Ventrucci
Ri-connessioni
Prosegue il dibattito sulla critica
di Oliviero Ponte di Pino
Cari amici,
intanto grazie della cortese risposta. E su molte cose sono d’accordo con voi, anche se a volte non capisco bene quello che dite. Magari è una bella frase e suona bene, però non mi è chiaro a cosa vi riferite, per esempio, quando dite che bisogna offrire «visioni che riflettano posizioni, non solo [prendere] posizioni che riflettano visioni. A volte la durezza della presa di posizione nasconde e offusca la visione alle spalle; l’io, la soggettività, qui stanno». Parlate del rapporto tra il critico e l’opera? Di quello tra passato e presente? Bisogna allenare una soggettività più forte o più debole? O la debolezza della propria forte soggettività?
Ogni tanto mi fate dire cose che non ho detto. Non ho scritto né penso «che il sistema teatro sia intoccabile» (o che sia l’unico orizzonte di riferimento), tanto è vero che personalmente posso permettermi (per ora) il lusso di restarne fuori e combatto da sempre per cambiarlo. Ma poi capita, per esempio, che molti dei gruppi che piacciono a me (& a voi) dentro a questo sistema entrino alla prima occasione, dopo questue e compilazione di moduli, perché a loro questa pare l’unica possibilità di sopravvivenza e crescita, anche economica (magari per produrre spettacoli che costano diverse centinaia di milioni e perciò faticano a girare). Dunque mi sembra utile far in modo che questo ingresso nella rutilante burocrazia ministeriale avvenga nelle migliori condizioni, per loro: questo implica una conoscenza dei meccanismi e dei rapporti di potere che regolano il sistema, prese di posizione nei suoi confronti e una consapevolezza del valore culturale di un’opera in relazione a esso.
Inoltre non penso che confrontarsi con la storia implichi necessariamente tutte le brutte pratiche anatomo-patologiche che dite. Penso piuttosto che confrontarsi con la storia significhi innanzi tutto essere consapevoli che la realtà (e dunque anche la realtà in cui si muovono gli artisti, e anche quei pezzi di realtà che sono le opere d’arte, e soprattutto le opere di un’arte civile e sociale come il teatro) sia attraversata da differenze, fratture e conflitti: voi che scrivete sullo «Straniero» lo sapete meglio di me. E’ anche sulla base della storia – continuo a illudermi – che si può decidere a che cosa dire «sì» e «no», e che cosa riprendere dalla tradizione, e come.
Magari un pizzico di consapevolezza storica può aiutarci a interferire con l’evoluzione del sistema, e a capire (a illuderci di capire) quel che succede sul palcoscenico della storia, senza dire dei «sì» e dei «no» istintivi, intuitivi e acritici, ma lavorando (anche) sulle contraddizioni interne del sistema.
Aggiungo che queste fratture e differenze – questi paradossi – attraversano anche le nostre soggettività, e prime tra tutte le soggettività critiche. Dunque lo spirito critico cerco di esercitarlo anche (e prima di tutto) proprio nei confronti della mia soggettività, che come giudice primo e ultimo non mi pare del tutto affidabile. Anzi, è proprio l’attività critica – quello che vedo e che trascende il mio orizzonte – che spesso mi obbliga a mettere in discussione la mia soggettività e i suoi valori.
Un altro problema riguarda lo statuto attuale del teatro. Scrivete che «il teatro d’arte, da tempo uscito dal circuito del grande mercato delle idee ha – purtroppo – perso quella valenza che ne faceva fino a trent’anni fa un sistema da contrapporre al teatro ufficiale. Oggi la realtà ne fa un mercato di nicchia, una piccolissima bottega che sopravvive – anche e proprio in virtù di questa sua condizione di marginalità economica – come territorio di iniziazione all’arte». Che cosa vuol dire? Una volta sverginato dal teatro, il giovane artista dove deve andare? Dopo questa educazione teatrale, come può crescere? Facendosi promuovere dentro il teatro ufficiale (che tanto non lo vuole)? Dedicandosi al cinema o ai videogames, che costituiscono «sistemi più forti»? Ovviamente sono domande retoriche (e ironiche), perché tanto ogni artista farà quel che gli garba. Credo che il problema sia piuttosto capire dove e come questa marginalità culturale ed economica possa costituire un valore. Altrimenti meglio davvero occuparsi di arti «adulte» e artisti «maturi» (e magari campare meno precariamente).
Ma forse non è questo il vero nocciolo del problema. Se quello che volete dire è che lo sguardo critico non deve restare ristretto all’interno del piccolo orizzonte del teatro, sono perfettamente d’accordo: benissimo uno sguardo impuro, che sappia aprirsi alla realtà e alle altre arti, che mescoli e contamini. Però mi pare una richiesta ormai ampiamente condivisa e generica. Ecco, è un po’ questo che mi lascia perplesso: la genericità dei propositi impuri, la mancanza di obiettivi da raggiungere e di ostacoli da superare, la timidezza nel fare i nomi dei «nemici» – a meno che non vogliate bene a tutti. Più di tutto questo, mi sembra vi interessi la messa a punto di un vostro atteggiamento per renderlo pubblico, e va naturalmente benissimo. Ma a me questa rivendicazione di identità, di metodo e di programmatica marginalità non basta.
Così come è un po’ troppo generico anche il fortunato motto forsteriano «only connect». Il gioco delle connessioni è meravigliosamente bello e affascinante; il problema è che in questo gioco – credo – non tutto è permesso. «Only connect» non dovrebbe essere un biglietto gratuito per una deriva infinita: immagino che anche per voi ci siano connessioni permesse e connessioni impossibili (o vietate?). La catena dei significati e delle associazioni non è del tutto libera, altrimenti si rischiano la gratuità, la vaghezza o il delirio. Allora mi illudo che le due o tre cose che ho citato prima possano aiutarmi a capire i limiti entro cui si può e deve muovere la lettura critica di uno spettacolo teatrale (ma anche, più in generale, di qualunque testo e forse della realtà). Anche in questo sta la responsabilità del critico.
Con affetto
Oliviero
Due foto tessera e alcune parole di troppo
sul Teatro della Valdoca
di Oliviero Ponte di Pino
Mariangela ha la dolcezza dei suoi occhi azzurri, ma più morbida. Ha la morbidezza di una voce dai toni vellutati e profondi, ma anche la forza interiore di una antica contadina che sa aspettare lo scorrere del tempo senza mutare. Quando la vedi per la prima volta pare un misto di timidezza e modestia, ma ti accorgi subito che sa ascoltare e capire i moti del cuore. Quando il volto le si illumina in un sorriso, spesso è per la sorpresa. Questa è la superficie. Ma là sotto, lontano, ti accorgerai che c’è una pietra nascosta e durissima, nera e lucida come ossidiana - ma che è un tesoro che nessuno può scoprire, forse neppure lei.
Cesare è appassionato e ombroso. Può essere feroce e fingere di non accorgersene, ogni tanto lo sguardo gli diventa sottile come una lama. Si sente in guerra con il mondo, e per questo mi è piaciuto subito. Ha bisogno di buttar fuori le sue ossessioni, è pronto a difendere quello in cui crede in quel preciso istante con tutta la sua testarda intelligenza, anima e corpo. Ti attacca a testa bassa - anche se magari pensi di essere d’accordo con lui. Quando ride, è una risata aperta, la testa si piega all’indietro, ed è come se solo in quei momenti gli fosse possibile essere d’accordo con il mondo. Invece è d’accordo con il mondo solo quando lavora, quando lotta e s’ammazza di fatica - e ammazza gli altri di fatica e di entusiasmo - per costruire i suoi spettacoli, quasi a bruciarsi nello sforzo, per buttare fuori e cancellare quello che ha dentro.
Il Teatro della Valdoca nasce allo snodo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del Novecento, in un momento di particolare vitalità della scena italiana. Sulla scia di Carmelo Bene e degli altri artefici delle cantine romane, oltre che sull’esempio degli innovatori della scena mondiale di quegli anni (da Jerzi Grotowski ed Eugenio Barba al Living Theatre, da Ariane Mnouchkine a Peter Brook) il teatro si emancipa dall’ipoteca letteraria che aveva caratterizzato la grande stagione della regia, da Strehler e Visconti ai loro epigoni.
Il punto di partenza è il rifiuto del testo - un testo pre-scritto da leggere, interpretare e rappresentare - come elemento fondante dell’evento spettacolare. Il primo postulato di queste variegate esperienze è che tutti gli elementi che concorrono all’evento teatrale devono avere uguale importanza e dignità: dunque in primo luogo lo spazio e il tempo in cui esso ha luogo, e poi i suoni (rumori, musiche ed eventualmente anche parole) e gli oggetti, e soprattutto i corpi degli attori. L’etichetta di "teatro immagine" segna il polemico radicalizzarsi di questa impostazione (i detrattori parleranno di un teatro del gesto e dell’urlo, insomma dell’inarticolato). L’etichetta definisce una forma di spettacolo che rifiuta o accantona il testo per concentrarsi su tutti questi altri elementi, riprendendo magari suggestioni delle performance e degli happening creati in quegli stessi anni da artisti partiti dalle arti figurative; e in ogni caso lavorando spesso sulla contaminazione tra le diverse discipline - mentre sullo sfondo si intravede l’utopia dell’opera d’arte totale.
Quel postulato non si limita a emarginare o escludere la parola, ma cambia radicalmente la prospettiva dei creatori di teatro e impone la fondazione di una nuova grammatica dello spettacolo. Se esistono collaudati metodi per analizzare e interpretare un testo letterario (dagli anni Sessanta furoreggiano il grimaldello marxista, sulla scia di Brecht, e quelli psicanalitico e semiotico-strutturalista), sembrano invece mancare strumenti e pratiche adeguati a gestire gli altri elementi che confluiscono nell’evento teatrale - e soprattutto i loro rapporti reciproci.
La scoperta di questa "terra incognita" - quasi una rivelazione - offre straordinari margini di libertà, a seconda degli elementi selezionati, del peso assegnato a ciascuno di essi, alle prospettive in cui vengono utilizzati, alla logica che sottende al loro intreccio e alla loro dinamica.
Dato che gli strumenti teorici sono ancora fragili, l’unica strada praticabile è quella tracciata dalle avanguardie storiche del Novecento. E’ un metodo di lavoro che fino alla fine degli anni Cinquanta sulle scene non ha ancora trovato sistematica applicazione, a parte le esperienze, rimaste prive di eredi, del teatro russo negli anni intorno alla rivoluzione d’ottobre e del Bauhaus negli anni di Weimar. Si procede - come nella sperimentazione scientifica - per tentativi ed errori. "Teatro laboratorio": così Grotowski aveva scelto di chiamare la sua compagnia. Prova dopo prova, esercizio dopo esercizio, improvvisazione dopo improvvisazione, spettacolo dopo spettacolo, inizia prima a condensarsi una grammatica (i vari elementi utilizzati negli spettacoli) che successivamente viene articolata in una sintassi che mette questi elementi in relazione dinamica. La consapevole formalizzazione di questi elementi definisce una poetica.
Uno degli aspetti più affascinanti dell’esperienza del nuovo teatro (non solo italiano) è proprio la ricchezza, diversità, potenza e coerenza interna delle diverse poetiche messe a punto da ciascun gruppo, che riflettono peculiari interessi, curiosità, metodi di lavoro, incontri. Perché una significativa conseguenza di questo approccio è la possibilità di arricchire progressivamente questa poetica - e questo linguaggio - di nuovi elementi e suggestioni, in un percorso di ricerca che da un lato è potenzialmente infinito. Mentre - se l’ispirazione è autentica - questa poetica resta sempre fedele al proprio nucleo vitale.
In questo scenario, il percorso del Teatro della Valdoca, animato da Cesare Ronconi e Mariangela Gualtieri, due ragazzi di Cesena che hanno studiato architettura a Venezia e s’interessano di arti visive (appassionandosi ad alcune esperienze contemporanee, ma anche affascinati dalla figuratività medievale e rinascimentale), è fin dall’inizio esemplare. Il gruppo nasce in una regione ad alta densità teatrale. In Romagna ha sede il Festival di Santarcangelo, che è osservatorio e punto d’incontro e di scambio del nuovo teatro italiano (non a caso proprio a Santarcangelo il gruppo ottiene la prima visibilità su scala nazionale e torna di frequente). A Bologna si sta insediando Leo De Berardinis. E proprio in quegli anni iniziano a crescere altre esperienze analoghe, dalla Societas Raffaello Sanzio (proprio a Cesena) alle Albe-Ravenna Teatro, in un "distretto teatrale" destinato a rivelarsi nel corso degli anni assai produttivo.
Alla metà degli anni Ottanta i primi lavori del gruppo (Lo spazio della quiete, 1983, Le radici dell’amore, presentato alla Biennale veneziana del 1984) colpiscono immediatamente il pubblico e la critica per la forza e la coerenza della poetica, frutto della estrema formalizzazione dei pochi elementi scelti e utilizzati.
Gli spettacoli sono chiusi in una scena-stanza, uno spazio dai confini definiti e pienamente controllato, in cui le luci disegnano rari oggetti, spesso caratterizzati dalla loro "naturalità": sassi o canne, creta o veli leggeri, collegati da geometrie e prospettive di puntiglioso equilibrio e precisione. La parola viene rifiutata a favore di una comunicazione che passa contagiosamente per sensazioni, emozioni e modulazioni a volte minime. In quest’orizzonte muto resta solo il ritmo del respiro, a dare l’eco lontana di un possibile senso.
Quello esplorato per successive variazioni è un universo per certi versi idilliaco, fuori dal tempo e dallo spazio - astratto dalla dimensione tragica della vita. Non si tratta però - e questo è chiaro fin dall’inizio - di un universo immune dal dolore: piuttosto si tratta di uno spazio solo momentaneamente «quieto», in cui la sofferenza può essere come sospesa - in una forma delicata e precaria. Quella poesia muta è il memoriale di un dolore indicibile, sospeso tra grazia e nostalgia. E’ anche evidente una forte dimensione rituale: i gesti delle attrici (perché le interpreti sono solo donne), anche nella loro semplicità, in quel silenzio sospeso e dilatato, assumono una dimensione sacrale, e paiono rimandare a una realtà trascendente.
Questo mondo idilliaco è un invito a praticare una forma di ecologia dell’anima. Quegli spettacoli fondano un luogo (non è un caso che la compagnia abbia scelto come insegna il nome di un posto - la Valdoca - anche se più immaginario che reale) a cui tornare, per rivivificarsi con la sua energia. Per certi aspetti i successivi lavori torneranno sempre ad abitare quel luogo, per trasformarlo, ridargli vita, esplorarlo nelle sue pieghe e risonanze segrete. Gli spettatori lo vedranno crescere e cambiare, magari volutamente sfregiato, per arricchirsi di nuove presenze e riflettere nuove inquietudini.
Da un certo punto di vista, il problema di quei primi spettacoli è che sono fin troppo perfetti: la formalizzazione è talmente spinta, la sintassi è così coerente che rischia di rinchiudere la poetica del gruppo in un universo chiuso e autoreferenziale, nutrito di un esasperato culto della bellezza, come a voler esorcizzare le sofferenze e le banalità del mondo. Tuttavia l’equilibrio di questa estetica astratta e fragile è inevitabilmente destinato a incrinarsi.
Nell’ambito della ricerca italiana, in quella fase paiono fronteggiarsi due tendenze: il filone del Terzo Teatro, che partendo dalla riscoperta del corpo operata da Grotowski e dal Living e teorizzata da Barba si misura con l’espressione dell’interiorità soprattutto attraverso dal lavoro sul corpo e sulla voce, per approdare spesso in una arcadia fuori dal tempo, vieppiù popolata di contenuti archetipici. Sull’altro versante opera la cosiddetta post-avanguardia, che in una fase di tumultuoso cambiamento della realtà sociale e dello scenario della comunicazione (in quegli anni inizia a definirsi il concetto di «mediasfera») utilizza gli strumenti del teatro e il metodo delle avanguardie storiche per appropriarsi della contemporaneità, in un vertiginoso gioco di contaminazioni. In questo scenario, il Teatro della Valdoca sembra utilizzare tecniche compositive più vicine a quelle delle neo-avanguardie (anche se con assoluto rigore) ma misurandosi con atmosfere cariche di risonanze mitiche e suggestioni rituali.
In questo - e in una maturità estetica raggiunta istantaneamente, e non attraverso un progressivo affinamento - il gruppo cesenate costituisce un unicum e si trova in una posizione per certi aspetti scomoda, sia per le aspettative che suscita sia per una poetica che confonde le etichette allora in voga.
Dopo quella folgorante fase aurorale, il percorso del Teatro della Valdoca si muove su due linee continuamente intrecciate. Su un versante si tratta di far riemergere le parole contenute in quei silenzi, latenti in quei respiri, per dare loro un corpo, la pienezza del loro senso. Ma come il mondo di quei primi lavori appare lontano da ogni quotidianità, da ogni realismo «contemporaneista», così la parola che riecheggerà in quel luogo non potrà essere banale chiacchiera, ma dovrà avere la profondità della poesia. Perché riaprire quel respiro, superare la muta vitalità dell’animale senza però perderne la verità, significa ritrovare parole sovraccariche di senso, il più possibile dense ed evocative.
Sull’altro versante si tratta di spezzare (o almeno sfregiare) quella bellezza così astratta e cristallina, di sporcarla, di ridarle il palpito di sangue e carne - per trovare un diverso grado di bellezza, che sappia pulsare anche nel dolore. In parallelo, questa grammatica si arricchisce via via di nuovi elementi, da mettere in tensione con quelli già acquisiti. Può essere una certa forma di ironia, o una esplosione di brutalità, o una sessualità quasi animalesca, primordiale; e naturalmente il testo poetico. A livello tematico, può essere l’eco di eventi contemporanei come la guerra, oppure l’Africa, o il mito di Parsifal, o il circo, o ancora l’inserimento di segni "moderni" all’interno dell’oggettivistica artigianale e arcaica che sono una delle firme registiche di Cesare... E sono ovviamente i nuovi attori e attrici da inserire nell’ensemble, con la loro vitalità e le loro qualità tecniche: Ossicine e Fuoco centrale, costruiti al termine di un lungo lavoro seminariale con due tribù di giovani attori, sono solo gli esempio più clamorosi di apertura e allargamento del gruppo, quasi una rifondazione.
Al rifiuto della forma narrativa e sequenziale a favore della comunicazione "organica" della poesia, Cesare Ronconi resterà sempre orgogliosamente fedele (con la parziale eccezione del Parsifal). Dati i componenti di base e il nucleo originario dell’ispirazione (la poetica del gruppo, il luogo dell’anima che si è andato delineando, le pratiche di lavoro con gli attori, e poi, sempre di più, i testi di Mariangela Gualtieri), la composizione dei lavori procede assecondando le dinamiche interne dei vari elementi, sia all’interno di un singolo spettacolo sia da un lavoro all’altro. Alcuni segni mantengono una loro continuità spettacolo dopo spettacolo: la predilezione per il bianco, il rosso e il nero, quei fuochi che tornano, una attenzione geometrica alla luminosità e alla prospettiva, la fascinazione per l’universo femminile, quei trucchi vagamente clowneschi che sfigurano i volti degli attori... Altri elementi possono essere radicalizzati: per esempio all’interno di uno spettacolo un salto può essere ripetuto all’infinito, fino allo sfinimento fisico dell’attrice che lo esegue, o al contrario la gestualità può essere ridotta al minimo, trasformando le interpreti in icone. Altri elementi possono essere al contrario programmaticamente negati: l’oscurità in cui sono immersi i primi lavori si ribalta nell’Atlante in un biancore abbacinante, lo spazio chiuso può distendersi in verticale e in orizzontale.
E’ un percorso di feroce radicalità e coerenza, che non concede nulla al pubblico ma che ne rispetta nella maniera più sincera l’intelligenza e il desiderio di condividere un percorso di ricerca. In un certo senso Cesare Ronconi allestisce un unico ininterrotto spettacolo - o meglio, costruisce lo spettacolo successivo destabilizzando sistematicamente le certezze raggiunte nel precedente lavoro.
L’elemento chiave che entra in gioco fin da Atlante dei misteri dolorosi (1986), segnando una svolta che caratterizza l’intero lavoro della Valdoca, è per l’appunto la poesia, o meglio la parola poetica. Nel nuovo teatro italiano, nel giro di pochi anni, al rifiuto - o all’emarginazione - della parola si sostituisce l’interesse per una parola poetica da far risuonare sulla scena. Carmelo Bene (il teorico della phonè) e Leo De Berardinis proseguono e approfondiscono il loro confronto con i grandi testi della tradizione. Federico Tiezzi, il regista del Carrozzone che sta diventando Magazzini Criminali, teorizza un "teatro di poesia" (in il Patalogo quattro, p. 176), scrive e allestisce una trilogia che mette in pratica quelle intuizioni e successivamente si misura con la Commedia dantesca (in collaborazione con Sanguineti, Luzi e Giudici) e con i testi di Pier Paolo Pasolini (che al teatro di poesia aveva dedicato il suo Manifesto) e Giovanni Testori. Giorgio Barberio Corsetti, abbandonato il vitalismo fisico e metropolitano dei suoi esordi con la Gaia Scienza, inaugura un filone diaristico e autobiografico, con venature inevitabilmente liriche.
Ma, al di là di questa sommaria esemplificazione, certamente chi si spinge con maggior impegno e costanza sulla strada di un teatro di poesia è proprio il Teatro della Valdoca: non si tratta di un interesse episodico ma sapientemente coltivato, come testimoniano gli incontri e i seminari organizzati con vari poeti, a cominciare da Milo De Angelis, nel corso degli anni, in una costante attività di formazione e autoformazione.
All’inizio, nell’Atlante, che segna anche l’evoluzione verso uno spazio più aperto lungo la linea dell’orizzonte e con un gruppo d’attori più folto (tre attrici, una cantante e un attore-angelo, al posto delle ali una fascina di stecchi), i passi di questo cammino verso la poesia sono appena accennati. In uno spettacolo ancora costruito soprattutto sull’impatto visuale, alcuni frammenti di Paul Celan, di Eschilo e di Milo De Angelis vengono sussurrati attraverso megafoni di terracotta, raccontati come a se stessi, con fatica e sofferenza, colme se giungessero da lontananze irraggiungibili; mentre altri versi appaiono sui lunghi cartigli - ripresi dall’iconografia medievale - che vengono srotolati in scena. In questa prima tappa ci sono solo echi lontani di bisbigli infantili e parole scritte («Ciò che è amaro tiene desto»), non è ancora possibile la sintesi.
In Ruvido umano (1987), in una scena che gioca a raddoppiare un teatro, con le quinte e i fondali di velluto rosso, tocca all’inedito connubio Rilke-Ginsberg offrire il materiale per esplorare la parola nella sua intera gamma tonale, dall’urlo al sussurro. E’ una parola sfuggente, spesso spezzata o impedita, portata verso il punto di rottura dell’inarticolato. Tra cupezza e estasi, disperazione e sublime, si tratta di esplorare le modalità di comunicazione della parola in tutte le valenze emotive e tonalità espressive, dal sussurro all’urlo, dalla parlata pascoliana e fanciullesca con un dito in bocca a un farfuglio che tende all’inarticolato. Sempre spingendosi verso l’estremo, con una parola faticosa, da conquistare sillaba dopo sillaba. L’ouverture è un lungo brano di Rilke sulla natura degli angeli, appena mormorato in una oscurità quasi totale. Pierre Renaux, in piedi su una sedia, tenta invano di descrivere la propria solitudine rimasticando versi con la bocca ingozzata di pane. Karin Jourdant spezza la purezza del suo canto in una dolorosa capriola che ripete all’infinito. Gabriella Rusticali urla la maledizione conto il Moloch di Allen Ginsberg con la testa arrovesciata all’indietro, quasi a strangolarsi.
Questa «parola faticosa» resterà negli anni a venire una delle costanti del lavoro sulla voce. Il testo non viene dato nella sua oggettività, la parola non è mai neutrale veicolo di significati, il senso non è mai naturale né innocente: nel cammino dalla pagina allo spettatore, incontra un ostacolo - il corpo dell’attore. Prima che la parola possa riconquistare il proprio senso, è necessaria una violenza. Da un lato c’è la muta ottusità del mondo, la bellezza e la sofferenza del creato che si offrono nella loro immediatezza di cosa nella quale siamo animalescamente immersi con la nostra carne e i nostri sensi - e su tutto questo non ci sarebbe nulla da dire, solo cantare con ammirato stupore e orrore quello che non sappiamo più vedere e cantare, cancellato dalla civiltà e dalla sua continua violenza. Dall’altro, ci sono parole e frasi usurate, consumate dalla chiacchiera. La parola poetica - parola di stupore - deve dunque inventare un nuovo senso al mondo restando nuova e viva. O meglio, ritrovare il senso e lo stupore perduto del mondo, senza cadere nella banalità della chiacchiera. Gli spettacoli della Valdoca saranno dunque rituali della parola, costruiti su una triplice violenza. Violenza sull’oggettività muta del mondo - dell’animale - per estrarne un senso. Violenza sul linguaggio, per recuperare la sua forza originaria e rivelatrice. E soprattutto violenza sulla voce e sul corpo dell’attore - il campo dove si combatte questa lotta necessaria.
Dopo l’incontro con Pasolini (Otello e le nuvole, 1987), in Cantos (1988), frutto di un emozionante soggiorno africano, struggente inno alla nostalgia e allo struggimento per una bellezza quasi aliena e irrecuperabile, sofferto ritorno alla propria disperazione, salgono in primo piano i testi di Mariangela Gualtieri, che distillano in forma di parole una saggezza poetica tra favola e filosofia. In una sorta di insegnamento misterico centrato sulla multiforme parabola di un costruttore di tappeti accecato come Tiresia dalla sua stessa saggezza, sono monologhi impressionistici di ricordi, sogni e pensieri (affidati a una tribù di quattro ragazze), storie di silenzi e di fantasmi, con sconfinamenti in francese e in swahili, schegge poetiche che una quinta ragazza (Anna Amadori) emette con pietrosa fatica. A punteggiare il lavoro, le note di un violoncello, un canto struggente e dolente, ma anche fughe e ritorni improvvisi delle attrici, lamenti, grida improvvise e richiami come d’animali. E’ uno spettacolo che contraddice e rifiuta le regole della rappresentazione, alla ricerca della pura emozione, in una parziale dichiarazione d’impotenza poetica, volutamente difficile da decifrare, sospesa tra un’urgenza vitalistica di autenticità e la difficoltà di mantenere il contatto con una voce che pare farsi sempre più flebile e angosciata. Sarà Mariangela Gualtieri a cercare, con le sue liriche, questa difficile sintesi: da quel momento firma in pratica i testi di tutti gli spettacoli della Valdoca, in un percorso che diventa così il cammino verso l’individuazione e l’espressione di una voce poetica autonoma e autentica, destinata ad avere un’ampia eco e riconoscimenti anche al di fuori del mondo del teatro.
A sancire la centralità dei testi saranno le diverse fasi spettacolari di Antenata (i tre atti dal 1991 al 1993): anche la prima raccolta di poesie da lei pubblicata nel 1992, che raccoglie i versi usati nella trilogia, avrà lo stesso titolo. Non è un caso che i primi versi di Antenata - tutti scolpiti in maiuscole, in un grido solenne e sacrale - rimandino a una poesia detta e ascoltata, prima che letta:
PARLAMI CHE
IO ASCOLTO PARLAMI CHE
MI METTO SEDUTA E ASCOLTO
METTO UNA MANO SULL’ALTRA
PARLAMI E ASCOLTO.
La poesia di Mariangela Gualtieri ha dunque il compito di "dare voce", e pare rimandare a un altrove da cui queste voci possano parlare (in Antenata questo luogo è l’universo archetipo delle madri). Implica al tempo stesso una disposizione all’ascolto - che è anche quella dello spettatore di teatro, fin nella postura fisica. Può tornare a essere viva e pulsante solo grazie a un duplice ascolto. In primo luogo l’ascolto del poeta, che dev’essere in grado di accogliere una voce che non è sua, che gli giunge da un altrove indefinibile e di cui egli si fa tramite, umile e ferito. Il poeta viene attraversato da un testo enigmatico, di cui egli stesso non è in grado di cogliere tutte le stratificazioni di senso. Dunque questa voce presuppone anche l’ascolto di un destinatario, che deve aprirsi a essa e renderla carne pulsante, in un atto sacrificale.
Infatti questa parola originaria, primordiale, organica, non ci può arrivare con naturalezza, perché noi siamo ormai "innaturali", lacerati, feriti. In una civiltà che divide l’io e il mondo, in un continuo stupro, la poesia è l’eco - appena percepibile, ma con la potenza di un urlo - di un cosmo ancora organicamente unitario, dove il rapporto con la natura, gli oggetti, gli altri, le parole non è violenza e dolore - distacco da sé. Per recuperare almeno in parte la sua forza originaria, la sua verità, la sua bellezza, per non restare chiusa in una dimensione consolatoria, la parola deve dunque farsi respiro e corpo. Per farlo, per recuperare quella purezza e semplicità, deve rispondere alla violenza con un’altra violenza. Il rito teatrale implica uno sforzo, un dolore, il superamento di un limite.
Di più. Se è un mondo invaso - quasi infestato - dalla tecnica, la voce potrà ritornare a noi ripercorrendo quel cammino come a ritroso: dunque spesso sarà filtrata da megafoni, passerà attraverso una bocca ingozzata, o più spesso arriverà dai microfoni, amplificata e a volte distorta - in qualche modo oggettivata, staccata dall’io che la genera. La maestria di Cesare Ronconi nel portare in scena i testi di Mariangela Gualtieri sta proprio nel rifiuto programmatico dell’illustrazione del testo, nell’affrontare ogni volta queste liriche con una lotta esasperata, lavorando ossessivamente sull’intreccio di dolore e bellezza che è il nucleo germinale di quei testi, sullo scarto tra l’aspirazione all’integrità e la consapevolezza della ferita, tra l’utopia della purezza e lo sporco del sangue e dello sperma, tra l’asettica purezza del segno e la grana della voce e del respiro. Il terreno si cui misurare tutto questo è il corpo degli attori - e in particolare delle attrici, a cominciare dalla presenza più intensa dei lavori del gruppo, Gabriella Rusticali: nella sua capacità di assumere in sé anche un principio maschile ha trovato negli ultimi spettacoli del Teatro della Valdoca un ruolo di emblema, di icona chiave e fulcro.
Un testo poetico ha una sua forma - anche se la poesia di Mariangela Gualtieri la spezza e la torce di continuo. Per portare in scena questa forma, Cesare Ronconi continuerà a utilizzare lo stesso metodo messo a punto nell’Atlante e in Ruvido umano: la mette alla prova, la sospende, la graffia, la torce, la dilata, la pone in contrasto con il corpo e la voce degli attori. Perché anche il corpo può essere muta esistenza, una beatitudine ottusa e materna, una quiete che riposa in sé e si abbandona al flusso del respiro. Il corpo - soprattutto il corpo femminile - porta ancora in sé la potenza originaria delle madri. Conosce l’impulso vitale, l’estasi del movimento e la felicità dell’istante, l’orgasmo. Conosce la fatica e il dolore, e nell’ultimo attimo forse l’orrore della fine. Il corpo è carne, è muscoli, è forza. E’ respiro che si fa sussurro o rantolo, urlo o lamento, e poi si raggruma in voce, in canto e forse in parola.
E’ su questa parola sotto sforzo - la cui forma chiusa è dunque sospesa, riaperta in una tensione dinamica - che lavora Cesare Ronconi, per trovare un’altra forma. E’ un’operazione drammaturgica di smontaggio e rimontaggio dei testi, una manipolazione quasi magica, misteriosa, quella che porta all’incarnazione della parola in un corpo (anche se, all’atto pratico, usa precise tecniche di lavoro sull’attore. E, di nuovo, dopo questa disarticolazione, si tratta di coagulare da quei materiali, con una sapiente opera di messa a punto, una nuova forma. Ogni volta il punto di partenza sono questi materiali destabilizzati, resi fluidi, a volte consapevolmente sfregiati. L’ideale è ogni volta trovare una bellezza che sappia contenere dentro di sé le tensioni che l’hanno generato.
Dopo la tragica e rarefatta serietà, la dolorosa intensità di Antenata e dei primi lavori, Ossicine (1994) segna una nuova svolta. Nei primi anni, la compagnia era cresciuta, anche con calibrati innesti, intorno a un preciso nucleo di attori (o meglio, di attrici), le cui possibilità espressive erano state spinte all’estremo (fino a un punto difficilmente superabile, a volte, proprio per lo sforzo fisico richiesto agli interpreti). La scrittura scenica era andata via via irrigidendosi, quasi ossificandosi e cristallizzandosi. Così - come spesso è avvenuto in altri gruppi - il rischio era quello di insistere su un linguaggio che tende a chiudersi su se stesso, in un codice sempre più preciso ma ripetitivo e dunque destinato a svuotarsi di contenuti. La necessità è dunque quella di una apertura: rimescolare i dati acquisiti, sporcare i segni, abbeverarsi a nuove energie.
Ossicine nasce da un lavoro seminariale condotto con una trentina di ragazzi a Cervia ed è - come il successivo Fuoco centrale (1997), frutto anch’esso di un percorso pedagogico - una sorta di festa teatrale, un’esplosione di vitalità che si nutre di una duplice scoperta. C’è ovviamente, da parte dei giovani interpreti, la scoperta del piacere dell’esibizione e del gruppo, del proprio corpo e del corpo dell’altro, dello spazio e delle sue geometrie, del suono e della parola. Da parte di Cesare Ronconi c’è invece la sorpresa di una fonte di energia ancora vitale, fresca, a volte incontenibile, cui dare la disciplina del lavoro teatrale e della presenza sulla scena. E’ un incontro che porta felicità e gioia di vivere, sfrontatezza e ritmo indiavolato. La leggerezza - che prima era soprattutto delicatezza, rispetto - assume ora scopertamente la forma dell’ironia, tra favola e circo. Attori e attrici sono insieme guerrieri e atleti (anche se questa duplice radice dell’attore di teatro è da sempre uno dei punti di riferimento del regista). Indossano ampie e coloratissime sottane a fiori, braccia e gambe nude e dipinte, i volti truccati di rosso. I capelli hanno fogge bizzarre e mille tinte e sono infarciti di frutta e ortaggi. I cappelli - ricavati da rocchetti per cavi elettrici - sono anch’essi ornati di fiori e frutta. Nello spettacolo figurano un Pinocchio e una fatina cicciona - o meglio una grassa Alice che si gode questo Paese delle Meraviglie - e un bosco che si muove come nel Macbeth.
Tre anni dopo Fuoco centrale rilancia - sempre con i versi di Mariangela Gualtieri e 18 attori-danzatori, più il gruppo musicale Bevano Est con la sua trascinante colonna sonora folk - questa scoperta del teatro e della parola, in un contagioso ed euforico sperpero di energia, che ancora una volta spinge verso la festa - la comunità del gruppo che prima si confronta con quella del pubblico e poi forse lo accoglie. Ancora una volta si mischiano il sublime e il clownesco, l’estasi e il grido di dolore, in una lunga ballata accesa da improvvise folate di furore e - a volte - disperazione.
Si crea così una sorta di corto circuito tra le due fonti di energia che ispirano il lavoro di Mariangela Gualtieri e Cesare Ronconi, tra l’antico e il moderno, tra una origine che si perde nell’alba della storia e una giovinezza ugualmente primigenia. Sono anche, in definitiva, due forme di innocenza, ancora immuni dal dolore della vita nel quale siamo immersi noi, lettori e spettatori - macchiati dalla storia e dalla biografia. Sono le due sonde con cui la poetessa e il regista provano a ritrovare la purezza perduta, a conciliare la memoria e l’attualità della bellezza, in un mondo dove pare definitivamente sfregiata e cancellata. Il teatro e la poesia, la vitalità erotica dei corpi e una parola che reclama la propria pienezza, diventano il fragile ma potente tramite tra quella innocenza e la nostra lacerazione interiore.
Non è un caso che l’unico eroe della poesia di Mariangela Gualtieri, popolata di Madri e animata da demoni e spiritelli, sia il puro e folle Parsifal, maestro di stupore e stupidità. Rivisitando il mito in forma di poema, la sorprendente riscrittura esplora e reinventa gli «anni perduti» del cavaliere destinato a ritrovare il Santo Graal, prima che riparta verso la sua missione. In quell’intervallo, secondo questa leggenda apocrifa, Parsifal «viene torchiato e sottoposto al "duro allenamento dei dolori terrestri"». Lo spettacolo - che debutta nel 1999 in un luogo carico di memorie pascoliane come la Villa Torlonia a San Mauro, con un intenso Danio Manfredini nel ruolo di Parsifal-Pinocchio - è una lunga e fiabesca iniziazione al sesso, un’orgia folle e dolorosa, erotica e acrobatica, con una tribù colorata e barbarica di Pinocchi e Fate Turchine (ancora segni che si rincorrono spettacolo dopo spettacolo) che mitragliano amplessi e capriole, danze e accoppiamenti. Prima di ritornare al canone e alla sua missione «del tutto snervato, sfinito, confuso, disperato», il Parsifal della Valdoca attraversa dunque la sofferenza del mondo - la nostra sofferenza. Per rinascere, deve in qualche modo morire. Solo così può diventare un doppio e un portavoce del poeta: deve conoscere il peccato ma restare innocente, comprendere la vita senza diventare meschino, essere il meno possibile - essere meno intelligente, meno consapevole, non avere volontà né personalità.
Accanto a queste «grandi forme» spettacolari, di respiro corale ed epico, il Teatro della Valdoca continua parallelamente a esplorare forme più contenute, dove i versi di Mariangela Gualtieri assumono un ruolo preminente. In uno spettacolo-manifesto di sottile attualità contro l’orrore della guerra come Nei leoni e nei lupi (1997) domina un grottesco che a volte spinge verso una decisa comicità, quasi a far emergere l’animalità feroce che sopravvive in ciascun di noi, quel bisogno febbrile di agire per riempire il vuoto e l’angoscia. Nel monologo Chioma (1999) esplode la potenza vocale di Gabriella Rusticali, con la potenza di un demone furibondo. Nel delizioso varietà da camera Predica ai pesci (2001) un mondo da fiaba surreale si popola di presenze animalesche e acrobatiche.
Nel corso degli anni, gli spettacoli del Teatro della Valdoca hanno di volta in volta trovato diversi punti d’equilibrio, inseguendo una poetica in continua evoluzione.
In primo luogo per Mariangela ci sono un’innocenza e un’armonia perdute, delle quali tuttavia è possibile conservare ancora la consapevolezza e la nostalgia. Dall’altro, ci sono il dolore e la sofferenza del mondo in cui siamo immersi: in definitiva, il dolore di quel divenire che è la storia da un lato, e dall’altro la biografia di ciascuno di noi, la coscienza di noi stessi che ci separa dal mondo. Non credo che, in questa visione, noi siamo colpevoli. Non è stato un qualche peccato originale ad allontanarci per sempre - ciascuno di noi, irrimediabilmente - da quella purezza: è troppa la compassione e l’amore per il creato che emerge da quei versi. A farci perdere l’innocenza è stata piuttosto una atroce rivelazione: la consapevolezza della violenza del mondo - una violenza che esiste, terribile e bella, nell’ordine delle cose. Nel momento in cui diventiamo consapevoli della nostra finitezza, nasce la tragedia dell’uomo. In quell’istante irreversibile perdiamo l’innocenza, perché ci scopriamo incapaci (salvo appunto Parsifal, o forse per un istante il poeta e l’attore nei quali riecheggiano quelle voci lontane) di accettare i limiti di un ordine del cosmo - un ordine naturale, arcaico, contadino, forse matriarcale - nel quale ciascuno può trovare il proprio posto. E’ uno stato originario irraggiungibile, ormai, ma noi abbiamo il dovere della nostalgia - e della lotta. In questo, quella di Mariangela non è mai una poesia consolatoria ma autenticamente militante. Perché far rivivere il ricordo di quella purezza perduta è una continua lotta, una estenuante violenza. Ma una violenza poeticamente necessaria, affinché la parola non ritorni a essere suono inarticolato, respiro o farfuglio, urlo o rantolo: da quel caso è emersa e lì può sempre ritornare, oppure appiattirsi di nuovo nella banalità del chiacchiericcio quotidiano
Per Cesare la bellezza è di sicuro forza e rabbia, energia liberata da ricondurre a un linguaggio. E’ una forza che vive di un fragile equilibrio, da infrangere e ricomporre di continuo. Perché la bellezza ruota intorno a una forma. E’ equilibrio e proporzione, rapporto tra pieni e vuoti, tra gli oggetti e lo spazio che li circonda. Sono le corde che misurano e scandiscono lo spazio nei primi lavori, sono i percorsi che disegnano gli attori sulla scena. Sono i colori fondamentali, il rosso, il bianco, il nero che pitturano i volti degli attori. Sono quei materiali spesso antichi e naturali, dove a volte il moderno è necessario a evidenziarli, per contrasto: sono il legno e l’argilla, la grana della materia. E’ una qualità della luce - il fuoco che brucia, la fiamma di una candela, ma anche le svariate luci artificiali utilizzate di volta in volta con grande maestria. Ma questa bellezza non è mai una forma statica, classicamente chiusa in se stessa: è una fiamma che brucia, una forma vivente, che ha pulsioni e tensioni che la trasformano di continuo. Sono corpi in movimento, che danzano nella luce, sono quei gruppi dai quali di volta in volta qualcuno fugge correndo per gridare la sua gioia o la sua rabbia, la sua tenerezza o la sua solitudine. Sono coppie che si intrecciano nell’amplesso o quei grumi che compongono una pietà laica per accogliere il dolore dell’altro.
Da questo punto di vista, la bellezza può anche essere uno sfregio, addirittura uno stupro. E’ spesso ferita, è il canto della ferita. Ma questa consapevolezza tragica, con il passare degli anni, viene sempre più spesso trasmessa - e insieme contraddetta, almeno in apparenza - da un filtro spettacolare, dal gioco del teatro consapevolmente citato. Non è che il nostro dolore sia rappresentazione, e che il mondo sia un gran teatro: anzi, la sofferenza è sempre vera e presente e la realtà drammaticamente reale, fuori dal teatro. Ma, appunto, qui siamo in teatro - ed è bene esserne consapevoli. Così, se quello della bellezza è un gioco fragile, allora tanto vale giocare, e se possibile con leggerezza e disincanto. Ecco dunque riecheggiare l’avanspettacolo (con quelle parate e le esplosioni patetiche di allegria musicale), le marionette (che punteggiano Nei leoni e nei lupi) e i clown (con quel trucco esagerato che torna spettacolo dopo spettacolo a distaccare gli attori dalla loro immagine, dalla loro realtà per farne qualcosa di diverso) e persino gli acrobati (le bravissime interpreti della recente Predica ai pesci).
E’ questo duplice aspetto dinamico (nella poesia e nello spettacolo) a tradire la natura profondamente teatrale del Teatro della Valdoca. Certo, ci sono belle poesie e belle immagini, che potrebbero avere valore autonomo se venissero fissate e rimanessero fini a se stesse. Ma queste parole sono frutto di un processo - di una violenza - e fanno parte di un processo di comunicazione che non si esaurisce nella pagina. Se la poesia fosse autosufficiente, se non servisse a cambiare - a illudersi di cambiare - lo stato del mondo, almeno di un poco, di un infinitesimo (oppure, se la poesia non cambia certo il mondo, almeno può cambiare l’attenzione che abbiamo per la realtà), forse Mariangela smetterebbe di scrivere, o lo farebbe come un automa cui certe voci dettano un testo di cui abbiamo perso il significato. Allo stesso modo, se la bellezza fosse una forma eterna e autosufficiente, da contemplare in una qualche estasi, se la bellezza non si usurasse non appena l’abbiamo intravista, forse Cesare smetterebbe di fare teatro.
(da Teatro Valdoca, a cura di Emanuela Dallagiovanna, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2003, pp. 147-161)
Le recensioni di "ateatro": Tragedia Endogonidia R.#07
Il ciclo della Socìetas Raffaello Sanzio fa tappa a Roma
di Oliviero Ponte di Pino
Con l’ambizioso ciclo della Tragedia Endogonidia (giunto a novembre alla tappa numero 7, al Teatro Valle di Roma per Romaeuropafestival) la Socìetas Raffaello Sanzio prosegue con coerenza il proprio cammino, continuando a lavorare metodicamente alla realizzazione del proprio teatro della crudeltà. Ovvero della personale pratica delle intuizioni e visioni di Antonin Artaud condotta da Romeo Castellucci & soci: un teatro dove il segno-gesto teatrale possa recuperare – prima ancora che un senso – la propria potenza destabilizzante, numinosa, là dove il linguaggio non si è ancora strutturato e codificato.
E’ un cammino che sospinge verso il mito e ancora di più il rito. Verso il pre-umano e l’animale (e infatti ecco regolarmente in scena, anche in questo ciclo un capro, come nella tappa inaugurale a Cesena, e una scimmia, come a Roma, dove uno scimpanzé abita a lungo una candida scena, dietro una vetrata geometricamente scandita). E sospinge verso il corpo, il dato elementare della fisicità (fino addirittura al DNA...). Verso l’inorganico e la morte, in un teatro vitalissimo. Al tempo stesso, questa tensione verso l’origine implica spesso un gesto di destabilizzazione nei confronti dei linguaggi già codificati, dei miti condivisi, dei luoghi comuni della comunicazione: di qui la necessità di oltraggi, provocazioni, trasgressioni...
Dopo la dissezione e destrutturazione del mito operata negli ultimi spettacoli, il ciclo della Tragedia Endogonidia costituisce una ulteriore fase di lavoro per il gruppo cesenate. Questa volta si tratta di far germogliare il segno dal confronto con la realtà, ma anche dalla frizione con la storia e con l’attualità politica. Ovviamente con lo stile, i punti di riferimento, il patrimonio accumulato dalla Socìetas in decenni di lavoro.
Dunque, in primo luogo, un estetismo raffinato e perturbante, che opera per sottrazioni progressive e formalizzazioni radicali, per opposizioni binarie. Il «prima», l’origine a cui tende asintoticamente la Raffaello è al tempo stesso un «dopo»: dopo il disastro, dopo una catastrofe reale che è al tempo stesso un collasso del sistema di segni di cui è fatto il mondo.
In secondo luogo, ritorna tutta una costellazione di oggetti, gesti e relazioni, oltre che di riferimenti (per esempio a Lynch e, nella prima scena, al Kubrick di 2001 Odissea nello spazio), e un costante slittamento verso una dimensione onirica, riprendendo la logica freudiana di associazioni, derive e inversioni di segni. Nella tappa romana, il nero ossessivo del fascismo diventa clamorosamente un bianco lattiginoso (quasi degno dei marmi dell’Eur e del Foro Italico...), nell’inferno ovattato dove viene condotto e rinchiuso un Mussolini in accappatoio bianco.
C’è, in più rispetto ai lavori precedenti, un serrato confronto con i luoghi che ospitano e producono lo spettacolo, in un viaggio che ha un respiro triennale, lungo un percorso circolare parte e tornerà a Cesena nell’ottobre del 2004, dopo aver toccato altre nove città (Avignone, Berlino, Bruxelles, Bergen, Parigi e poi – dopo Roma – Strasburgo dal 17 al 20 febbraio 2004, Londra a maggio e Marsiglia a settembre). Così nella stazione romana ecco evocati, per l’appunto, Mussolini, e prima di lui uno sciame di pretini in tonaca nera che sembrano rubati a una foto di Giacomelli: giocano a maldestramente pallacanestro, in un beffardo ibrido di sport e cerimonia religiosa.
L’accostamento rimanda obliquamente a un evento storico: perché Roma è la città del Concordato del 1939, il patto tra il Potere e la Chiesa. Ma questa Roma astrattamente felliniana è anche una città del teatro (o della commedia dell'arte...), e dunque ecco entrare in scena un demonio tutto vestito di rosso, che si abbevererà vampirescamente del sangue del Duce, per poi rivelare un abito da Arlecchino, prima multicolore e poi a scacchi bianchi e neri, proprio come il costume dell’attore affrescato sulla volta del Valle, in una duplicazione ironica, sottolineata da un gioco di luci (ed è sintomatico che questa gag metateatrale tra realtà e finzione, in uno spettacolo aperto al mondo esterno e alla storia cittadine, rimandi all’interno del luogo teatrale).
Sono immagini e segni incisivi, spesso sorprendenti e spiazzanti, a volte ironici (ma anche l’ironia è uno dei meccanismi dell’inconscio). Segnano la assunzione esplicita di una sensibilità – se non di una responsabilità – politica: nelle prime tappe della Tragedia Endogonidia una delle icone più riconoscibili era un cadavere che evocava quello di Carlo Giuliani; mentre a Roma l’infernale scatola bianca finisce si apre e si sfonda su un contenitore addobbato con strisce multicolori che richiamano le bandiere della pace.
Al tempo stesso sono segni che cercano di evitare ogni facile decifrazione, per incidersi in una zona dell’Io ancora vergine, aperta a nuove sensazioni e associazioni. Tuttavia quella di Romeo Castellucci, che da sempre fa «teatro contro il teatro», pare una fatica di Sisifo: la crudeltà artaudiana, che si rivela ogni volta – più che in un segno – in un gesto, in un’azione, diventa tuttavia immediatamente e inevitabilmente interpretabile, inscritta com’è nella forma del testo-spettacolo, e dunque in una logica e in una sintassi.
La Tragedia Endogonidia cerca di sfuggire a questa morsa praticando un nomadismo dei luoghi, che arricchisce ogni volta il repertorio di riferimenti e provocazioni (in un ambito assai diverso, è la stessa strada imboccata da Pina Bausch nelle produzioni ospitate dalle diverse città che producono i suoi lavori). Questa apertura al reale viene però compensata da quello che Castellucci definisce «isolamento»: la creazione di un sistema chiuso e autoreferenziale (l’aspetto «endogonico»), di uno spazio finito come un mazzo di tarocchi, in cui alcuni segni e meccanismi (la deriva verso altri mondi, l’anonimia, la maschera, l’alfabeto, la legge, il bersaglio, la cronaca nera, la città, in un elenco prodotto dallo stesso gruppo, ma ce ne sono ovviamente altri), tornano e si fecondano tra loro: una sorta di camera iperbarica che porta a conflagrazioni, dissociazioni... E’ nell’equilibrio tra l’indispensabile contaminazione con il mondo (altrimenti l’intero sistema si riduce a esaurire le diverse possibilità combinatorie di un numero finito di elementi) e la coerenza poetica del sistema che si verificherà la tenuta dell’intero progetto. In questo, la testimonianza filmica offerta da Cristiano Carloni e Stefano Franceschetti offrirà certamente una significativa verifica.
E la tragedia? Fin dall’inizio, con lucidità, Romeo Castellucci si arrende all’impossibilità della tragedia.
«La nostra epoca e le nostre vite sono definitivamente fuori da ogni concezione tragica. Redenzione, pathos e ethos sono parole irraggiungibili, cadute nella più fredda delle astrazioni. Occorre avere il coraggio di guardare il vero volto della tragedia. Perché non so ancora cos’è».
Per recuperare il senso della tragedia, rifiuta l’aspetto più direttamente civile e politico:
«La tragedia non crea un modello estetico, in cui la polis si riconosce e che illustra il pensiero e i timori di un’epoca. Non è una riflessione sul mondo o l’espressione di una visione del mondo, ma un interrogativo vitale sulla possibilità dell’azione, sulla natura stessa dell’agire (...) La tragedia non è quindi testimonianza, ma epifania: non è riflesso della realtà, ma contestazione profonda della realtà, attraverso la creazione della coscienza tragica. Essa nasce dal conflitto. Essa è conflitto per affermare la legge del possibile, sempre pragmatica.»
Coerentemente, viene data per scontata l’assenza di una comunità (di una polis) a cui far riferimento; e viene esclusa da questa nuova forma di tragedia il Coro, visto come istanza razionalizzatrice, portatrice della possibilità e necessità dell’interpretazione all’interno dello stesso evento teatrale. Viene dunque enfatizzato, della tragedia antica, l’aspetto misterico, pre-verbale, rituale, pur sapendo benissimo che il recupero di quella dimensione è un obiettivo irraggiungibile per noi moderni – anche se forse per i post-moderni la situazione potrebbe essere diversa...
Tuttavia, se la tragedia nasce dal mito e dal rito, essa ha preso forma anche e soprattutto nel rapporto paradossale tra la necessità (il destino) e la libertà (la possibilità dell’individuo di scegliere tra bene e male). L’azione tragica non si contrappone solo e tanto all’impossibilità di agire, magistralmente portata sulla scena proprio dall’Amleto autistico della Socìetas. Si contrappone piuttosto a un agire «eterodeterminato»: determinato dalle leggi della natura, dell’istinto, del corpo, della società – o magari divine. Mentre le abbaglianti e affascinanti figure e icone della Socìetas Raffaello Sanzio non paiono mai godere del libero arbitrio (che sta tutto, se ancora è praticabile, nella mente del demiurgo-creatore). La tragedia «raffaellesca», considerata emanazione (e forse degradazione) del mito e del rito, rifiuta invece la dimensione dell’individualismo, quello slittamento che dal rito e dall’epica apre agli abissi tragici – con le loro implicazioni morali e (di degradazione in degradazione, si potrebbe obiettare) psicologiche. Ma in questa Tragedia Endoginica il limite tra l’etico e l’estetico resta invalicabile, coerentemente con la visione e la pratica teatrali di un gruppo che ha costruito lcuni tra gli spettacoli più belli e significativi di questi decenni.
TRAGEDIA ENDOGONIDIA R.#07 - VII EPISODIO
Regia, scene, luci e costumi Romeo Castellucci
Composizione drammatica, sonora e vocale Chiara Guidi
Musica originale ed esecuzione dal vivo Scott Gibbons
Traiettorie e scritture Claudia Castellucci
Roma, Teatro Valle, novembre 2003
Un teatro a cavallo del '68
Margherita Becchetti, Il teatro del conflitto. La compagnia del Collettivo nella stagione dei movimenti. 1968-1976, Edizioni Odradek, 2003
di Carla Pagliero
Il bel libro di Margherita Becchetti, giovane ed entusiasta studiosa parmense, ricostruisce in maniera fresca e immediata un piccolo pezzo di storia del teatro italiano che ben rappresenta le vicende di una generazione, quella uscita dai movimenti sociali degli anni Settanta profondamente trasformata sia nei rapporti sociali e umani che negli strumenti professionali e teatrali.
Le vicende raccontate prendono il via dagli anni Cinquanta, quando Parma era l’unica sede italiana che ospitava i festival internazionali di teatro universitario e dalla singolare esperienza del Centro Universitario Teatrale che, attraverso varie trasformazioni, conflitti interni, spaccature e cambiamenti di rotta approderà nel 1971 alla nascita della Compagnia del Collettivo e alla fine degli anni Settanta alla gestione di uno spazio teatrale – Teatro Due – che oggi costituisce una realtà di assoluto rilievo.
Il libro dà ampio spazio alle effervescenze sessantottine quando anche Parma viene toccata da quel processo di politicizzazione e sperimentalismo che, nella seconda metà degli anni Sessanta, si impose in tutto il mondo teatrale costituendo la premessa per il superamento delle scelte esistenziali e generazionali della cultura beat.
Spulciando i programmi del Festival internazionale del Teatro Universitario, in appendice al testo, che si tiene continuativamente a Parma negli anni che vanno dal 1953 al 1971 si scoprono passaggi interessanti di compagnie che in questo momento stanno portando avanti un preciso discorso artistico che, come nota Becchetti nel testo, conduce ad “un uso politico del teatro” improntato su caratteristiche tipiche delle avanguardie e che si riflette nei modi della produzione, della comunicazione, nell’abbattimento dei rapporti gerarchici fra registi, attori, produttori. Nel 1967 il Living Theatre porta a Parma una delle opere più prestigiose del proprio repertorio: L’Antigone di Brecht, mentre nel 1968 Jean Jacques Lebel, uno dei protagonisti dell’occupazione dell’Odeon di Parigi, presenta un happening, forma di comunicazione artistica importata dall’America, che mette in scena la contestazione.
Tra 1967 e 1968 vengono allestite opere emblematiche che riflettono lo spirito dell’epoca, si toccano temi scottanti e attuali quali il Vietnam, il terzo mondo, la morte del Che, la rivoluzione culturale cinese, lo sfruttamento del lavoro in fabbrica. Uno degli autori più ripresi è, non a caso, Bertolt Brecht.
Anche i modi della ribellione e dell’azione uniscono le vicende parmensi a quelle internazionali: il 5 marzo 1968 l’Associazione Universitaria viene esautorata dal movimento e sostituita dall’assemblea generale di ateneo. Vengono occupati l’università e il Teatro Regio, nell’ospedale psichiatrico di Colorno, viene allestito uno spettacolo in solidarietà con la lotta degli studenti di medicina e degli infermieri, nel dicembre si contesta l’inizio della stagione lirica, sull’esempio delle contestazione della Scala di Milano, della Biennale di Venezia, “se un teatro vuole essere rivoluzionario deve rivolgersi al Proletariato… ogni opera teatrale è una proposta rivolta all’uomo sociale… per un discorso di classe… l’arte è funzionale ai fini di interessi politici” si legge nel Documento del Centro Universitario Teatrale di Parma, dell’aprile del 1968. Anche i circuiti in cui portare l’azione teatrale diventano alternativi: fabbriche, ospedali psichiatrici… nel 1970 viene ideato un progetto che coinvolge uno dei quartieri popolari della periferia, Montanara: Quartiere aperto ’70. Decentramento culturale. Quartiere Montanara, undici serate con proiezioni, canti popolari, dibattiti, dove il pubblico è invitato a partecipare gratuitamente, viene coinvolto nei dibattiti e nello spettacolo.
Tra gli episodi che attraversano la vita del Collettivo viene sottolineata l’importanza dell’incontro con Gianni Bosio, Cesare Bermani e il gruppo del Nuovo Canzoniere Italiano, che segna l’avvicinamento alla tradizione canora popolare italiana e anche ad una posizione estremamente critica nei confronti del PCI e dei sindacati accusati di operare una mediazione al ribasso fra istituzioni e classe operaia. La collaborazione con Bosio e Il NCI si concretizza con l’allestimento de La grande paura, sull’occupazione delle fabbriche del 1920, che metteva in scena quel teatro di classe, viva voce della cultura proletaria urbana tanto cara a Bosio. Il dissidio con il Pci fu vivacissimo e proseguì con virulenza anche maggiore durante l’allestimento di 1921: Arditi del popolo, messo in scena in occasione del cinquantenario delle barricate di Parma, che ribadì la critica viscerale nei confronti della politica del Pci e sancì la rottura con l’Arci che monopolizzava i circuiti alternativi di sinistra in quegli anni.
Alla fine degli anni Sessanta l’esperienza teatrale universitaria è oramai ampiamente superata, «restano», scrive Flavio Ambrosini, «i gruppi teatrali che hanno vissuto questa autodistruzione e che stanno faticosamente raggiungendo una loro definizione artistica, culturale, politica e sociale a un tempo». Molti abbandonano l’esperienza teatrale, altri scelgono il teatro come professione andando a costituire “la Compagnia del Collettivo” dove le consuete gerarchie vengono sostituite da una gestione assembleare. Il panorama italiano si presenta vivacemente articolato e ricco, proliferano le cooperative. Sorgono nuove sale teatrali.
Per la compagnia parmense sono gli anni in cui vengono recuperate le forme della satira politica e i generi popolari come la farsa e la canzone. Nel 1973 si propone La colpa è sempre del diavolo di Dario Fo, prima opera del futuro premio Nobel messa in scena da un’altra compagnia. E’ poi la volta de Le piaghe della santa repubblica, allestimento farsesco della storia d’Italia, e Il Figlio di Pulcinella dove l’opera del grande Edoardo viene riletta facendo emergere alcuni temi dibattuti quali il divorzio, la corruzione politica, le figure grottesche di certi uomini politici molto bersagliati dalla letteratura satirica dell’epoca, la lezione di Bosio appare superata e i modelli popolari diventano l’oggetto e non più il soggetto della produzione teatrale del gruppo.
La fase successiva è caratterizzata dal ritorno ad una ricerca più professionale e meno politica: l’occasione è data dalla trasformazione dello stabile dell’ex-Enal di viale Basetti, inaugurato il 16 novembre 1975. Il Comune affida lo spazio a un comitato dove sono presenti l’Arci e la Compagnia del Collettivo: il progetto prende il nome di Teatro Due: si organizzano incontri, corsi di recitazione, spettacoli. L’esigenza di dare una stabilità a questa esperienza porta alla firma di una convenzione con il Comune. Nel 1980 Teatro Due diviene il primo esempio di sala teatrale pubblica gestita da una compagnia privata. La compagnia non è più composta da giovani universitari, il teatro è diventato una professione vera e propria, anche il modo di lavorare non è più quello autogestito del collettivo e il rapporto fra politica e teatro diventa recupero dell’impegno civile e intellettuale, i dissidi con la sinistra storica si stemperano. Sono gli anni del riflusso e del recupero della professionalità che segnano senza interruzione di continuità il passaggio dall’esperienza esistenziale sessantottarda a nuove forme artistiche ma anche a nuovi atteggiamenti morali e culturali nell’esercizio della professione.
Margherita Becchetti, Il teatro del conflitto. La compagnia del Collettivo nella stagione dei movimenti. 1968-1976, Edizioni Odradek, 2003, pagg.187, € 12.
 a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |
Marco Paolini (ri)monologa in tv
Il pezzo su Bhopal a Report su Raitre
di Fernando Marchiori
Nel febbraio scorso, Marco Paolini era andato in scena in Piazza San Marco a Venezia, in pieno carnevale, con il suo Parlamento chimico, riportando nel salotto buono della città lagunare la storia drammatica del polo industriale di Porto Marghera, dei morti per cancro nei reparti cvm, del processo ai dirigenti Montedison e Enichem conclusosi con l’assoluzione di tutti gli imputati. Era un modo - scrivemmo allora - per intere generazioni di veneziani di tornare a pensare senza vergogna né pregiudizi ad un tempo in cui a sfilare per le strade non erano le maschere di Arlecchino e Pantalone, ma quelle antigas degli operai in sciopero. Fu un successo enorme, doppiato oggi, 23 novembre, dall’altra parte della città, a Marghera, dove una piazza Mercato stracolma (forse cinquemila persone, in piedi, attentissime), a due passi dagli impianti del petrolchimico, ha seguito Paolini nel racconto di Bhopal. Certo l’attore trevigiano richiama grandi folle ovunque, e la recente esperienza televisiva nella trasmissione Report (di cui Bhopal era una delle puntate) ne ha ancora una volta confermato la bravura e la popolarità. Ma l’appuntamento di Marghera ha avuto un significato che va ben al di là del successo di pubblico.
Bhopal e Venezia
Organizzato nell’ambito delle iniziative per rilanciare la "questione petrolchimico", a un anno dall’incidente al reparto TDI che, il 28 novembre 2002, fece temere il peggio (l’esplosione dei depositi di fosgene), con la città industriale paralizzata e la gente ancora una volta costretta a chiudersi in casa per evitare la nube tossica, lo "spettacolo" si è affiancato ad altri appuntamenti di non minore pregnanza politica: una campagna informativa, un’assemblea permanente sul rischio chimico, una raccolta di firme per chiedere l’allontanamento del fosgene, e soprattutto la mostra delle sconvolgenti fotografie scattate da Raghu Rai all’indomani del disastro di Bhopal, in India, 19 anni fa. Già presentata al vertice sulla Terra di Joannesburg e in varie capitali europee, la mostra ha trovato a Marghera la sua più coerente e inquietante conclusione. Diversi i tempi della strage e le sostanze chimiche impiegate, Bhopal e Venezia hanno conosciuto le stesse dinamiche criminali: l’inquinamento continuato e pianificato, l’irresponsabilità delle dirigenze aziendali e di un’intera classe politica, la riduzione progressiva della manutenzione degli impianti e dei sistemi di sicurezza per abbattere i costi di produzione, la mancanza di informazioni a medici e cittadini. E infine l’ingiustizia: in India nessuno è alla sbarra, quindi né bonifiche né risarcimenti in vista; in Italia una sentenza scandalosa ha assolto due anni fa tutti gli imputati eccellenti al processo celebrato nell’aula-bunker di Mestre dopo quattro anni di indagini. Ma il legame tra i due centri industriali, e i timori fondati di un rischio-Bhopal per Venezia, sono resi ancora più inquietanti dal fatto che non solo la Union Carbide (insieme a un’altra multinazionale americana, la Monsanto) fornì il supporto tecnico per lo sviluppo del Petrolchimico negli anni Cinquanta, ma la Dow Chemicals, che nel 1999 ha acquistato la Union Carbide, è attualmente proprietaria anche degli impianti veneziani.
Trasporti, ponti e indiani veneti
Accolto da un lunghissimo applauso, Paolini ha iniziato proprio con una scheggia del Parlamento chimico: la scena dei veneti che si chiedono vicendevolmente il luogo d’origine ("da ‘ndove ti xe?"), tastandosi la lingua (le diverse varianti del dialetto) come gli animali si annusano per riconoscersi l’un l’altro. Scena che a sua volta era un trasporto da un altro spettacolo, il Milione, cardine di quel processo di reciproco riconoscimento tra l’attore-autore e il pubblico veneto che è la ragione prima del successo di Paolini e del suo impegno anche televisivo (sia detto per inciso: chi inverte i fattori non solo è in cattiva fede e dimostra di non conoscere il lavoro di Paolini, ma soprattutto troverà che il risultato non torna, sfugge ai parametri di una critica aprioristica). Pur mitigato dall’invito a non correre troppo lungo facili parallelismi, il sottotesto veneziano del racconto di Bhopal (del resto più volte reso esplicito da richiami a situazioni tecniche equivalenti o alla medesima condizione di subalternità culturale dei lavoratori: spesso gli operai indiani finiscono per parlare in veneto) scorre limpidamente fra i grumi di emozioni quasi palpabili tra la folla silenziosa. Qui ogni famiglia ha conosciuto sulla propria pelle la metastasi sociale, quando non direttamente anche quella organica, causata dall’insorgere incontrollato di un polo chimico che tutt’oggi è il più grande d’Italia. Non ci vuole molto, perciò, a riconoscersi in quelle altre famiglie che a Bhopal sognarono di poter finalmente uscire dalla miseria grazie al lavoro in fabbrica o nell’indotto. La strage avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 1984 viene ricostruita dal loro punto di vista: dalla gioia per la fine della stagione dei monsoni ai matrimoni celebrati in serie in quelle notti dolci raccomandate dalle congiunzioni astrologiche; dalla fallita "rivoluzione verde", che impose di sostituire il mais al riso usando i prodotti chimici e causando la desertificazione, fino alla crisi della fabbrica, alla sua dismissione, alla svendita degli impianti in Brasile e Malesia. Sotto terra, chiuse in vasche frigorifere, rimangono 63 tonnellate di isocianato di metile, che a contatto con l’acqua accidentalmente versata da una una squadra di operai (non specializzati) incaricati della manutenzione periodica sprigionerà una nube tossica devastante. » l’apocalisse: quasi 8.000 morti in tre giorni per gli effetti immediati, altri 16.000 in seguito, ripercussioni su mezzo milione di sopravvissuti e su tutto l’ambiente circostante per un’area di 40 kmq. "You want Osama, give us Anderson", ripete più volte Paolini, verso la fine del monologo. » la frase, dura e sconcertante, che si legge su una delle foto di Rahgu Rai. Campeggia sul cartello che un’anziana donna in sahri regge, tra molti altri, durante una manifestazione a New Delhi. » una sopravvissuta alla strage, una delle migliaia di vittime del più grande disastro chimico della storia che da 19 anni chiedono giustizia per un crimine senza precedenti e ancora senza colpevoli. Denuncia il contrasto tra gli sforzi enormi per catturare bin Laden e quelli risibili per ottenere l’arresto e l’estradizione di Warren Anderson, all’epoca presidente della Union Carbide e oggi latitante negli Stati Uniti. Il cortocircuito tra disastri ambientali così lontani e così vicini tra loro, tra modelli di sviluppo e colonialismo economico, tra declinazioni tanto differenti della categoria di "terrorismo" potrebbe continuare in un perverso climax di sicuro effetto. Ma la conclusione di Paolini si affida alla grazia e alla ferma serenità di una ragazza che si vede tra i dimostranti nelle foto di Rahgu Rai, una ragazza nata in quella notte maledetta e che porta nel suo nome la memoria della nube tossica e insieme la forza della vita che continua: Gas Dehvi, Dea del Gas.
Teatralità, televisione
Il Paolini di Report ha attraversato ancora una volta il mezzo televisivo, lo ha usato senza farsi usare, ne ha esaltato i giacimenti di recondita teatralità, imponendo - complice la splendida regia di Giuseppe Baresi – i propri tempi, mezzi e linguaggi. Il teatro di Schio (Vicenza), dove l’estate scorsa sono stati registrati tutti i monologhi trasmessi in tv, è apparso come una metafora del teatro tout court. Uno spazio sventrato (l’edificio era in restauro e mostrava le viscere dell’impianto all’italiana, i muri con i segni dell’attrezzeria strappata, i palchetti, gli ingressi laterali, il sottopalco) ridisegnato dal corpo dell’attore e dagli spostamenti di macchina essenziali. Pochi elementi di riporto (come il trenino caro a Paolini, un leggio, una bicicletta o un baule) e un funzionale riuso del materiale rinvenuto in loco, ovvero delle macerie del teatro (nei due sensi: letterale e metaforico): una scritta sul muro scrostato ed ecco una stazione, la polvere che si alza dal pavimento e siamo nei campi del Kosovo contaminati dall’uranio impoverito, una catasta di travicelli o un percorso nei meandri bui del sottopalco e siamo nei pressi delle vasche che a Bhopal contenevano il gas micidiale. Se nelle precedenti esperienze televisive e radiofoniche di Paolini ci era sembrato di leggere il tentativo di far emergere la teatralità (implicita e spesso strumentalizzata) dei media, qui siamo forse di fronte a un passo ulteriore, che porta la tele-visione del teatro a riarticolare il proprio linguaggio sulla base di un modello di comunicazione che rimane orgogliosamente altro, e non solo rifiuta di farsi "telegenico" ma anzi costringe la tv a portare in luce la propria filigrana teatrale. Tutto questo, ovviamente, non si è visto sul palco di Marghera. Ma è indubbio che ne costituisce l’antefatto artistico. Se agli spettacoli di Paolini non si ha l’impressione di vedere qualcosa che si è visto in televisione (come accade sempre con i personaggi resi famosi dal piccolo schermo e che poi decidono di calcare le scene) è perché la verità di questa forma di relazione con il pubblico, cui volentieri diamo ancora il nome di teatro, si sostanzia in un farsi comunità che sfida i mezzi di distrazione di massa sul loro stesso terreno (e con esiti meno effimeri, per nostra fortuna, della facile satira politica, che conferma la supremazia di quei mezzi proprio mentre ne tenta lo smascheramento). Riempire le piazze con un monologo (per di più molto "tecnico" e molto poco divertente) significa certo saper investire il capitale comunicativo accumulato con l’esperienza televisiva, ma in questo caso significa anche rivendicare quella specificità del teatro che Paolini riesce a mantenere viva anche proprio mettendola continuamente alla prova nel confronto e nell’attraversamento mediatico anziché rinchiuderla nelle nicchie risentite o nelle torri d’avorio che costellano tanta parte del panorama teatrale contemporaneo.
FAQ-frequenze anti quiete a Sarzana
A cura di "Cut up" dal 20 al 30 novembre 2003 ore 17,30 e 21
di Redazione ateatro
FAQ nasce come progetto collettivo Cut up che raccoglie progetti di comunicazione alternativa e produzioni artistiche legate al comune denominatore della cultura in azione e della critica al mercato dell'arte.

Dalla letteratura di fantascienza e noir (Soriga, Caronia) al teatro attivista (passaggi dal teatro di strada del Living theatre al tactical media moviment del Critical art ensemble) al cinema underground (Brackhage, Burroughs, Jarman); dai videodocumentari politici (Giacomo Verde con S'era tutti sovversivi, e il collettivo Mijito film con Scarcerarci football club) alle telestreet (Incontro con Franco "Bifo" Berardi ) al fumetto e alla grafica undergroound (Chicco Aiello e Squaz): un passaggio tra generi e linguaggi e una discesa nell'inferno delle guerre mediatiche e delle "scene del conflitto."
Info: www.cut-up.net
La prima monografia sulla Valdoca
Teatro Valdoca a cura di Emanuela Dallagiovanna, Rubettino Editore, Soveria Mannelli (CZ), 2003
di Redazione ateatro
Sta arrivando in libreria la prima monografia dedicata al Teatro Valdoca. L’ha curata, per la collana «Teatro contemporaneo d’autore» dell’editore Rubbettino, Emanuela Dallagiovanna. Il volume ripercorre l’intera storia del gruppo fondato e diretto da Cesare Ronconi e Mariangela Gualtieri attraverso saggi critici (di Valentina Valentini, Oliviero Ponte di Pino, Luciana Rogozinski, Francesco Scarpelli), interviste e testimonianze, immagini, teatrografia, bibliografia & videografia. Sono 214 pagine a 11,00 euro.
Su ateatro è possibile leggere in anteprima il saggio Due foto tessera e alcune parole di troppo di Oliviero Ponte di Pino.
Un epitaffio per la Raffaello Sanzio?
Socíetas Raffaello Sanzio-Romeo Castellucci, Epitaph, Ubulibri, Milano, 2003
di Oliviero Ponte di Pino
Arriva in libreria Epitaph, una coedizione Ubulibri-Les Solitaires Intempestifs, ovvero un viaggio per immagini nel percorso della Socíetas Raffaello Sanzio curato da Romeo Castellucci (Ubulibri, 256 pagine, 29,00 euro, con brevi scritti introduttivi di Franco Quadri, Frie Leysen, Alan Read e Cristina Ventrucci in edizione bilingue italo-francese).
Dopo i testi di Epopea della polvere, uno dei libri di teatro più importanti di questi anni, questo Epitaph esplora l’aspetto visivo del lavoro della Socíetas Raffaello Sanzio, quasi a mettere in archivio e azzerare le precedenti fasi del lavoro del gruppo. La radicalità, la volontà di smontare e distruggere i meccanismi della comunicazione, del mito e dell’arte, la caparbietà nel cercare una bellezza che a volte può rivelarsi anche oltre l’orrore, stanno facendo del percorso della Socíetas una delle esperienze più interessanti e perturbanti di questi anni. In questa volontà estrema, il gruppo corre sempre sull’orlo del fallimento, sospinto dalla tentazione dell’estetismo e del sublime, in un formalismo abbacinante che offre una estrema speranza di redenzione; insieme, questo implica la coazione all’esplorazione di terre incognite dell’anima, alla provocazione contro i «luoghi comuni» e al tradimento come necessità vitale. Proprio nella compresenza di queste tensioni inconciliabili sta la dinamica che muove il gruppo, sempre alla ricerca di una potenza che permetta di attingere – ancora – ai territori dove il concetto, il linguaggio, il mito, la tragedia, in una parola la cultura, non si sono ancora cristallizzati ma mantengono un aurorale potere germinativo. Dove il perturbante abbia ancora la forza di farci vacillare.
Tra la maschera della morte e un’esplosione di energia cosmica, Epitaph il percorso della Socíetas, dagli spettacoli «iconoclasti» dei primi anni Ottanta fino a Genesi, che segna il punto di rottura e la chiusura di un intero ciclo di lavoro e apre alla nuove esperienza della Tragedia Edogonidia, che sta approdando in questi giorni a Roma, dove dal 21 al 30 novembre sarà in scena la settima tappa del percorso. E’ un itinerario nella memoria, che permette di rivivere le emozioni scatenate dalla visione degli spettacoli. A contrappunto delle fotografie degli spettacoli, Castellucci contrappone altre icone che hanno nutrito il lavoro del gruppo, in una sorta di «autocritica per immagini» (con alcune parole chiave incise come lapidi) che offre ulteriori squarci per interpretare questa sfida estrema di gnosticismo teatrale.
Epitaph diventa così anche un viaggio in un immaginario complesso e di grande impatto, dove il protagonista è un «corpo scolpito», in vari modi segnato, inciso, trasformato: da una ferita o da una amputazione, dall’anoressia o dall’obesità, dalla malattia, dalla chirurgia o da una menomazione... A essere messa in discussione, a creare significati, è ogni volta la differenza, lo scarto con l’idealizzazione del corpo e la sua presunta perfezione, l’esplorazione dei suoi limiti e confini, in una parola la ricerca di una verità del corpo che può nascere solo dallo scarto, dall’esperienza, dalla differenza. Questo «corpo segnato», feticcio crudele ed erotico, a sua volta sulla scena, inserito nella grammatica dello spettacolo, diventa segno – una icona che però porta dentro di sé la crudeltà della vita, dell’esistere. Lo troviamo contrapposto alla bellezza ottusa dell’animale o infine, in Genesi, alla bellezza innocente, insieme ancora animale e già umana, dell’infanzia.
E’ in questa dissezione dei confini del nostro corpo, fondato sul riconoscimento e insieme la distanza dall’Altro, che Epitaph offre il suo messaggio bello e devastante, tra orrore e speranza.
Altri testi sulla Socíetas Raffaello Sanzio in ateatro.it e olivieropdp.it
Una nuova lingua per miti vecchi e nuovi
intervista alla Societas Raffaello Sanzio
da Il nuovo teatro italiano 1975-1988. La ricerca dei gruppi: materiali e documenti, La casa Usher, Firenze, 1988
Lingue teatrali. Saggio di linguistica ipotetica e applicata con una Breve antologia della fantalingua
dal Patalogo otto, Annuario 1985 dello spettacolo, Ubulibri, Milano, 1985
(su Kaputt Nekropolis e la «Generalissima»)
Uomo, Dio, Animale (con frammenti da una conversazione con Romeo Castellucci della Societas Raffaello Sanzio)
da L'attore nell'epoca della sua riproducibilità tecnica in il Patalogo diciotto, Annuario 1995 dello spettacolo, Ubulibri, Milano, 1995
(sull’Orestea)
Per farla finita con il nome del padre
Alcuni appigli per scalare la Societas Raffaello Sanzio dopo vent’anni di spettacoli
(su Epopea della polvere, Ubulibri, Milano, 2001)
Una lettera a Antonio Moresco su Artaud, Hitler, la Socíetas Raffaello Sanzio (& altro)
in occasione della pubblicazione de L’invasione, Rizzoli, Milano, 2002
Le novità di novembre su dramma.it
Con il testo vincitore del premio "Vicini sconosciuti"
di www.dramma.it
Su www.dramma.it il dramma del mese è "La tattica del gatto" di Giovanni Clementi, vincitore del premio "Vicini sconosciuti" ed "Enrico Maria Salerno". E' stato rappresentato nel gennaio 2003 a Graz capitale europea della cultura 2003 al Theater im Keller con la regia di Alfred Haidacher. Se desiderate vedere un testo di Giovanni Clementi in scena, potete andare al Teatro Vittoria di Roma per vedere, fino al 23 novembre "Alcazar".
Il sito del mese è "Sceneggiatori.com" un sito dedicato interamente a chi scrive drammaturgia
per lo schermo.
Nell'agenda del Teatro delle Moline/TNE il calendario degli spettacoli ed i laboratori.
Nell'agenda dell'Associazione Teatrale Pistoiese in evidenza il progetto A Teatro con il Copit e le prevendite dei primi due spettacoli della stagione.
Nuovi argomenti di discussione nel forum, dove si è inaugurata una nuova stanza di discussione dedicata al Premio Riccione e dove si possono leggere gli interventi di alcuni dei finalisti.
Scaricabili dalla home page i bandi di prossima scadenza.
Nella sezione Drammaturgie :
Nello speciale sul premio Riccione l'articolo "Lasciate in pace i becchini" di Barbara Valli sulle tematiche dei copioni pervenuti al premio.
Un'intervista di Tiziano Fratus ad Antonio Tarantino
Un'intervista di Vincenzo Morvillo a Carlo Cerciello (Premio Ubu 2002)
Una lettera testimonianza sui pericoli dei Laboratori per attori professionisti
Tra le recensioni vi segnaliamo quelle a "Hotel de l'univers" l'ultima fatica di Enzo Moscato, "4.48 Psychosis" di Sarah Kane e "Frammenti di un discorso amoroso" drammaturgia di Rita Cirio.
Nello spazio dedicato alle Tesi di laurea e saggi la novità di Virginia Consoli "Ionesco: l'anarchia come creatività"
E poi non dimenticare i comunicati stampa, i cartelloni dei teatri, i link a centinaia di siti teatrali, scrivi una scena del copione interattivo, le segnalazioni per il dizionario dei drammaturghi del 900, le scuole di scrittura teatrale
Raiot, censurato dalla Rai, rivive in teatro
Domenica 23 a Roma e in tutta Italia una serata da non perdere
di Redazione ateatro
La seconda puntata di RAIOT, la tramissione di Sabina Guzzanti che Raitre non manderà in onda, verrà trasmessa in diretta all'Auditorium di Roma domenica 23 novembre alle 20.30 nella sala grande da 2.500 posti.
Nella Cavea esterna verrà installato un maxi schermo per consentire una larghissima partecipazione di pubblico.
Verrà proiettata la seconda puntata della trasmissione sospesa dalla decisione del CdA Rai.
Il "varietà" di protesta" che Sabina Guzzanti sta allestendo per domenica sera all'Auditorium di Roma uscirà dalle pur ampie sale del Parco della Musica, perché l'intera serata sarà proiettata in diretta in diversi teatri italiani: la produzione ha accolto l'opportunità di sfruttare le strutture satellitari messe a disposizione da Emili.Tv (cliccare qui per info sulla trasmissione di domenica), visibile nel pacchetto Sky al canale 855 o con il decoder free.
Allo show parteciperanno, oltre all'attrice, il fratello Corrado Guzzanti, Daniele Luttazzi e Dario Fo con un contributo video, Paolo Rossi, Serena Dandini, Fiorella Mannoia, Nicola Piovani, Francesco Paolantoni, Neri Marcore, Marco Marzocca, Sabrina Impacciatore, David Riondino, Rosalia Porcaro, Stefano Vigilante, Max Paiella, Corinna Lo Castro, Roberto Herlitzka, Francesca Reggiani.
L'associazione Shining anticiperà le spese per lo spettacolo, che verranno poi coperte dalla libera sottoscrizione degli spettatori. L'ingresso sarà fino ad esaurimento posti, mentre all'esterno dell'Auditorium sarà allestito un maxi schermo.
Firenze, Napoli, Bologna, Lecce, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Ravenna, Milano, Varese, Marsala, Pescara, Napoli e Torino sono le prime città che si stanno mobilitando in queste ore per trasmettere il varietà, aderendo all'iniziativa "Non censureRai" lanciata dai siti internet igirotondi.it e centomovimenti.it, che hanno ricevuto 12.000 adesioni in poco tempo.
Invitiamo tutti coloro che sono interessati ad attivarsi per riempire teatri, palasport, case del popolo, circoli privati e locali.
"Sono molto determinata ad andare fino in fondo e a protestare finché campo per questa vicenda" ha dichiarato oggi Sabina Guzzanti. "E' un precedente gravissimo per la libertà d'espressione".
Sull'intenzione della Rai di visionare tutte le puntate prima di mandarle in onda, Sabina sorride: "E' come se chiedessero ai giornalisti di scrivere il giornale di oggi per pubblicarlo tra un mese. Non credo che lo comprerebbero in molti. E fra l'altro registrare tutte le puntate prima della messa in onda non è in accordo con il contratto".
Altre info & pareri sul forum di ateatro.
Questa sera (sabato 22) a L'infedele, la trasmissione della 7 condotta da Gad Lerner (ore 20.45), parleranno della censura a Raiot (e della sentenza Previti) tra gli altri il professor Franco Cordero, Marco Travaglio, Sabina Guzzanti, Curzio Maltese, Renato Farina e Yasha Reibman.
Se volete saperne di più sulla censura radiofonica e televisiva, leggete il saggio di Menico Caroli, Proibitissimo! Censori e censurati nella radiotelevisone italiana.
Che cos'è il Dramaturg e perché in Italia non esiste?
"Walkie Talkie" ne discute a Milano
di Teatro Aperto
Si terrà tra il 28 e il 30 novembre a Milano, presso la Civica Scuola d'Arte Drammatica, "Walkie Talkie. Incontri fra testo e scena" a cura di Teatro Aperto. Il tema degli incontri è il Dramaturg, una figura che nel teatro italiano fatica ad attecchire. Qui di seguito il comunicato stampa della manifestazione.
In sintonia con l’attenzione che ha sempre mostrato nei confronti della drammaturgia contemporanea Teatro Aperto propone un’indagine pluriennale intorno al rapporto tra testo e scena articolata secondo focus specifici che annualmente approfondiscano un nodo di questo intricato e stimolante rapporto.
Questo progetto vuole essere l’occasione per far confrontare e scontrare diverse e altrettanto importanti scritture per il teatro e intende distillare materiali, pensieri, tensioni.
Far sedere intorno a un tavolo chi scrive e chi mette in scena le parole. Far dialogare diverse generazioni. Viaggiare tra Italia e Europa.
L’indagine di quest’anno fa luce sul delicato ruolo del Dramaturg, figura di spicco del teatro europeo, link tra testo e attore, testo e regia, testo e spettatore.
Abbiamo invitato il Dramaturg della Schaubühne di Berlino a confrontarsi con alcuni dei più significativi tra i nostri registi, attori, drammaturghi, narratori, nella poliedricità dei loro ruoli e vocazioni.
Le giornate di lavoro si svolgeranno su base teorica attraverso il coordinamento di tre attenti osservatori della realtà teatrale italiana. Si approfondirà il confronto con questioni e dispute, grazie ad artisti e teorici “provocatori” chiamati a porre questioni agli ospiti, insieme a un auditorio attivo di studenti dei corsi di drammaturgia e regia.
Gli spunti e le riflessioni verranno raccolti e organizzati, come da tradizione del gruppo, per un’apposita pubblicazione (e naturalmente su "ateatro").
Interverranno al convegno:
Coordinatori
Renata Molinari, Oliviero Ponte di Pino, Massimo Navone
Ospiti
Jens Hillje, Sandro Lombardi, Marco Martinelli, Enzo Moscato, Antonio Tarantino, Ferdinando Bruni, Ettore Capriolo, Tiziano Fratus,
Giuseppe Di Leva, Roberto Traverso, Claudio Meldolesi
Provocatori
Andrea Balzola, Fabio Bruschi, Antonio Calbi, Ettore Capriolo,
Sara Chiappori, Concetta D’Angeli, Renato Gabrielli, Marcello Isidori, Helena Janeczek,
Roberto Menin, Antonio Moresco, Mario Raimondo, Roberto Traverso
Auditorio attivo
Studenti dei corsi di Drammaturgia e Regia - Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi
Studenti del corso di Drammaturgia teorica - Università degli Studi di Milano.
A cura di
Elena Cerasetti, Federica Fracassi, Renzo Martinelli
Con la preziosa collaborazione di
Renata Molinari, Oliviero Ponte di Pino
Organizzazione
Teatro Aperto: Gianni Munizza, ChiaraTrezzani
Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi: Massimo Navone, Rossana Valsecchi
INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE presso
Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi 02-58302813
PER INFORMAZIONI:
Teatro Aperto, tel.fax. 02-58319484
teatroaperto@yahoo.it; Regione Lombardia – Culture, Identità e Autonomie della Lombardia www.lombardiacultura.it
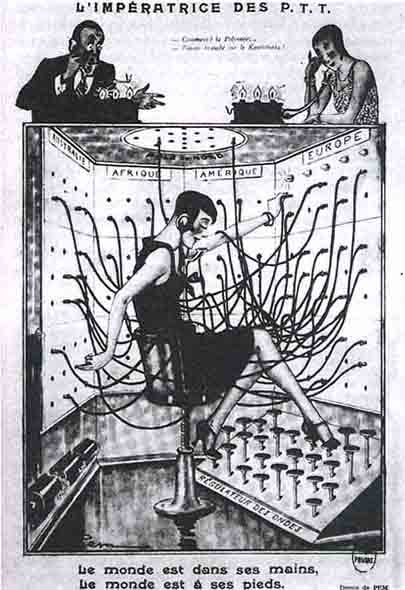
Il programma
28-29-30 NOVEMBRE 2003
ore 10.00-18.00
WALKIE-TALKIE
INCONTRI FRA TESTO E SCENA
2003
IL DRAMATURG
Un'idea di
TEATRO APERTO
Con il contributo di
Regione Lombardia
Culture, Identità e Autonomie della Lombardia
In collaborazione con
Scuola d'Arte Drammatica "Paolo Grassi"
Venerdì 28 Novembre
Chi è il Dramaturg
Coordinatrice
Renata Molinari
Ospite
Jens Hillje
Dramaturg alla Schaubühne di Berlino
Sabato 29 Novembre
Chi fa il Dramaturg in Italia
Coordinatore
Oliviero Ponte di Pino
Ospiti
Sandro Lombardi
Marco Martinelli
Enzo Moscato
Antonio Tarantino
Domenica 30 novembre
Dramaturg e formazione
Coordinatore
Massimo Navone
Ospiti
Ferdinando Bruni
Ettore Capriolo
Giuseppe di Leva
Tiziano Fratus
Roberto Traverso
Un concorso di idee per Alfieri
Il comunicato e il bando
di Commissione Artistica di AstiTeatro 26
Dopo il rilancio dello scorso anno, il Festival AstiTeatro conferma per il 2004 la propria missione: scoperte e riscoperte nell'ambito della drammaturgia. Si tratta di presentare al pubblico nuovi autori, italiani e internazionali, ma anche di sollecitare diversi spazi e diverse direzioni di pensiero drammaturgico.
Con quest'ultima aspettativa, AstiTeatro 26 bandisce fin d'ora un CONCORSO DI IDEE che vuole incentivare una giovane generazione d'artisti alla scrittura per il teatro, e al tempo stesso intende diffondere la drammaturgia e la poetica teatrale del suo più illustre concittadino, Vittorio Alfieri.
IDEE PER ALFIERI è un concorso di idee rivolto a nuovi giovani drammaturghi (l'età limite è 35 anni), affinché sviluppino un lavoro contemporaneo di invenzione attorno alle opere e alla personalità dello scrittore astigiano. I testi, ma anche le vicende biografiche alfieriane, o la sua fortuna teatrale, potranno essere oggetto di un'elaborazione drammaturgica, da realizzare con i più recenti linguaggi delle arti performative o con le più semplici e essenziali forme dell'arte scenica. In entrambi i casi LE IDEE PER ALFIERI, progetti per spettacoli da fare, verranno esaminati e selezionati dalla Commissione artistica di AstiTeatro, che offrirà a quelli più interessanti e più originali la possibilità di trasformarsi in dimostrazioni sceniche, da presentare a giugno, nel corso dell'edizione 2004 del Festival, e di diventare, se ce ne sarà ragione e opportunità, una produzione vera e propria.
Il CONCORSO DI IDEE offre a tutti, anche a chi non dispone di risorse produttive, la possibilità di veder valutate le proprie idee e la propria iniziativa progettuale. La formula, pensata in due fasi - PROGETTO SCRITTO e DEMO - permette inoltre di verificare la realizzabilità dei progetti.
La commissione artistica di AstiTeatro 26
Eugenio Guglielminetti,
Roberto Canziani, Mimma Gallina, Mario Mattia Giorgetti, Salvatore Leto
Il bando
AstiTeatro 26
IDEE PER ALFIERI
Bando di concorso
Il Festival AstiTeatro bandisce per il 2004 un CONCORSO DI IDEE intitolato IDEE PER ALFIERI. L’iniziativa si propone di valorizzare il lavoro di progettazione drammaturgica e spettacolare, e sviluppare nello stesso tempo la conoscenza e la diffusione delle opere e della biografia di Vittorio Alfieri presso una nuova generazione di artisti teatrali.
Al concorso di idee possono partecipare tutti i progetti originali di spettacoli dal vivo che abbiano come tema privilegiato i testi e/o le vicende biografiche alfieriane. Ogni progetto potrà trattare liberamente i materiali individuati, ma deve essere finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo. Sono ammessi progetti individuali o di gruppo, in entrambi i casi l’età di chi presenta il progetto non può superare i 35 anni (sono ammessi tutti i nati dopo l’1/1/1968).
Entro il mese di dicembre 2003, il Festival AstiTeatro organizzerà tre incontri - uno presso l’Accademia Nazionale "Silvio D’Amico" di Roma, uno presso la Civica Scuola "Paolo Grassi" di Milano e uno presso la Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Torino - utili a presentare pubblicamente il concorso e ad introdurre, con una lezione di drammaturgia alfieriana, il contesto dell’iniziativa.
4. Il concorso si articola in due fasi: PROPOSTA di progetto e DEMO di progetto.
- La PROPOSTA consiste in un documento scritto, della lunghezza massima di 10 cartelle e corredato eventualmente da illustrazioni, nel quale viene definito e dettagliato il progetto di uno spettacolo che abbia le caratteristiche indicate nel precedente punto 2. La Commissione artistica analizzerà le proposte di progetto per valutare quelle meritevoli di passare alla fase di DEMO. La selezione verrà resa pubblica il 2/2/2004.
- Il DEMO consiste in un evento dal vivo, della durata massima di 20 minuti, durante il quale vengono messi in scena una parte, o una sintesi del previsto spettacolo, in forma dimostrativa, o di trailer di scena, da presentare nella Sala Pastrone del Teatro Alfieri di Asti. I DEMO possono utilizzare liberamente qualsiasi linguaggio, tecnica e materiale espressivo; l’utilizzo di particolari tecnologie e spazi diversi dalla Sala Pastrone è ammesso, ma subordinato alle effettive disponibilità. I DEMO saranno presentati al pubblico nel corso del Festival AstiTeatro 26.
5. L’apporto finanziario del Festival AstiTeatro per la realizzazione dei singoli DEMO sarà definito sulla base delle caratteristiche dei progetti e del numero delle proposte selezionate.
6. Le PROPOSTE, accompagnate dalla SCHEDA DI PARTECIPAZIONE e da un CURRICULUM professionale, devono pervenire alla Commissione artistica di AstiTeatro entro il 15 gennaio 2004 secondo una delle seguenti modalità (farà fede il timbro postale o la data di ricezione):
in forma cartacea (6 copie della lunghezza massima ciascuna di 10 cartelle più eventuali illustrazioni) all’indirizzo:
“CONCORSO IDEE PER ALFIERI”
TEATRO ALFIERI
VIA AL TEATRO, 2
14100 ASTI
tramite posta elettronica (file allegato in formato .rtf, eventualmente .pdf, di dimensione non superiore ad 1 Mbyte) all’indirizzo ideeperalfieri@comune.asti.it, riportando nell’oggetto della e-mail la dicitura “Idee per Alfieri”.
Ulteriori informazione verranno rese disponibili sul sito www.comune.asti.it o contattando gli uffici del Teatro Alfieri al numero 0141 -399035 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13
martedì e giovedì: dalle 16 alle 17,30.
Nuovo teatro e nuovi autori: se ne discute a Riccione
Il 13 dicembre l'incontro "Per un teatro d’autore. Progetto e nuove prospettive per il Premio Riccione"
di Riccione Teatro - Fabio Bruschi
Il 3 e 4 dicembre del 1983, vent’anni fa giusti, il Premio Riccione affidava a Franco Quadri il rilancio delle proprie iniziative con l’incontro nazionale Per un teatro d’autore. Progetto e nuove prospettive per il Premio Riccione.
Nel suo contributo scritto Eduardo De Filippo ci scriveva: "Organizzare attorno al Premio Riccione un centro di attività permanente mi sembra utile e importante; altrettanto utile e importante è che queste attività non si cristallizzino in schemi fissi ma cambino col cambiare della realtà intorno a noi". E proseguiva affermando che se "è essenziale non lasciarsi rimorchiare nella vita in genere", a maggior ragione "la creazione artistica e la sua gestione devono contenere quel tanto di profetico che rende tempestivi e utili l’opera d’arte e l’iniziativa artistica".
A distanza di vent’anni che hanno coinciso con un ciclo importante del teatro italiano, o meglio della parte viva di questo, che include la nuova drammaturgia, ci diamo appuntamento di nuovo a Riccione per un incontro che – a differenza di quello dell’ ’83 – vuole essere più agile e informale.
Abbiamo invitato autori, critici, operatori, registi, studiosi che conoscono più da vicino il Premio e le altre attività complementari a questo, contenute nella proposta Quadri dell’ ’83: il TTV Festival, gli archivi e la videoteca, l’attività di informazione.
Quella proposta conteneva anche il progetto di una "Settimana del teatro d’autore", per realizzare la quale, nella diversa forma de "La stagione del Premio", sono occorsi giusto vent’anni: all’interno di questa rassegna - che presenta undici autori premiati dal Riccione o dal Tondelli tra il 1985 e il 2003 - si colloca l’incontro Nuovo teatro e nuovi autori.
Non parleremo di tematiche certamente importanti quali leggi, norme, regolamenti e quant’altro, per le quali altre sedi sono più utili e opportune, né insisteremo sui numerosi elementi di doglianza.
Cercheremo di capire invece dove siamo oggi; cosa ci è possibile fare contando sulle nostre forze, in rapporto con altre realtà teatrali, alleate in potenza o in atto; in che rapporto stanno oggi tra loro il teatro che lavora sulla drammaturgia della parola e il teatro dei gruppi; quali linee di sviluppo si possono – in questo contesto – proporre al Premio, ricordando l’invito di Eduardo a non cristallizzarci in schemi fissi, a cambiare con la realtà circostante, e – difficilissimo! – a non andare a rimorchio ma proporre quel tanto di profetico di cui sopra.
Riccione, 14 novembre 2003
Il direttore di Riccione Teatro
Fabio Bruschi
A oggi hanno aderito: Franco Quadri, Andrea Nanni, Massimo Marino, Gerardo Guccini, Gilberto Santini, Oliviero Ponte di Pino, Luca Scarlini, Fausto Paravidino, Letizia Russo, Maroly Lettoli, Fabio Bruschi, Silvio Castiglioni, Motus e altri autori, critici, registi, operatori teatrali.
Riccione, Palazzo del Turismo, sabato 13 dicembre 2003, ore 15 – 19
Per altre info, adesioni
lastagionedelpremio@riccioneteatro.it
Vi ricordiamno anche che sul sito www.dramma.it è attivo un forum sul Premio Riccione.
Che succede alla Biennale?
Appunti a margine
di Oliviero Ponte di Pino
Che succede alla Biennale? Intanto, se volete qualche info, nei forum di ateatro ci sono materiali utili per orientarsi. Ma il problema non riguarda solo la prestigiosa rassegna veneziana e il suo boccone più ghiotto, il Festival del Cinema. Molte grandi istituzioni culturali del nostro paese attraversano una fase difficile. I segnali sono numerosi. Dalla baruffe scaligere tra Sandro Fontana e Riccardo Muti (con Fedele Confalonieri pronto ad assumere la barra del timone) alla stasi del Piccolo Teatro (e in genere allo stallo pluridecennale del teatro pubblico), dal tracollo dei Festival dei Due Mondi a Spoleto all’involuzione bottegaia e regressiva dell’Eti, passando magari per due enti coinvolti nella gestione della Biennale, la Quadriennale romana e la Triennale milanese (dove la nomina del presidente Davide Rampello è stata al centro di una umiliante bega). Senza naturalmente dimenticare la più importante azienda culturale del paese, la Rai. Che in queste settimane la televisione pubblica si sia rilanciata grazie all’Isola del famosi e ai quiz digestivi di Bonolis rientra perfettamente in questa logica.
La crisi non risparmia neppure realtà più piccole e militanti, alle prese con la cronica mancanza di risorse e la difficoltà a rilanciare la propria progettualità.
E’ una situazione che riguarda, più in generale, il triste stato della cultura e dei beni culturali in Italia. E’ il frutto dell’inguaribile provincialismo di un paese troppo concentrato su se stesso e sulle proprie beghe. E’ il frutto di clientelismi e mafiette di basso profilo. E’ il frutto dell’asservimento alle logiche della spartizione politica, con l’aggravante del maggioritario e di una maggioranza arraffatutto (una destra che in realtà per la cultura ha scarso interesse e che spesso si muove in una logica rancorosamente punitiva). E’ il frutto della progressivo diminuire delle risorse destinate alla cultura. E’ il frutto di una intimidazione censoria che passa attraverso censure esplicite e implicite (ricatto economico, querele miliardarie, silenzi).
In questo scenario, gli allarmi e i gridi di dolore servono solo a placare la propria coscienza. Purtroppo resta l’unica pratica possibile. Infatti i velleitari tentativi di reazione della società civile della cultura e le risposte delle forze politiche della sinistra restano impercettibili e inefficaci. Resta la buona volontà di tante persone di buona volontà, sospinte sempre più verso i margini e una stentata sopravvivenza...
I vincitori dei Premi Ubu 2003
La premiazione lunedì 1 dicembre al Piccolo Teatro di Milano
di Redazione ateatro
I Premi Ubu per la stagione 2002-2003, promossi dall’annuario del teatro Il Patalogo, edito da Ubulibri e da anni considerati i più importanti premi del teatro italiano votati dalla critica, sono stati consegnati per la ventiseiesima volta a Milano, lunedì 1 dicembre, alle ore 18.00, amichevolmente ospitati nella storica sede del Piccolo Teatro, la sala Paolo Grassi in via Rovello 2, col patrocinio del Comune di Milano.
Qui sotto le nominations e (in neretto) i vincitori, scelti da una giuria di 57 critici tramite referendum & ballottaggio.
Spettacolo dell’anno
Sabato, domenica e lunedì di Eduardo De Filippo (Toni Servillo, Teatri Uniti)
Le Metamorfosi da Ovidio (Giorgio Barberio Corsetti)
Fabbrica di e con Ascanio Celestini
Opera da tre soldi da Bertolt Brecht (Armando Punzo, Compagnia della Fortezza)
Regia
Toni Servillo (Sabato, domenica e lunedì)
Giorgio Barberio Corsetti (Le Metamorfosi)
Antonio Latella (Querelle)
Scenografia
Daniela Dal Cin (Bersaglio su Molly Bloom)
Marco Rossi (Amor nello specchio)
Margherita Palli (Prometeo)
Paolo Tommasi (La storia immortale)
Attore
Carlo Cecchi (La storia immortale)
Ferdinando Bruni (sdisOrè)
Roberto Herlitzka (La Mostra)
Toni Servillo (Sabato, domenica e lunedì)
Attrice
Anna Bonaiuto (Sabato, domenica e lunedì)
Barbara Valmorin (Vecchie)
Mariangela Melato (Amor nello specchio)
Attore non protagonista
Francesco Silvestri (Sabato, domenica e lunedì)
Nello Mascia (Miseria e nobiltà)
Roberto Sturno (Volpone)
Attrice non protagonista
Lucia Ragni (Lamìa)
Manuela Mandracchia (Amor nello specchio)
Gianna Piaz (La nemica)
Pia Lanciotti (Pentesilea e Riccardo III)
Nuovo attore o attrice (under30)
Manuela Lo Sicco
Claudia Coli
Marco Foschi
Migliore novità italiana
(o ricerca drammaturgica)
Tomba di cani di Letizia Russo
Carnezzeria di Emma Dante
Bellissima Maria di Roberto Cavosi
Vendutissimi di Renato Gabrielli
Migliore novità straniera
Cara professoressa di Ljudmila Razumovskaja
Io sono il maestro di Hrafnhildur Hagalín Gudmunsdottir
La brigata dei cacciatori di Thomas Bernhard
CLOSER + vicini di Patrick Marber
Migliore spettacolo di teatro-danza
Il migliore dei mondi possibili di Roberto Castello
non assegnato
Migliore spettacolo straniero
presentato in Italia
Woyzeck di Georg Büchner (Robert Wilson, Betty Nansen Teatret,
Copenaghen)
After Sun di Rodrigo García (Rodrigo García, La Carniceria Teatro, Spagna)
The Far Side of the Moon (La face cachée de la lune) (Robert Lepage, Ex-Machina, Québec City)
Segnalazioni per premi speciali
Iliade di Teatrino Clandestino per la commistione dei linguaggi.
Davide Enia per la nascita di un nuovo cantastorie.
Sacchi di sabbia (Orfeo) per il loro intreccio di ironia, storia e metafisica.
Una collana di libri dedicati alle fotografie di Tommaso Le Pera
Si parte con il volume dedicato agli spettacoli pirandelliani
di Redazione ateatro
Inizia con un primo volume su Pirandello e proseguirà con altri autori, da Shakespeare, Goldoni, Molière, Cèchov, Brecht, Ionesco, Beckett, Genet, Pinter a Eduardo, la collana edita da Guido Talarico Editore che presenta centinaia di foto di teatro d’autore eseguite da Tommaso Le Pera, da molti anni il fotografo per eccellenza del teatro italiano.

Mariangela Melato.
Al lavoro di Tommaso Le Pera sono state dedicate molte mostre e altre pubblicazioni, la particolarità di questa nuova collana consiste nel fatto di documentare, attraverso le immagini del fotografo come e da chi sono stati realizzati e rappresentati gli spettacoli più importanti di ciascun autore in Italia: un documento preziosissimo per il nostro teatro che può disporre soltanto delle foto di scena a memoria del lavoro di registi, attori, scenografi e costumisti, spesso tra loro molto diversi per stile e lettura dello stesso testo e autore.

Monica Guerritore e Gabriele Lavia.
L’ eccezionalità del lavoro di Tommaso Le Pera consiste anche nell’aver documentato, non solo gli spettacoli che gli venivano di volta in volta affidati, ma anche altre produzioni di particolare interesse che sono andate ad arricchire il suo archivio composto da oltre 4000 spettacoli realizzati nell’arco di 35 anni nei maggiori teatri e festival italiani e stranieri.

Paolo Stoppa.
Nel primo volume dedicato a Pirandello sono presenti 33 titoli del grande autore tra cui quelli realizzati da Eduardo De Filippo, Giorgio De Lullo, Franco Zeffirelli, Giancarlo Sbragia, Antonio Calenda, Mariano Rigillo, Giancarlo Sepe, Massimo Castri, Vittorio Gassman, Giuseppe Patroni Griffi, Gabriele Lavia, Mario Missiroli, Carlo Quartucci, Leo De Berardinis, Mauro Bolognini, Luca De Fusco, Alvaro Piccardi, Marco Bernardi, Marco Mattolini etc, fino al recente Come tu mi vuoi di Pasquale Squitieri, protagonista Claudia Cardinale.
Sono quasi duemila gli artisti, tra scenografi, costumisti, attori, musicisti e tecnici vari coinvolti in queste produzioni e documentati sulle relative locandine che accompagnano ciascuno spettacolo.
Il primo volume sugli spettacoli pirandelliani sarà in distribuzione dal 15 dicembre nelle principali librerie.
